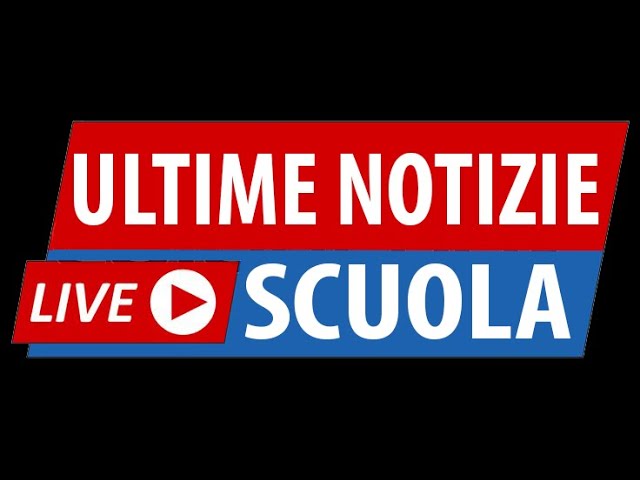Di seguito riportiamo la testimonianza, pubblicata da Libreriamo, di un’insegnante italiana a New York, Alessandra Pavan, di quel tragico giorno, quel momento che ha segnato la storia contemporanea.
New York 11 settembre 2001: Mi ricordo un cielo incredibilmente terso. Ero arrivata da qualche giorno per insegnare in una scuola pubblica: tramite un’inserzione “civetta” sul Corriere e conseguente colloquio, il New York Board of Education aveva assunto un gruppo di docenti italiani da assegnare – ma nessuno lo sapeva- nei sobborghi più difficili dove i colleghi americani non volevano andare. L’anno scolastico era appena iniziato e stavo cercando di capire i meccanismi della mia nuova scuola situata a Throgs neck nel Bronx, un ‘area a forte immigrazione italo-irlandese, ma con nuovi arrivi soprattutto portoricani. Il classico melting – pot americano insomma, ma ancora in fase di rodaggio in quanto ad inclusione. Così dal mio remoto e tranquillo Friuli mi ritrovai catapultata in un mondo complesso e turbolento.
Anche se lontana da Lower Manhattan, per quella strana conformazione ondulata di New York, dalle finestre della scuola si poteva vedere Downtown nelle giornate, come quell’11 settembre, terse e senza nuvole. Ero nella classe “special education” e perciò c’erano due assistenti – una sorta di insegnanti di sostegno – a gestire i casi difficili che nelle classi “special” in Usa sono tutti assieme. Le assistenti erano spesso al telefono e non vi prestavo particolare attenzione, ma quel giorno continuavano a ripetere “hijacked, hijacked” con le lacrime agli occhi e, anche senza dizionario, ho compreso subito cosa volessero dire. Poi lo sguardo verso le finestre, lontano ma non troppo, il fumo a sporcare il cielo settembrino.
Il tempo di una brevissima telefonata in Italia e poi un lunghissimo black out: non funzionava più niente. Si sentivano solo le voci dei colleghi che bisbigliavano per non spaventare i bambini – ero in una scuola elementare – e che invitavano a continuare fino alla fine delle lezioni, come al solito. Ma, diversamente dal solito, molti genitori non vennero all’orario consueto a prendere i figli, alcuni non vennero affatto: erano pompieri impegnati in quello che sarebbe divenuto Ground Zero. In qualche modo arrivammo alla fine della giornata di scuola, con notizie confuse che io, con il mio inglese ancora malcerto, ancora non capivo fino in fondo. E poi l’invito ad andare a casa in fretta e a seguire gli aggiornamenti alla Tv, visto che non funzionavano i telefoni e così, sulla via di casa, una via spettralmente deserta ed assolata, mi ritrovai ad acquistare un televisore, unico mezzo di contatto con la realtà.
Seguirono giorni destabilizzanti senza la possibilità di comunicare con nessuno se non con le room mates incontrate pochi giorni prima e con cui mi trovai a condividere l’orrore del fumo acre che proveniva da Lower Manhattan, la solitudine forzata, l’incertezza del domani. Poi il ritorno a scuola, – un 13 settembre surreale – con un team di psicologi a consigliare di andare da estetista e parrucchiera: servivano colori dicevano. Poi ci spinsero a far disegnare ai bambini, in modo ossessivo, gli eroi del tempo: i pompieri, in azione, morti, vivi e bandiere americane dovunque.
Per il gruppo dei docenti italiani venne approntato un pool apposito, con l’invito pressante a share, a condividere la paura e le emozioni provate. In realtà non riuscimmo a parlarne: tra di noi ci eravamo appena conosciuti e nei due anni successivi in cui rimasi a New York si mantenne una sorta di ritrosia, una rinnovata angoscia, nell’affrontare il tema. Lo facciamo solo in questi giorni e metaforicamente, a vent’anni di distanza, chi è rimasto lì e chi è tornato come me, attraverso un ricordo comune: il cielo azzurro, il fumo acre e il grido “hjjacked”.