
Molte volte il ministro Valditara ha dichiarato di voler ridare dignità ai lavoratori della scuola. Siamo d’accordo con lui, ma lo invitiamo a riflettere che la dignità di un lavoratore la si deve tutelare in vari modi. Se dovessimo attenerci alla Carta Costituzionale – ma è evidente che i governi che si sono susseguiti dagli anni Novanta in avanti hanno considerato la Costituzione una sorta di dichiarazione di intenti non vincolante, piuttosto che la legge fondamentale della Repubblica italiana – se dovessimo attenerci alla Costituzione, dunque, un lavoratore dovrebbe percepire “una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” (art. 36).
Abbiamo i salari più bassi rispetto agli altri Paesi dell’area OCSE, ma questa “bomba” si è trasformata in una notizia innocua, buona per apparire ciclicamente sui giornali. Il Sole24Ore a dicembre 2023 riportava la seguente informazione, tratta dal Rapporto Inapp: “Tra il 1991 e il 2022 i salari reali in Italia sono rimasti sostanzialmente al palo con una crescita dell’1% a fronte del 32,5% in media registrato nell’area Ocse.” Gli stessi dati OCSE spostando di poco il cursore temporale (1992-2022) davano l’Italia ultima tra i 27 Paesi dell’area, l’unica con un segno negativo (-2,9%).
E dov’è finito il rispetto del dettato costituzionale in termini di reddito, chiederebbe Candide? Che poi i lavoratori, dopo aver sopportato anni di lavoro precario – altra piaga che, dagli anni Novanta, ha afflitto la nostra società – e lunghi decenni di lavoro malpagato se ne vadano in pensione alle soglie della vecchiaia è un altro problema serio. Però accreditati economisti ci hanno variamente spiegato che l’aumento dell’età pensionabile non è in alcuna relazione con la disoccupazione giovanile e il precariato prolungato; con buona pace dell’articolo 4, secondo il quale “la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”.
Veniamo a qualcosa di più circoscritto, ad uno di quegli argomenti di cui neppure si dovrebbe parlare in uno Stato appena più giusto di quello in cui viviamo. Torniamo, perciò, alle “notizie cicliche”, che periodicamente ricompaiono e che forse, anche per questo, non colpiscono più nessuno. Come si sa, i dipendenti pubblici che approdano alla pensione subiscono una vera e propria ingiustizia. In base ai soliti provvedimenti fatti in tempi “emergenziali”, in un passato ormai abbastanza lontano, un signore con il loden ed una signora dalla lacrima facile stabilirono che la pacchia era finita e che tutti dovevano fare sacrifici (loro no; ai tempi Mario Monti, osannato salvatore della Patria, dichiarava un milione di euro di reddito annuo).
Tali sacrifici si concretarono, come già detto, nell’allungamento medio di sette anni dell’età pensionabile (una bazzecola) e, per i dipendenti pubblici, con un blocco del pagamento del TFR/TFS che, tranne i casi della pensione di vecchiaia, sarebbe stato corrisposto loro in tre tranche (la prima e la seconda sino a 50.000 euro), la prima delle quali versata dopo 24 mesi+3 (i tre mesi se li riserva l’INPS per elaborare la pratica; si vede che due anni sono pochi e non bastano).
Non sono bastate le proteste e i pronunciamenti della Consulta, l’ultimo dei quali del 23 giugno dello scorso anno (sentenza 130/2023), esorta il governo ad intervenire per risolvere questo vulnus, la cui incostituzionalità è palese; non è bastato nemmeno che il Consiglio di indirizzo e vigilanza ( Civ ) dell’Inps abbia segnalato il fatto che i molti ritardi (ben superiori ai 27 mesi canonici) siano dovuti soprattutto a endemica carenza di personale. Adesso giunge un’altra notizia “nuova”: dal 25 aprile l’Inps ha chiuso il canale telematico per l’invio delle “domande anticipazione ordinaria trattamento di fine servizio (Tfs) o trattamento di fine rapporto (Tfr)”, che permetteva ai pensionati iscritti al fondo credito (ex Inpdap) di ricevere la buonuscita (Tfs/Tfr) prima dei tempi ordinari di erogazione.
La causa, manco a dirlo, è la scarsità dei fondi disponibili per il 2024; teniamo conto che l’ “anticipo” è, a tutti gli effetti, un prestito a tasso agevolato (1% e 0,50% per le spese di gestione), per cui, anche se appare paradossale, il pensionato paga, magari poco, per avere prima soldi suoi.
Ma anche in questo modo non ha funzionato: la Ragioneria dello Stato ha messo in rilievo che abbreviare i tempi di erogazione e modificare la rateizzazione a favore del pensionato determinerebbe “effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in particolar modo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, privi di copertura”. Ancora una volta i dipendenti pubblici vengono bistrattati. In Italia il lavoro dipendente è svilito dalle basse retribuzioni e, in particolare, il lavoro pubblico ha dovuto subire l’affronto di un blocco contrattuale di quasi dieci anni, conclusosi con un rinnovo contrattuale del 3,48!
E da allora, era il 2018, le cose non sono andate molto meglio. Che dopo più di quarant’anni di lavoro si debba attendere a lungo per avere la propria liquidazione è un vero e proprio affronto; che la liquidazione non la possa ottenere nemmeno chi è disposto a pagare per abbreviare i tempi suona a vergogna di chi amministra e di chi governa la cosa pubblica.




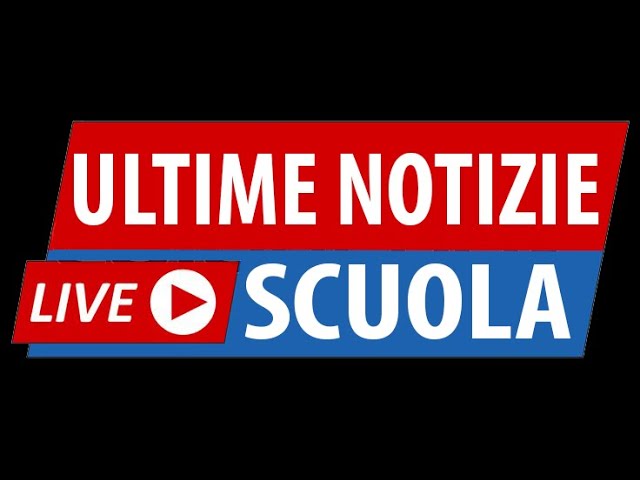
![Alunni stranieri, in arrivo risorse per il potenziamento della lingua italiana nelle classi con il 20% di nuovi arrivi [DECRETO] Piano estate](https://www.tecnicadellascuola.it/wp-content/uploads/2017/10/bambini_scuola_corano-e1507284985704-238x178.jpg)

