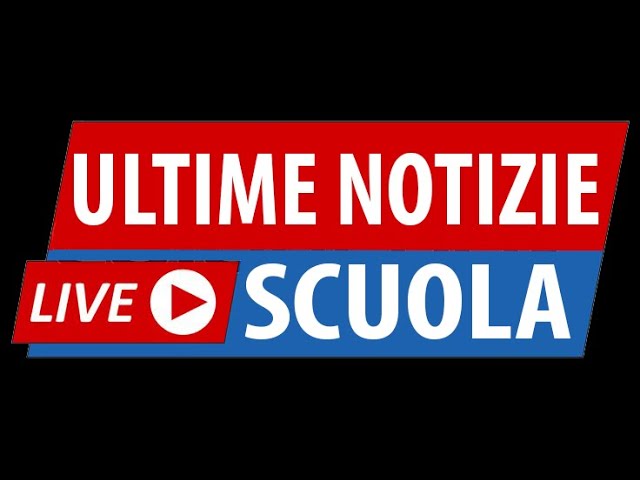Gentile redazione,
ogni anno, in occasione dell’esame di Stato al termine della scuola secondaria di secondo grado, sono in molti a interrogarsi sull’opportunità di tale prova per definire il “verdetto” finale. Personalmente ho da tempo risolto il dubbio: per come è configurato e, in particolare, per il peso che gli viene attribuito, l’esame di Stato è privo di senso e, anzi, costituisce finanche un oltraggio allo stesso buon senso. Un’opinione come tante, si dirà. Sarà. Però trova un supporto nella matematica. Come può, infatti, un esame costituito da tre prove – due scritti e un colloquio – pesare per 60 punti su 100 complessivi? Quale ragionamento può portare a mantenere ciò che non solo ad una prima evidenza, ma anche ad una più approfondita riflessione, appare come un paradosso?
La matematica, si diceva. Già, la matematica. Che c’entra? Consideriamo solo il triennio e stimiamo, in modo spannometrico e prudenziale, il numero di valutazioni che ogni alunno ha ottenuto complessivamente dal suo gruppo di insegnanti: al netto della variabilità tra una scuola e l’altra e tra un indirizzo e l’altro, conseguente al mutare del numero delle discipline, si può tranquillamente ipotizzare un numero non inferiore a 180. Proprio così: centottanta, assegnate da una quindicina di docenti (sempre in media, grosso modo). Ebbene, mi si dica: perché mai tre prove al cospetto di centottanta come minimo, peraltro dinanzi a una commissione composta per i 4/7 da docenti che mai hanno conosciuto gli esaminandi, devono pesare addirittura per il 60% del voto finale? Est modus in rebus, dice una nota locuzione latina. Ed è proprio la misura, segnatamente le proporzioni, più che l’esame in sé, a destare enormi perplessità.
Ma – affermano sovente gli indefessi sostenitori dello status quo – questa prova ha il pregio di essere standardizzata, uguale in tutta Italia, e quindi offre anche la possibilità di “limare” l’eventuale manica larga di alcune scuole, garantendo una valutazione più omogenea. I membri esterni offrirebbero poi la garanzia di una maggiore imparzialità e obiettività del giudizio. Quintessenza della teoria: la realtà ci dice che poco o nulla vale, l’esame di Stato, in tal senso. Diversamente spieghino, i sostenitori dell’esame di Stato nella sua attuale configurazione, come mai in Calabria negli ultimi 5 anni il 17% degli alunni si è diplomato con 100 e 100 e lode, percentuale più che doppia rispetto a quella della Lombardia, quando le prove Invalsi, anch’esse standardizzate, dicono che gli studenti della secondaria di secondo grado della Calabria contendono a quelli siciliani l’ultimo posto tra le regioni italiane, mentre quelli lombardi sono nel gruppo dei primi. Al Nord i voti della maturità sono sempre mediamente più bassi, ribaltando sistematicamente, tra l’altro, la mappa delineata dalle prove Invalsi. Anche i bambini sanno che Veneto, Lombardia, Piemonte, vengono regolarmente surclassate, nelle statistiche degli studenti diplomati con il massimo dei voti, da Calabria, Puglia e Campania. La ragione poi basta e avanza per comprendere che qualche commissario esterno non garantisce alcuna oggettività di giudizio, tantomeno la standardizzazione: non è forse vero che nel Paese operano ogni volta migliaia di commissioni diverse, composte da insegnanti diversi, con metri di valutazione anche molto diversi?
Come docente di classe terminale ho visto, soprattutto negli ultimi anni, esiti sconcertanti: alunni che si sono presentati all’esame di Stato con un’ottima pagella, peraltro reiterata nel tempo, superati nel voto finale da altri che hanno sovente battuto la fiacca e rimediato una media finale dei voti nettamente inferiore. In altri casi, più numerosi, le differenze a lungo mostrate sul campo sono state spaventosamente limate, erose. Ho visto alunni avviliti e, soprattutto, profondamente sfiduciati proprio quando avrebbero dovuto raccogliere il frutto del loro pluriennale lavoro: dopo anni di serio impegno, dopo aver compiuto l’ultimo metro della lunga maratona hanno maturato la profonda convinzione che la scuola sia una burla. Ed è questa l’idea della scuola che porteranno verosimilmente con sé per una vita intera. Niente e nessuno toglierà più a questi alunni il senso dell’inutilità di un impegno serio profuso per un tempo così lungo e questo è l’aspetto che più dovrebbe avvilire chi ha davvero a cuore i nostri studenti e il nostro sistema di istruzione.
Il fatto è che è impossibile dar loro torto, impossibile far credere che sia normale così, che sia giusto che la loro valutazione finale sia stata affidata all’aleatorietà estrema di quei tre, ultimi voti, passibili di essere fortemente influenzati da fattori che poco o nulla hanno a che vedere con l’impegno e le capacità: una notte insonne, una maggiore ansietà davanti a una commissione, una minore scaltrezza (qualità che non è tra quelle che la scuola deve premiare), perché no finanche un banale di mal di pancia, il Caso. La ragione non supporta, in siffatte evenienze, nel tentativo di lenire il dolore della ferita, perché tanto la matematica quanto il più ordinario buon senso danno ragione agli alunni affranti: più aumenta il numero delle prove, più si riduce, come insegna il calcolo delle probabilità, la possibilità che la valutazione possa essere inficiata, in un senso o nell’altro, da eventi occasionali e imprevedibili, e viceversa. Ecco dunque corroborato il non senso matematico e razionale del far prevalere quelle tre prove rispetto a un paio di centinaia di valutazioni distribuite su tre anni. Ma, ribatte il solone di turno dopo una lunga meditazione, con l’aria di chi sta per ammannirti l’incontestabile Verità: “è sempre stato così”. Certamente, non per nulla siamo un Paese schiacciato nei decenni e ancor oggi da un gattopardismo che ha regolarmente tarpato le ali ad ogni alta aspirazione in quasi tutti i campi.
E pensare che basterebbe così poco per risolvere il problema. In medio stat virtus, suggerisce una nota locuzione apportatrice di ordinaria saggezza. Tra il mantenimento dello status quo e l’abolizione dell’esame di Stato ci sarebbe una terza via che, in quanto logica e razionale, viene “giustamente” accantonata, in questo curioso Paese: un ridimensionamento del punteggio attribuito all’esame di Stato. Trenta punti su cento, per esempio, o quantomeno il ribaltamento di quel rapporto 60-40: migliore ponderazione dei pesi, senza cestinare la “maturità” e quello che di buono può dare se le si attribuisce la giusta rilevanza. Ma, appunto, appare una soluzione troppo ragionevole per trovare applicazione.
Sergio Mantovani