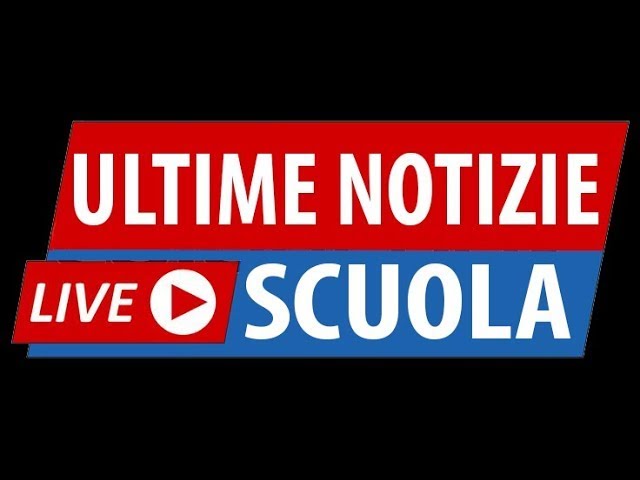Quanti sono i giovani nomadi che frequentano regolarmente la scuola? Se si fa una media nazionale, alla primaria la percentuale di bambini rom e sinti è appena superiore al 50%; nella scuola media scende, attorno al 20-30%; alle superiori crolla, attestandosi attorno all’1%. Questo avviene principalmente perché nella cultura dei nomadi la scuola viene considerata un ostacolo alle attività da svolgere per arrivare a fine giornata: la priorità, anche per i giovani, è portare soldi a fine giornata, in caso contrario possono arrivare anche ad essere malmenati. Non a caso, quasi sempre i genitori sono i primi ad ostacolare la frequenza scolastica dei figli, soprattutto quando diventano adolescenti. Per loro, per i roma, insomma sembra non valere la “stretta” voluta dal ministro Giuseppe Valditara sulle famiglie che non mandano i figli fino a 16 anni a scuola, con pene fino a tre anni.
Il fattore culturale ha quindi un peso specifico enorme. Tanto da essere considerato motivo di giustificazione in sede giudiziaria. Il “contesto” e le esperienze di vita, si legge in una recente sentenza della la Corte di appello di Torino, spingono a credere che siano “l’unico strumento disponibile per garantire ordine e disciplina in famiglia”: i giudici, sulla base di queste motivazioni, hanno quindi assolto dall’accusa di maltrattamenti una coppia di origine romena proveniente da un campo nomadi (lui di 54 e lei di 44 anni) nei confronti delle tre figlie.
Cultura, mentalità e psicologia delle persone coinvolte, sottolinea l’Ansa, in certi casi prevalgono sulla soddisfazione dei diritti.
Tanto da produrre “una sentenza aberrante e paradossale”, commenta con amarezza la senatrice Paola Ambrogio (Fdi), che ha chiesto al Ministero della giustizia di mandare gli ispettori.
Pure l’assessore regionale Maurizio Marrone si è detto contrariato: “E’ inaccettabile la resa istituzionale alla violenza insita nello stile di vita nomade, con il rischio di ufficializzare l’impunità di chi picchia, maltratta e delinque”.
La storia, ha scritto ancora l’agenzia di stampa, comincia nel 2016 quando, nell’ambito di un progetto del Comune, la madre e i quattro figli (tre bimbe e un bimbo) lasciano il campo e vanno a stabilirsi in un alloggio del capoluogo piemontese. Il padre li va a trovare di tanto in tanto. Poche settimane dopo un’operatrice sociale vede che la donna ha “un occhio nero” e raccoglie la confidenza di una delle bambine: “papà ha di nuovo picchiato mamma”.
E partono gli accertamenti. I coniugi finiscono in tribunale perché le figlie, oltre allo stress di vedere papà e mamma litigare furiosamente (cosa che di per sé è già considerata reato), sono costrette a ricevere la loro brutta razione di schiaffi e di calci. Da parte di entrambi.
In primo grado, nel 2021, la coppia è condannata a due anni e sei mesi. In appello, però, tutto si ribalta. La Corte ha preso atto che nessuno ha mai visto sulle bimbe dei segni di violenza e ha concluso che “l’intensità delle percosse non fosse elevata”. Le maestre, poi, hanno dichiarato che a scuola si presentavano vestite e pulite come tante altre bambine. Ma l’accusa di maltrattamenti è caduta per l’aspetto psicologico. E’ stata la difesa a evocare “l’abituale contesto violento” dei campi rom.
I giudici hanno evitato di parlare di “degrado” (la famiglia era seguita dal Comune) e si sono limitati a richiamare “le peculiari condizioni del contesto familiare” per sostenere che ci sono “notevoli dubbi sulla coscienza e la volontà degli imputati” di commettere un reato. Hanno visto una donna che stava crescendo un nugolo di figli praticamente senza il marito. E hanno visto un padre e una madre che “sapevano assumere anche quel ruolo di genitori amorevoli che, in quanto tale, non è compatibile con la consapevolezza di sottoporre le bambine a un regime di vessazioni”.
Si tratta, hanno concluso i giudici, di due persone che, per formazione e impostazione mentale, “consideravano il metodo delle percosse come l’unico disponibile“. Del resto, senza volerlo, l’imputata aveva confessato: “Io le sculacciavo quando erano discole, ma non perché sono una mamma cattiva: è per quello che facevano”.