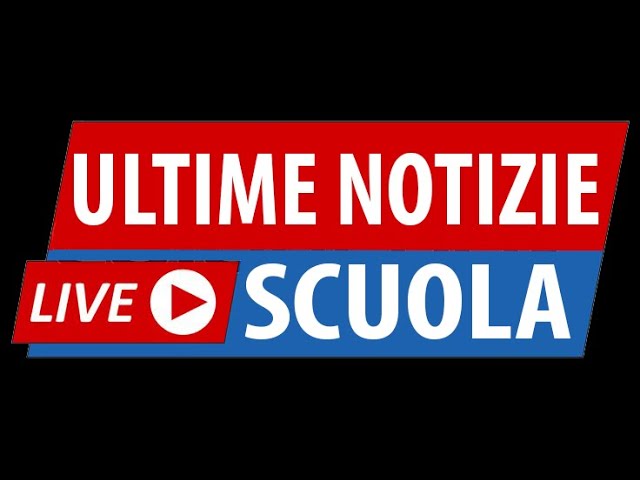"Il burn out è quella sindrome psicopatologica che definisce il crollo psicofisico di un operatore sociale per violazione dei suoi limiti funzionali, quindi per eccesso di stress".
Un operatore sociale può, in taluni casi, abusare dei propri limiti, non ammettere l’impraticabilità di una certa funzione, ossessionarsi nell’ottica della prestazione elevata e quindi cedere alla fatica, alla rabbia, allo sconforto fino a presentare patologie psichiatriche (ansia generalizzata, attacchi di panico, depressione, fobie, talvolta spunti deliranti…) e patologie fisiche correlate (disturbi del sonno, gastrointestinali, cardiaci, nevralgie, malattie dermatologiche, ecc…).
Nonostante la gravità del problema, il burn out si presenta ancor oggi come un "concetto fantasma", ai limiti della coscienza individuale e sociale perché uno dei suoi caratteri specifici è proprio quello d’essere oggetto di dinamiche di mistificazione. Per "mistificazione" di un fenomeno intendo quella dinamica per la quale la coscienza individuale e collettiva è tenuta a ignorare un problema, perché esso è l’epifenomeno di un problema più generale la cui rivelazione potrebbe minacciare la fiducia e il consenso della gente nei confronti di un valore ideologico o di una istituzione che potenti interessi sociali intendono tutelare.
Ormai riconosciuto come un "rischio specifico" delle attività sociosanitarie (medicina, psichiatria, psicoterapia, assistenza sociale, volontariato…), il burn out stenta ad essere riconosciuto in relazione ad attività sociali come l’insegnamento. In questo tipo di attività il grado di mistificazione è tutt’oggi molto elevato.
Allo stato attuale non è ancora possibile individuare il crollo psicofisico dell’insegnante al di fuori della singolarità del "caso estremo", non è stato ancora possibile parlare di un "rischio specifico" dell’attività docente e chiamarla "burn out" perché la coscienza di tale realtà avrebbe sollevato riflessioni critiche sull’ideologia relativa all’insegnamento e sulla congruità degli strumenti di cui la scuola dispone per realizzare i suoi scopi.
Come ho già evidenziato in altri interventi, il problema del burn out dell’insegnante si articola per intero fra tre termini in reciproca relazione:
1) il primo è l’ideologia sociale inerente la funzione della scuola e dell’insegnamento;
2) il secondo è la sensibilità personale dell’essere umano che svolge l’attività di insegnante;
3) il terzo, infine, è la concreta realtà sociale che afferisce alla scuola.
Come si vede, la sensibilità personale dell’insegnante funziona come una variabile intermedia rispetto agli altri due termini. Essa, infatti, può essere più o meno "sospettosa", dunque più o meno critica, nei confronti di ciò che la realtà sociale offre come materiale di lavoro e nei confronti di ciò che l’ideologia corrente ritiene auspicabile di quel materiale sia fatto.
La situazione scolastica contemporanea è simile in parte a quella affrontata più di un secolo fa, all’epoca della scolarizzazione di massa. La quantità di bambini e ragazzi che ogni giorno afferisce alla scuola è di fatto enorme. Nondimeno il periodo storico attuale è più problematico di ogni altro della storia recente per via di una fondamentale differenza.
Questa differenza di solito non viene nè percepita nè citata per timore di essere giudicati "politicamente scorretti". Il punto, ritengo, è che quella attuale è una società non solo multietnica, ma anche multiculturale e, soprattutto, multiproblematica. Ciò vuol dire che i bambini e i ragazzi che afferiscono alle scuole sono sempre più spesso a tal punto diversi tra loro per lingua, abitudini e cultura e presentano a tal punto problemi di varia natura da non costituire facilmente una "classe" omogenea, nonostante l’ideologia sociale corrente presupponga che essi lo siano.
L’ideologia educativa egualitaria, propria dei regimi democratici, presuppone che tutti i bambini partano da una condizione paritaria universale (l’infanzia), e che la scuola e gli insegnanti debbano far fruttare ed esaltare questa uniformità di partenza somministrando ai bambini una formazione comune e paritaria, che li inserisca nel mondo sociale con pari strumenti e pari possibilità. Il principio egualitario è, dunque, una petizione di principio che si basa su un presupposto di eguaglianza. Semplificato, il ragionamento è che avendo la scuola il potere di "sottrarre" temporaneamente il bambino alle famiglie di appartenenza, essa può risolvere le diseguaglianze presenti nella società.
La mia tesi è che il principio di eguaglianza è ideologico e fallace, e ciò per due motivi. Il primo è che le condizioni di partenza dei bambini continuano ad essere disomogenee per irrisolti fattori oggettivi (in termini assoluti, la povertà economica e quella culturale non sono diminuite; inoltre, è aumentata nelle scuole la presenza di bambini portatori di handicap).
Il secondo motivo è che la disomogeneità degli alunni non dipende solo dai citati fattori oggettivi, ma, stanti le forti tensioni etniche dovute alle nuove convivenze, un certo grado di disomogeneità viene sempre più rivendicato dalle famiglie (e dunque dai bambini) come un irrinunciabile elemento identitario.
Dunque, benché l’ideologia educativa corrente si ponga la meta democratica di fornire in astratto pari opportunità di successo per tutti, occorre ammettere che i bambini reali obbediscono a un innato "bisogno di appartenenza" il quale fa loro preferire i valori e gli affetti della famiglia a quelli dello Stato (e dunque della scuola).
Oggi giorno, non solo è impresa ardua rendere omogenee le diverse classi sociali, per alcune delle quali la scolarizzazione infantile e adolescenziale resta a tutt’oggi considerata un valore di scarso rilievo; ma è impresa ancora più ardua rendere omogenei fra loro alunni provenienti da culture che ignorano quando non temono o talvolta persino disprezzano la stessa esistenza di un apprendimento formale unitario deciso e somministrato dallo Stato.
Lo smarrimento dell’insegnante di fronte a tali realtà segna il drammatico scarto fra scopi dichiarati e realtà di fatto.
L’insegnante, dunque, può trovarsi di fronte a una classe multiproblematica, nella quale egli deve gestire:
1) differenze linguistiche non risolte;
2) il tendenziale rifiuto alla scolarizzazione da parte di alunni provenienti da culture (per fortuna rare) resistenti alla statualità o all’integrazione;
3) il disagio arrecato da alunni con problemi caratteriali;
4) il ritardo causato dalla presenza di alunni portatori di handicap.
Come diceva Totò: "E’ la somma che fa il totale!" Classi di questo genere manderebbero ai matti chiunque. E tutto questo a fronte di un trattamento economico che definire mediocre è eufemistico e di un precariato annoso e umiliante!
E’ chiaro che se il docente non ha sviluppato gli anticorpi giusti, ossia una coscienza critica, "diffidente", che gli consenta l’osservazione spassionata della realtà, e se, anzi, egli è gravato di un carattere ingenuo e passionale, altruista e magari perfezionista, egli rischia di farsi carico di oneri la cui risoluzione dovrebbe spettare piuttosto allo Stato e alla società nel suo complesso.
Mi rendo conto di sostenere una tesi "pesante", giudicabile come "politicamente scorretta"; e tuttavia essa mi appare centrale per comprendere appieno il crescente disagio psicologico che colpisce oggi una parte consistente degli insegnanti.
L’egualitarimo democratico può divenire un egualitarismo astratto se non ci si pone con onestà di fronte a questo importante aspetto del mondo contemporaneo. Negato e mistificato, esso rischia di esser fatto ricadere per intero sulle spalle del singolo insegnante, costretto a trasmettere una cultura unitaria nei valori e nei livelli a un certo numero di alunni che si sottraggono ad essa sia per l’invisibile influsso della loro classe sociale e della loro appartenenza culturale, sia per limiti psicofisici oggettivi.
Il burn out dell’insegnante può, dunque, essere affrontato a monte, sgravando il suo impegno dei carichi in eccesso. La lingua italiana potrebbe allora essere insegnata sia nei luoghi di origine che in scuole speciali sul nostro territorio, in modo che l’insegnante della scuola pubblica ne sia liberato; la gestione della diversità culturale potrebbe essere delegata ad appositi mediatori culturali; la devianza sociale e il disturbo psicologico affrontati da professionisti del settore (psicologi e assistenti sociali).
Solo l’handicap – a mia conoscenza – ha avuto ad oggi una risposta ampia e sollecita.
Dotarsi di queste figure alternative all’insegnante di scuola pubblica comporterebbe vantaggi per tutti: per lo Stato il quale avrebbe l’opportunità di preservare la salute del personale docente, evitando i prevedibili futuri contenziosi legali; per il docente il quale otterrebbe la restituzione di un ruolo finalmente equo, calibrato su doveri di sua effettiva competenza; e infine per gli stessi alunni, i quali otterrebbero di vedere finalmente integrato il lavoro scolastico di formazione culturale con una più generale opera di promozione dell’equilibrio psicologico e della salute.