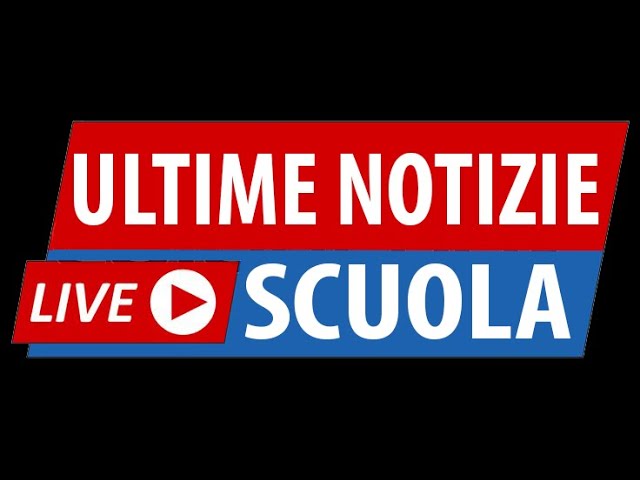Come Gruppo di interesse per la Valorizzazione Italiana del Ph.D (V.I.Ph.D) e Comitato per la Valorizzazione del Dottorato, desideriamo anzitutto ringraziare il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti, il Senatore Mario Pittoni Presidente della 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) e lo SNALS nella figura del suo Segretario Generale SNALS-Confsal Prof.ssa Elvira Serafini per il sostegno e l’impegno profuso a favore della valorizzazione del dottorato anche nella scuola, e che hanno portato all’inclusione dei Dottori di ricerca tra le categorie che accederanno al PAS, come stabilito nel decreto presentato dal Ministro Bussetti al Consiglio dei Ministri e da quest’ultimo approvato “salvo intese” il 7 agosto, contenente interventi per avviare Percorsi Abilitanti Speciali e un concorso straordinario per i docenti senza abilitazione.
L’intesa siglata lo scorso 24 aprile dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e da tutti i sindacati, cui è seguita quella ratificata l’11 giugno anche dal Ministro Marco Bussetti, è dunque finalmente confluita in un dispositivo normativo, ancorché ancora da integrare e promulgare, che vede i dottori di ricerca ammessi, in quanto tali e quindi senza requisiti di servizio scolastico, ai prossimi PAS.
È una svolta storica: per la prima volta i dottori di ricerca sono considerati come categoria meritevole, in virtù del solo titolo di dottorato, di accedere di diritto alla formazione come docenti di scuola. Un ottimo punto di partenza, sul quale costruire qualcosa di nuovo, che dà ai possessori del massimo titolo di studio conseguibile a livello internazionale (l’ottavo, nella classificazione internazionale standard dell’istruzione – ISCED – elaborata dall’UNESCO) l’opportunità di ricambiare gli investimenti formativi dello Stato nei loro confronti. Come dottori di ricerca, potremo infatti restituire alla società, alle sue generazioni più giovani, quel sapere agito fatto di conoscenze, competenze e abilità trasversali al quale abbiamo dedicato anni di impegno e che tanti benefici potrebbe apportare nella scuola e per gli studenti. I Ph.D interessati alla scuola, è bene ricordarlo, per la maggior parte sono studiosi, docenti universitari a contratto o provenienti da istituti esteri, professionisti in aziende e in enti privati, che non chiedono di meglio che mettere a disposizione della Scuola la propria qualificazione e professionalità.
“Dalli al Dottore di ricerca!”
Eppure, c’è qualcuno a cui l’eccellenza che entrerebbe nelle aule grazie a professori motivati e formati da esperienze di altissimo livello dà fastidio, qualcuno che finge di ignorare come in una società globalizzata e competitiva quale quella odierna, i ragazzi debbano essere formati e preparati in modo trasversale, approfondito, e quanto questo sia più facile con docenti che a loro volta abbiano sperimentato in modo profondo e differenziato sia il mondo della formazione sino ai massimi livelli che quello del lavoro, in Italia e all’estero, traendone conoscenze e competenze uniche. Il fatto più grave per il nostro Paese è che tra le fila di questi odiatori della meritocrazia e difensori dello status quo come titolo e valore a sé stante, vi siano soprattutto docenti o aspiranti tali e anche rappresentanti dei cittadini eletti in Parlamento.
In ordine sparso, gli epiteti indirizzati ai dottori di ricerca (spesso conditi da sgrammaticature e orrori ortografici), in particolare da chi già siede in cattedra o ritiene di avere in proposito un diritto di prelazione, includono: scarti dell’università, falliti della ricerca, parassiti, avvoltoi, sciacalli che senza neanche un giorno di insegnamento andrebbero a togliere posti ai precari che mandano avanti la scuola, dottori di ricerca del cazzo, dottorucoli feisbucchiani, gentucola.
Se questo è il livello del “dibattito”, forse sarebbe il caso, prima ancora di far entrare nella scuola nuovi docenti, di verificare la qualità e i titoli di dignità e merito di quelli che già vi lavorano. Chi insegna ha scelto una missione che non è solo trasmettere amore per il sapere e la cultura ma anche e soprattutto il valore del rispetto e del confronto con l’altro, operato su basi autenticamente democratiche: di tutto questo, il docente, colui che conduce gli alunni, deve offrire testimonianza, deve essere il primo esempio.
Il bullismo e l’odio, dettati da ignoranza o pura violenza, andrebbero quindi deprecati, non certo praticati.
Qual è il problema dei Dottori di ricerca?
In Italia il titolo di Dottore di ricerca (Ph.D) corrisponde, nella pratica e nella considerazione comune, a una lettera scarlatta. Come nel romanzo di Hawthorne, è segno anzitutto di un crimine: lì, l’adulterio; qui, l’essere affetti da una malattia incurabile, l’iper-qualificazione – o, per usare un termine internazionalmente riconosciuto, la “sovraistruzione pura” (Genuine overeducation), condizione sciagurata in cui né il titolo di studio né le competenze acquisite sono giudicate rilevanti per lo svolgimento del lavoro (i lavoratori “sovraistruiti” sono 5,7 milioni, quasi 1 su 4). Ma non solo: proprio come nel libro, quel marchio indica anche una colpa, nel caso dei Dottori di ricerca l’aver scelto di intraprendere quella complessa attività di studio piuttosto che “andare a lavorare” o imboccare vie più brevi (master o tirocini).
Il movente, nel classico statunitense e per i Ph.D, è il medesimo: l’amore.
Nel nostro Paese, evidentemente, l’amore per la conoscenza e la cultura è svalutato o, nel migliore dei casi, ignorato: per un verso ci si indigna di fronte al fenomeno dei “cervelli in fuga”, per l’altro non si fa alcunché per offrire a questi emigranti con lauree, master, dottorati, certificazioni linguistiche e via dicendo, concrete alternative in patria; da un lato si chiede agli insegnanti di trasmettere agli studenti di ogni età il valore dello studio, l’importanza dell’impegno e della formazione, dall’altro si distoglie lo sguardo o si fanno commenti di circostanza quando si scopre che, magari, il cameriere che ci ha appena serviti ha due lauree o un dottorato.
Come evidenziato dall’analisi OCSE del 2017 Skills Strategy Diagnostic Report, nel nostro Paese il premio per il capitale umano è bassissimo, cioè agli anni di studio e ai soldi spesi non corrisponde poi un adeguato riconoscimento né meritocratico né salariale, per cui anche il numero dei Ph.D è ridotto: non vi è alcun ritorno economico nell’aver conseguito un dottorato. C’è da stupirsi, allora, se quasi il 20% di chi possiede tale titolo, dopo 4 anni di tentativi, si arrende e fa le valigie (rapporto 2018 del Ministero del Lavoro, Istat, Inps, Inail e Anpal)? È uno spreco enorme di risorse e competenze: lo Stato prima investe nella formazione, arrivando a pagare un Dottore di ricerca per tre anni, e poi lo lascia andare via, a beneficio di imprese, università, enti e istituti di ricerca stranieri. Accanto alla ricerca pura, lo sbocco più naturale per chi è così qualificato e specializzato sarebbe l’insegnamento, all’università e a scuola: peccato che nel nostro ordinamento il Dottorato sia sostanzialmente irrilevante nelle selezioni per la Pubblica Amministrazione e di fatto penalizzato nelle procedure di accesso alla professione docente.
Che cos’è davvero un dottorato e quale rapporto ha con l’insegnamento.
In Italia come nel resto del mondo, il Dottorato di Ricerca (o Ph.D) è il massimo titolo di studio conseguibile, al termine un iter di studio e ricerca di minimo 3 anni al quale si accede tramite concorso pubblico (una o due prove scritte, una orale e verifica di competenze linguistiche minimo di livello B2) e che prevede, in uscita, la discussione e valutazione di una tesi.
Nella vulgata diffusa tra il mondo della scuola si tende impropriamente a scindere la figura del Dottore di ricerca da quella del docente. La ricerca non è “mero” studio, perché al termine dei tre anni, il prodotto – che viene giudicato dai massimi esperti sull’ambito disciplinare in cui il Dottore di ricerca si specializza – è non solo una ricerca innovativa, ma anche la prova tangibile di un’elevatissima professionalità sia di carattere disciplinare che di metodologia di studio e ricerca, ovvero di quelle conoscenze, abilità e competenze (il sapere e il saper-fare) che i docenti dovrebbero trasmettere agli studenti.
I dottori di ricerca studiano, fanno ricerca, preparano relazioni in cui presentano parti della propria ricerca, pubblicano in giornali, riviste, libri e, last but non least, insegnano, anche durante il corso dottorale (cfr. L. 210/1998, Art. 4 “Dottorato di ricerca”, punti 1 e 8; D.M. 8 febbraio 2013, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”, Art. 12 “Diritti e doveri dei Dottorandi”, punto 2).
Il dottorato prevede già una parte di didattica, guidata da un tutor, il docente ordinario, altamente qualificato nell’insegnamento e questa attività, e ciò garantisce una “scuola all’insegnamento” da parte di docenti universitari, responsabili dell’attività dottorale. Ecco perché, alla fine del suo percorso formativo, il dottore di ricerca risulta in grado di gestire l’attività didattica in tutte le sue forme. Ed ecco perché riteniamo che il dottorato di ricerca sia altamente qualificato e preparatorio per l’insegnamento, oltre che per la ricerca.
I PhD rilasciano abilitazioni ma non sono considerati abili a insegnare.
Tutti, inoltre, sembrano ignorare o dimenticare che fino ad oggi i Dottori di ricerca si sono trovati, proprio a proposito della formazione scolastica, in un’assurda posizione di sfruttamento e discriminazione: possono abilitare (insegnando a contratto, con rimborsi spese di poche centinaia di euro all’anno, nei TFA, nei PAS e nei corsi del For24) ma non sono considerati abilitati. Come se a tenere i corsi per prendere la patente di guida fossero istruttori che ne sono privi. Si dimentica, per di più, che in Italia il titolo di studio ha valore legale per cui il Dottorato dovrebbe semplicemente essere in vetta a qualsiasi graduatoria. Ai Ph.D si rimprovera di non aver partecipato ad alcun corso abilitante? L’ultimo, però, non solo è stato nel 2014 ma la legislazione reputava incompatibile lo svolgimento dei due percorsi: abilitazione (TFA) e dottorato. Se i corsi abilitanti si fossero tenuti con regolarità e senza incompatibilità, sarebbe stato diverso; il fatto invece che ogni tanto si sia palesata la possibilità fortuita di abilitarsi e i Ph.D abbiano valutato di non poterlo fare o di avere in quel momento altre esigenze di vita, non può essere loro imputato come un peccato originale. Incidentalmente, si ricorda che per altre professioni che richiedono una specifica abilitazione all’esercizio (medici, avvocati, giornalisti, ingegneri…), è stabilito un iter preciso, sempre uguale e a cadenza regolare: l’apposito esame di Stato. Non si capisce perché solo per gli insegnanti la possibilità di abilitarsi debba essere un sorteggio generazionale o congiunturale.
Un ascensore sociale alla rovescia.
Cos’hanno in comune tutti questi dottori di ricerca, che se non precari della scuola di certo sono precari della vita, col massimo titolo e il minimo riconoscimento? Appartengono alla prima generazione nella storia per la quale l’ascensore sociale non solo si è fermato ma è addirittura tornato indietro, per cui i figli sono e resteranno più poveri dei padri. È la prima ad aver sperimentato la “lotteria generazionale”, per cui l’essere nati un anno prima o un anno dopo, e non le proprie capacità, è l’unico discrimine per avere qualche occasione: le “politiche giovanili” riguardano chi ha tra i 15 e i 24 anni; per le aziende esistono solo “neolaureati” da non più di un anno (sfruttabili con stage e tirocini); nei bandi per le start-up si è “giovani” e si possono avere idee innovative solo fino ai 29 anni e superati i 35 c’è la morte civile, o si è considerati “vecchi” o si dà per scontato che si sia già “arrivati”. I nati tra la fine degli anni Settanta e l’inizio dei Novanta, xennial e millennial, costituiscono la tristemente nota “generazione perduta”, come ebbe a definirla l’allora Presidente del Consiglio Mario Monti: un’espressione infelicissima non solo per l’implicita e ignobile rassegnazione politica a lasciar morire senza un futuro i 30-40enni, ma anche perché in genere utilizzata per indicare la mattanza della Prima Guerra Mondiale che falciò, appunto, un’intera generazione. L’esito, a ben guardare, non è tanto diverso: un Paese in macerie, senza avvenire, privo di un adeguato ricambio generazionale e di forze fresche, preparate e appassionate, capaci di traghettare la società verso magnifiche sorti e progressive.
V.I.Ph.D – Comitato per la Valorizzazione Italiana del Dottorato di ricerca ([email protected])