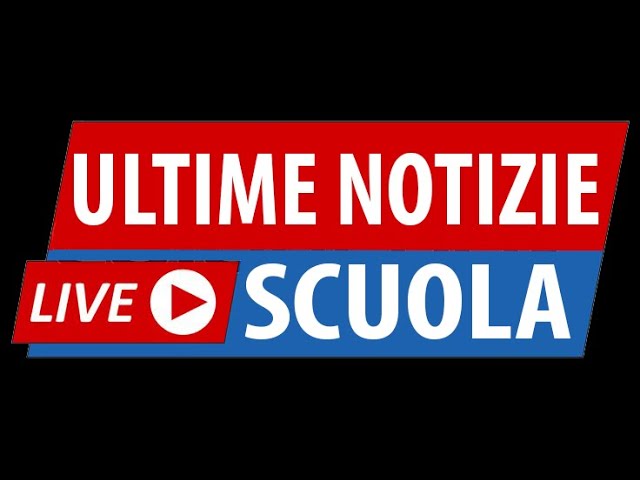In occasione dell’incombenza da parte delle Istituzioni Scolastiche di predisporre la documentazione didattica per alunni con problematiche di apprendimento, mi permetto di esprimere alcune valutazioni, indubbiamente “in direzione ostinata e contraria”, sull’affermazione di don Milani “Se si perdono i ragazzi più difficili la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati”, tratta dalla Lettera a una professoressa e riportata qualche tempo fa.
L’affermazione, per essere valutata a pieno nelle sue implicazioni e di conseguenza per poterne dare un giudizio di validità, deve essere contestualizzata in relazione alla scuola elitaria di matrice fondamentalmente gentiliana dei primi anni sessanta: un sistema scolastico gerarchizzato sia in termini di gradi (elementari, …) che di ordini (ginnasio-liceo classico …) con diverso stato sociale, se non giuridico, sia degli studenti che degli insegnanti ad esse appartenenti.
L’intero sistema, nelle sue varie articolazioni, era teso a selezionare, sostanzialmente in base alla classe sociale di provenienza, la collocazione “meritocratica” degli alunni: stabilito che il completamento degli studi umanistici a livello universitario era il fine didattico più elevato, era lo stesso meccanismo di selezione che presupponeva quello che, in termini dell’affermazione di don Milani, può dirsi una “perdita” progressiva degli alunni, una specie di decantazione frazionata, finalizzata a mantenere con minime variazioni, le proporzioni quantitative e qualitative tra le classi sociali e tra i ruoli specifici nella società di allora.
In quel contesto, l’adeguamento dell’insegnamento ai bisogni degli alunni “più difficili”, sia per quanto riguarda i contenuti che la metodologia, attraverso la costruzione di un apprendimento comune che fosse in grado di rendere collettivi i risultati di una ricerca conoscitiva individuale, oltre ad essere ovviamente necessario in una scuola finalizzata al recupero di quegli alunni che erano stati precedentemente respinti dal sistema educativo ufficiale, acquistava anche, di conseguenza, una indubbia valenza di opposizione alla cultura antidemocratica dominante.
Tuttavia, nella Lettera a una professoressa, questo adeguamento, questa “cura” dei bisogni educativi degli alunni meno integrati, sembra attuarsi più sulla base di un atteggiamento di puro ribellismo velleitario, di una mera rivendicazione di una presenta “bontà” della cultura dei “poveri”, che di una consapevole e coerente analisi dei vari aspetti della cultura dominante: i giudizi astiosamente drastici nei confronti degli insegnanti, individuati come “ truppe di riserva” a servizio dei “ricchi”, il sommario elenco delle materie che “non servono” o “sono sbagliate”, l’avversione di principio per ogni forma di valutazione degli alunni e di ogni bocciatura, sembrano fornire le basi di un ipotetico programma educativo costruito su misura della subalternità degli alunni “poveri”, quasi a circoscrivere una specie di riserva indiana protetta, senza nessuna prospettiva concreta di una riappropriazione della cultura dei “ricchi” per uscire da tale subalternità.
In un giudizio complessivo, se a quel tempo questa impostazione del problema educativo delle classi sociali disagiate poteva comunque rappresentare un necessario momento di rottura nei confronti del perbenismo della cultura educativa ufficiale, momento di rottura, da un altro punto di vista, esemplificato dal motto “ Io sto con Franti” di un celebre saggio di U. Eco, oggi, in una scuola già poco attrezzata per affrontare le conseguenze sia di un impoverimento culturale da analfabetismo di ritorno, sia di un’autonomia gestionale imposta dall’alto, l’andare in quella stessa direzione è del tutto deleterio: la tendenza attuale a trattare ogni condizione di disagio, sia disciplinare che didattico, come un caso clinico che richiede una “cura” facilitativa, contribuisce a deresponsabilizzare gli alunni in oggetto e, a causa della effettiva mancanza della sempreverde chimera della didattica personalizzata, genera meccanismi di difficile gestione all’interno della classe.
Inoltre, questa tendenza, ripercuotendosi maggiormente su quegli indirizzi di studio dove gli alunni “difficili” sono più numerosi, innesca proprio quel meccanismo di dequalificazione, se non di esclusione, che nelle intenzioni si vorrebbe eliminare: in nome dell’individuazione di obiettivi minimi teoricamente raggiungibili con varie strategie didattiche alternative, che però di fatto bypassano quello che, con A. Gramsci, certo in un altro ambito e con altre finalità, si potrebbe dire la necessità culturale, prima che educativa, di non sottrarsi a “studi difficili”, la scuola gentiliana, paradossalmente, cacciata dalla porta, rientra dalla finestra.
Massimo Salvarezza
Note a margine di:
Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa
U. Eco, Elogio di Franti, da Diario Minimo
non firmato, La scuola di cultura, da L’Ordine Nuovo del 20/12/1919
non firmato, Studi difficili, da L’Ordine Nuovo del 27/12/1919