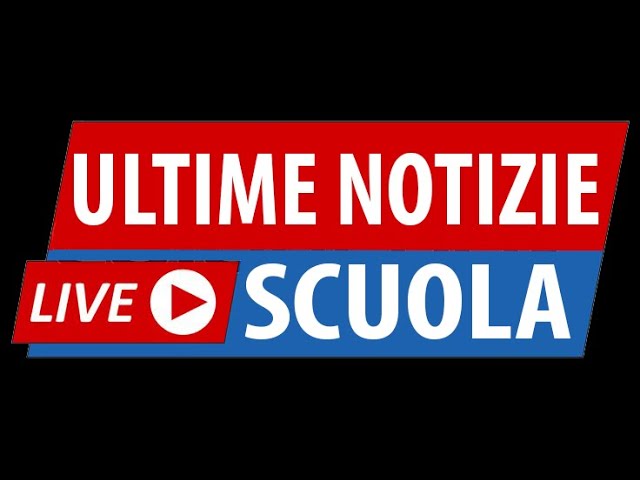Se dovessimo dare credito alle dichiarazioni e agli annunci che le diverse forze politiche stanno facendo in questi giorni di campagna elettorale dovremmo concludere che a partire dalle prossime settimane per la scuola italiana si aprirebbe davvero una nuova grande stagione.
Si parla di aumenti stipendiali mai visti (e forse neppure immaginati) fino a incrementi di organici per estendere il tempo pieno in tutta Italia e interventi sull’edilizia da fare invidia ai Paesi del nord Europa.
Ma sarà davvero così?
Lo sapremo fra qualche tempo, ma per intanto proviamo a parlarne con chi la scuola italiana la conosce da mezzo secolo.
Sentiamo cosa ne pensa Mario Maviglia, dirigente tecnico ora in pensione, con un lungo passato anche da insegnante e da direttore didattico, quando i dirigenti scolastici si chiamavano ancora così.
Maviglia:
Un problema importante che dovrà essere affrontato riguarda per esempio quello delle dimensioni delle istituzioni scolastiche. Ormai è invalso l’uso di considerare l’istituzione scolastica come una comunità che interagisce con la più vasta comunità esterna. L’ultimo CCNL Scuola ha introdotto, a questo proposito, l’espressione di “comunità educante”; si tratta di una visione certamente suggestiva e intrigante.
E cosa c’è che non va in questo?
E’ semplice: affinché la scuola possa riconoscersi come “comunità” occorre che vi siano i presupposti, come dire?, materiali perché ciò avvenga. In una comunità, ad esempio, ci si aspetta che i componenti si conoscano tra loro in modo non superficiale, ci si attende che possano interagire al loro interno e condividere idee e progetti; insomma ci si aspetta che vi sia una rete relazionale e comunicativa viva e continua sia in senso orizzontale (tra colleghi) che in senso verticale (con la dirigenza e viceversa).
E quindi cosa bisognerebbe fare?
Il fatto è che le norme attuali fissano solo i numeri minimi per far funzionare un’autonomia scolastica (non meno di 600 alunni ordinariamente e non meno di 400 nelle zone di montagna o piccole isole); non viene fissato un numero massimo. Pensare di fondare “comunità educanti” con numeri così alti è pura utopia in quanto viene a mancare l’elemento caratterizzante una comunità, ossia quello relazionale-comunicativo; al più si può fondare una comunità organizzativa con una chiara definizione dei ruoli e dei poteri dei diversi soggetti coinvolti.
Quindi ci vogliono scuole “a misura di relazioni umane e professionali”.
Esattamente, ma non basta.
Prendiamo per esempio l’aspetto burocratico. Ogni organizzazione non può fare a meno di documentare, attestare, certificare ecc. la propria attività, per vari e molteplici motivi; ma quando la produzione di atti raggiunge livelli assimilabili alla categoria della superfetazione, allora rischia di essere messa in discussione la stessa mission dell’organizzazione, nel senso che ciò che doveva essere visto come un mezzo diventa un fine. È quello che è successo alla scuola e che continua a succedere: un profluvio di norme, circolari, direttive, note, decreti, istruzioni e quant’altro, che soffoca l’attività di docenti e dirigenti. Non è esagerato dire che oggi il docente italiano rischia di essere più paragonabile ad uno scribacchino che a un intellettuale.
Ma è mai possibile che non si riesca a mettere un freno a tutto ciò?
Forse bisognerebbe riorganizzare in modo sistematico le norme già esistenti (operazione già prevista, per la verità, dalla legge 107/2015, ma finora mai portata a termine) e quindi imporre un limite massimo di atti da produrre nel corso di un anno scolastico. Se le norme nazionali sono chiare e ben sistematizzate, gli interventi amministrativi del Ministero non dovrebbero superare la decina nel corso dell’anno scolastico; ci penseranno le scuole autonome ad organizzare l’attività scolastica sulla base delle norme esistenti. Questo presuppone che il “superiore Ministero” abbandoni definitivamente ogni velleità centralistica e si ponga al servizio dell’autonomia delle scuole.
Che giudizio può dare dell’attuale dibattito sulla scuola?
Io credo che le preoccupazioni dei docenti, ma anche di chi oggi “governa” la scuola, dovrebbero essere altre: come strutturare la classe in una comunità di apprendimento? Quali strategie mettere in atto nei confronti degli studenti che non apprendono? Come utilizzare in modo proficuo le tecnologie informatiche nella didattica? Come interagire con la realtà esterna senza snaturare la specificità educativa della scuola?
Al contrario l’impressione che si ricava è che questi problemi siano stati espunti dal dibattito sulla scuola, tutto centrato su ciò che avviene al di fuori dell’aula, come se la professione docente si svolgesse in un altrove contrassegnato dall’assenza della didattica e della pedagogia.
E “dal lato” studenti cosa si osserva?
La responsabilizzazione dello studente con la mobilitazione delle sue capacità elaborative ed operative appare ancora molto poco diffusa nella pratica didattica. Di fatto gli studenti sono quasi sempre destinatari pressoché passivi degli interventi didattici degli insegnanti; sono poche le occasioni in cui possono mettere a frutto, attraverso progetti individuali o di coppia o di gruppo, quanto acquisito in classe. Non che manchino esperienze ispirate a questi principi educativo-didattici, ma nel complesso la didattica appare ancora ingessata, centrata prevalentemente sulla parola dell’insegnante e fortemente disallineata rispetto alle forme contemporanee di conoscenza dei giovani di oggi.
Insomma, secondo lei siamo di fronte a un dibattito parziale, potremmo dire quasi asfittico
Proprio così: quanto è stato detto fin qui stenta ad entrare nel dibattito pubblico sulla scuola, ma se non si tengono conto di questi problemi le varie proposte di riforma rischiano di rimanere lettera morta in quanto non riescono ad incidere sulle concrete prassi didattiche. Se non vi è un cambio di paradigma nel modo di fare scuola ogni progetto di riforma è destinato ad arenarsi.
Anche il contrasto alla dispersione rischia quindi di diventare solo uno slogan…
Sì, perché gli stessi interventi che mirano a contrastare le cosiddette “povertà educative” spesso dimenticano di considerare che può essere la stessa scuola ad alimentare ed aggravare queste povertà laddove perpetua forme vetuste di didattica che non riescono a motivare e coinvolgere nei processi di apprendimento la popolazione studentesca più fragile.
Siamo costretti a concludere “alla Bartali”, e cioè “è tutto sbagliato, è tutto da rifare” ?
Certamente non è tutto da rifare, ma bisogna prestare molta attenzione ai prossimi interventi.
Io credo che lavorare sulle competenze professionali degli insegnanti sia un obiettivo prioritario se non si vogliono perdere importanti opportunità di sviluppo e rinnovamento della scuola.
Gli stessi sostanziosi finanziamenti messi in campo dal PNRR rischiano di lasciare inalterato il livello di qualità della scuola se non si interviene sulla formazione dei docenti. Avere insegnanti ben preparati e in grado di modulare gli interventi didattici a seconda delle realtà delle classi, vuol dire investire sulla loro formazione e sui meccanismi di selezione e individuazione di professionisti idonei. E su questo aspetto in Italia si registra una grande fatica a trovare una soluzione adeguata; di fatto ci si accontenta di tenere in piedi un esercito di professionisti malpagato, senza alcun incentivo a migliorare la propria professionalità, con pochissimi controlli sulla qualità del servizio prestato e con una preparazione iniziale alquanto indefinita. Con questi presupposti c’è poco da essere ottimisti.