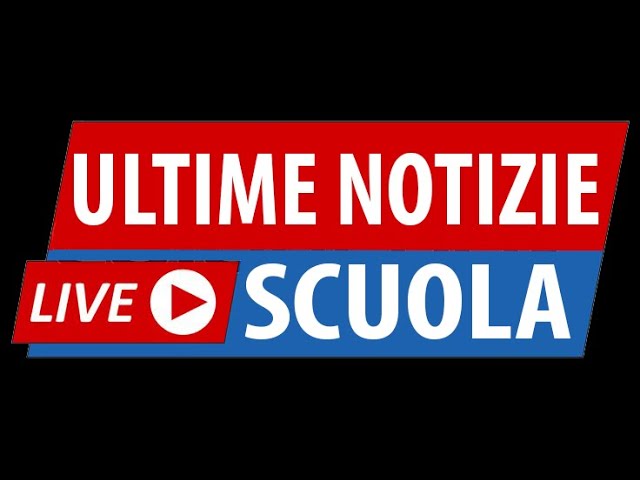La recente sentenza 3459 della Corte di Cassazione, depositata il 27 gennaio scorso, non lascia più dubbi di interpretazione: l’insegnante che ripetutamente, durante le lezioni e dinanzi ai compagni di classe, apostrofi un proprio alunno con epiteti quali “deficiente” o “fetente” o addirittura “coglione”, evidentemente umiliandolo dolorosamente, si macchia di reato. Il tutto nella cornice della palese differenza di ruolo e di età tra il docente e il minore.
In modo particolare, qualsiasi forma di violenza, sia essa fisica che psicologica, non costituisce mezzo di correzione o di disciplina, neanche se posta in essere per uno scopo educativo. E qualora di essa l’insegnante, faccia un uso sistematico come fosse un “ordinario” trattamento del minore affidato, la sua condotta non rientra nel mero «abuso dei mezzi di correzione», bensì in quella dei veri e propri «maltrattamenti» penalmente rilevanti.
E il codice penale punisce con la reclusione da tre a sette anni chiunque “maltratta” una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte. La pena in argomento è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in danno di un minore o di una persona con disabilità.
Nel caso specifico del docente condannato, si legge sul Sole 24 Ore, la Corte ha riscontrato da un canto che l’atteggiamento verso il ragazzo (appena) dodicenne fosse evidentemente di valenza ingiuriosa e umiliante, ma anche che il tenore dello stesso fosse di tale grado di “mortificazione” e continuità dall’essere assolutamente sganciato da qualsivoglia (legittimo) scopo educativo o, se si voglia, correttivo.
Anzi per la Corte è indiscutibile che, in ogni caso, e cioè quand’anche il docente in tali casi agisca con intenti educativi, una tale “modalità” non è mai appropriata, mancando su tutto e in ogni caso, l’imprescindibile requisito della “adeguatezza”.