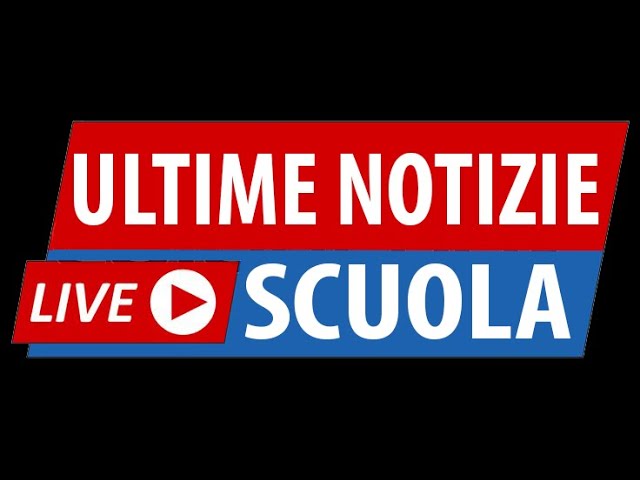È diverso tempo che l’Italia non annovera alcuna sua Facoltà universitaria tra le prime cento al mondo. Quasi una prassi che anche quest’anno è stata confermata: in base alla classifica realizzata il 7 ottobre dal quotidiano britannico “The Times” risulta che l’unico ateneo italiano presente nella top 200 è l’Università di Bologna che si piazza al 174° posto. E per trovare un’altra nostra università bisogna scorrere la graduatoria fino al 205° posto, occupato, come lo scorso anno, dall’ateneo più grande d’Europa: La Sapienza di Roma. Se poi si vanno a verificare le performance complessive delle nostre sedi universitarie si scopre che rispetto a 12 mesi fa sono addirittura peggiorate.
Senza entrare nel merito dei mali delle nostre università, noti ma sembra ineliminabili, almeno nel breve periodo, meglio concentrarsi sui modelli internazionali all’avanguardia. Come quello della struttura accademica nordamericana di Harvard, che si conferma al 1° posto. Le statunitensi continuano a padroneggiare, tanto che tra le prime cinquanta ne piazzano ben 18. C’è qualcosa che però si sta incrinando nelle strutture accademiche degli Usa: se si guarda alle prime cento università del mondo si scopre che 36 sono statunitensi, ma lo scorso anno erano 42.
Senza entrare nel merito dei mali delle nostre università, noti ma sembra ineliminabili, almeno nel breve periodo, meglio concentrarsi sui modelli internazionali all’avanguardia. Come quello della struttura accademica nordamericana di Harvard, che si conferma al 1° posto. Le statunitensi continuano a padroneggiare, tanto che tra le prime cinquanta ne piazzano ben 18. C’è qualcosa che però si sta incrinando nelle strutture accademiche degli Usa: se si guarda alle prime cento università del mondo si scopre che 36 sono statunitensi, ma lo scorso anno erano 42.
Chi non sembra perdere colpi è invece la formazione post diploma della Gran Bretagna (che piazza 8 atenei sui primi 50): Cambridge è al posto numero 2 (al 3 c’è Yale). E sono inglesi le posizioni 4, 5 e 6, rispettivamente ricoperte dall’University College di Londra, dall’Imperial College di Londra e dalla storica Oxford.
Ottimo anche lo score degli atenei australiani (6 su 50). Poi ci sono due atenei francesi ed altrettanti canadesi, uno irlandese (il Trinity College di Dublino), uno svizzero ed uno olandese. In salita le università asiatiche: Tokyo passa al 22esimo posto, seguita al 24esimo da Hong Kong. Ci sono anche Sud Corea e Singapore in classifica, oltre alla Tsinghua University della Cina.
Ottimo anche lo score degli atenei australiani (6 su 50). Poi ci sono due atenei francesi ed altrettanti canadesi, uno irlandese (il Trinity College di Dublino), uno svizzero ed uno olandese. In salita le università asiatiche: Tokyo passa al 22esimo posto, seguita al 24esimo da Hong Kong. Ci sono anche Sud Corea e Singapore in classifica, oltre alla Tsinghua University della Cina.
Chi non si è voluto tirare indietro dal commentare la mediocrità delle performance delle università italiane è stato il responsabile del Miur, Mariastella Gelmini: “la classifica del Times conferma clamorosamente – ha detto il Ministro – quello che abbiamo sempre sostenuto, cioè che il sistema universitario italiano va riformato con urgenza”. Un bell’assist, insomma, per avallare le scelte fatte dal Governo in tema di istruzione post-diploma. “Siamo agli ultimi posti nelle classifiche mondiali per questo motivo – annuncia Gelmini – presenteremo a novembre la riforma dell`Università, con l`obiettivo di promuovere la qualità, premiare il merito, abolire gli sprechi e le rendite di posizione“.
Per il Ministro la bassa qualità delle nostre facoltà non è legata alla mancanza di risorse pubbliche: “il problema, come ormai hanno compreso tutti, non è quanto si spende (siamo in linea con la media europea) ma come vengono spese le risorse destinate all`università. Spesso per aprire sedi distaccate non necessarie e corsi di laurea inutili. Tutto questo deve finire. Mi auguro – conclude Gelmini – di non dover più vedere in futuro la prima università italiana al 174° posto“.
Per il Ministro la bassa qualità delle nostre facoltà non è legata alla mancanza di risorse pubbliche: “il problema, come ormai hanno compreso tutti, non è quanto si spende (siamo in linea con la media europea) ma come vengono spese le risorse destinate all`università. Spesso per aprire sedi distaccate non necessarie e corsi di laurea inutili. Tutto questo deve finire. Mi auguro – conclude Gelmini – di non dover più vedere in futuro la prima università italiana al 174° posto“.
Poco dopo il Miur ha pubblicato dei dati impietosi che, anche se riduttivi, dimostrano che le posizioni arretrate dei nostri atenei non solo del tutto casuali: basta dire che le novantacinque università italiane annoverano ben 320 sedi distaccate, 37 corsi di laurea con un solo studente e 327 facoltà che non superano i 15 iscritti. Anche la moltiplicazione dei corsi universitari sembra imbarazzante e indifendibile: “nel 2001 – fa sapere viale Trastevere – i corsi di laurea erano 2.444, oggi 5.500: in Europa sono la metà; 170.000 le materie insegnate, la media europea è di 90.000”. La desolante conclusione del Miur è che in Italia “si impiegano infatti le risorse per aumentare il numero dei corsi, delle materie e delle sedi distaccate senza puntare su una moderna didattica e senza tenere conto delle reali esigenze del mercato del lavoro“.