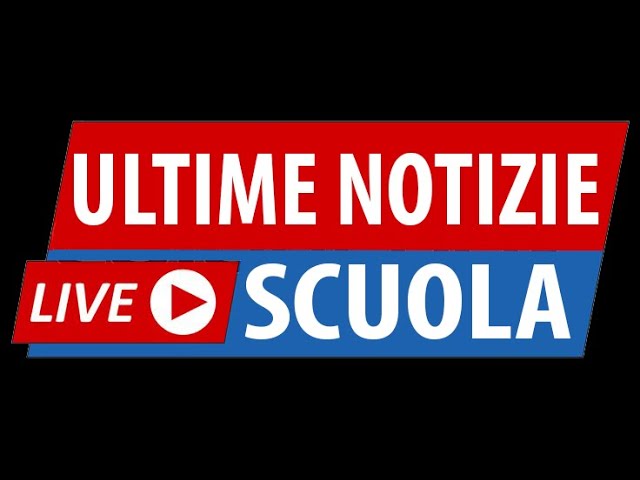Il sistema scolastico del Vecchio Continente si confronta di continuo con nuove sfide, ove la resilienza costituisce il principale valore ed elemento utile per vincerle: dal periodo pandemico ci confrontiamo con una comunità scolastica sempre meno produttiva e prestante, stressata ed eventualmente depressa, affetta da segregazione per gruppi (etnici o meno). Nelle aree interessate da importanti fenomeni di immigrazione le tensioni spesso portano interi gruppi etnici ad isolarsi; lo stesso vale per quegli studenti che, affetti da disturbi specifici dell’apprendimento o da disabilità, hanno difficoltà ad integrarsi attivamente nella popolazione scolastica di una determinata area, finendo così per essere segregati.
Il Consiglio Europeo da oltre un ventennio monitora attentamente il fenomeno su base nazionale pubblicando un rapporto annuo con valenza comunitaria: quali sono le problematiche più evidenti ed emergenti, quali le soluzioni a lungo termine e le strategie da adottare in Europa? In Italia la segregazione scolastica si sviluppa in particolare nei bacini ad alta immigrazione: in primis figurano Lombardia e Campania, che presentano alcune aree ove gli studenti stranieri costituiscono oltre il 40% della totale popolazione scolastica.
Una segregazione per gruppi: basi legali e principi da adottare
Un numero considerevole di giovani in tutta Europa frequenta scuole con un’alta concentrazione di studenti svantaggiati sulla base del loro background socioeconomico, etnico o culturale o a causa di una disabilità. La loro separazione o concentrazione in scuole e classi specifiche danneggia le loro opportunità di apprendimento e costituisce una chiara violazione del loro diritto all’istruzione e del loro diritto a non essere discriminati. L’istruzione separata dei bambini con disabilità è una pratica diffusa in tutta Europa, nonostante il fatto che l’Articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) imponga agli Stati il dovere di garantire che gli studenti con disabilità possano accedere ad “un’istruzione inclusiva, un’istruzione primaria e secondaria gratuita e di qualità, su base di uguaglianza con gli altri nelle comunità in cui vivono”.
La segregazione scolastica colpisce gravemente anche i bambini rom e nomadi in molti Stati membri. Un numero sproporzionato di loro è iscritto in classi di recupero e scuole speciali, dove ricevono un’istruzione secondo un curriculum inadeguato o ridotto. In alcuni paesi (Repubblica Ceca, Slovacchia ed Ungheria) le probabilità che i bambini rom vengano iscritti in una scuola speciale sono 27 volte superiori rispetto a quelle dei bambini non rom. Anche i bambini rifugiati e quelli con un background migratorio sperimentano la segregazione scolastica in molti paesi europei, poiché spesso frequentano scuole con una presenza sproporzionatamente elevata di altri bambini a loro volta migranti.
Soluzioni utili e strategie: presupposti utili per un’educazione inclusiva
I requisiti educativi minimi per l’inclusione sociale sono aumentati significativamente nel tempo anche su base legale. È necessario un accesso diretto e più ampio alle esperienze educative e scolastiche – sia nei settori statali che privati – affinché i giovani studenti acquisiscano le competenze necessarie per vivere e lavorare nelle società del presente. Garantire l’accesso alla scuola ai bambini appartenenti a gruppi svantaggiati non è sufficiente, né è sufficiente distribuirli in scuole diverse se queste non sono adatte ai loro bisogni e non offrono un’istruzione di qualità. Occorre monitorare con attenzione il loro inserimento, sostiene il rapporto. Ovviamente la lotta alla segregazione scolastica non può avere successo se l’istruzione non viene intesa come un servizio pubblico.
Ciò può tradursi in diverse forme di offerta educativa, anche attraverso soggetti privati. In molti paesi, gli stati finanziano le scuole private che convengono a condizioni e soluzioni specifiche, che di solito includono clausole non discriminatorie (per quanto riguarda le differenze economiche, culturali, sessuali o religiose) e la definizione delle attività educative senza scopo di lucro degli istituti. La scelta scolastica di per sé non genera inevitabilmente discriminazione. Un elevato numero di sistemi educativi fornisce istruzione a condizioni libere quasi di mercato, consentendo la scelta della scuola in circostanze specifiche. Occorre inoltre basarsi sul presupposto che tutti gli studenti possano apprendere e abbiano il potenziale per essere istruiti.