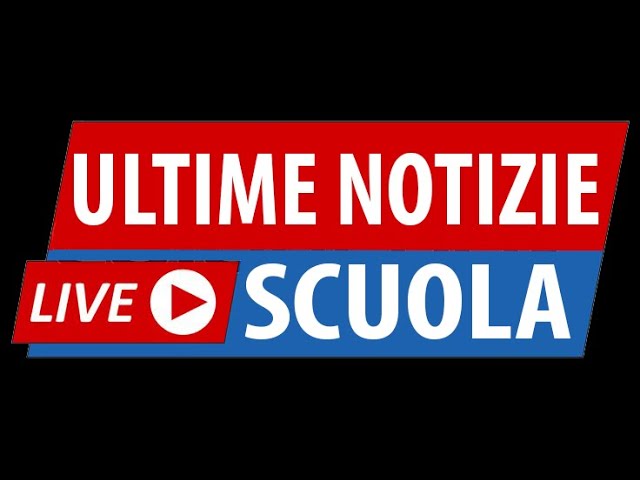L‘emergenza epidemiologica da covid-19, che nel nostro Paese ha segnato profondamente la vita quotidiana, mostrando un carattere particolarmente aggressivo nella sua diffusione e nella sua stessa letalità, ha stravolto senza preavviso le modalità di approccio alla formazione, che ha avuto come iniziale shock quello della sospensione delle attività didattiche in presenza, in tutti gli ordini e gradi di istruzione di tutte le Regioni.
L’avvicendarsi fitto di interventi ministeriali, attraverso la diramazione di DPCM, con relative note esplicative, ha gettato l’ombra dell’ignoto in un campo così profondamente radicato nella nostra tradizione che è quello del “fare scuola a scuola”. Il problema sostanziale non tanto è il venire meno dello spazio fisico, di quella garanzia spaziale rimodellabile ad ambiente di apprendimento, nel quale il docente mette a frutto tutte le sue competenze in ambito psicopedagogico e non solo, in cui entra in gioco la sua creatività, il suo desiderio di sperimentare, di ricercare soluzioni inclusive, di realizzare modalità prossemiche d’eccezione, di condurre quella che, nel gergo di settore, si definisce ricerca-azione; ma ancor più destabilizzante è la privazione dell’Esser-Ci di comunità, le assenze e le distanze da una relazione elettiva, che è quella che il docente crea con i suoi alunni.
E più piccoli sono gli alunni, maggiormente oscuro diventa il sentiero quando ad esso si affaccia lo spettro della didattica a distanza. Perché, se ci si ferma soltanto per un attimo a riflettere su questo abbinamento concettuale, ci si accorge di come risulti estremamente ossimorico, paradossale, bizzarro, accostare la forza euristica della parola “didattica” a quella puramente evocativa di “distanza”.
E come nella scena di un metateatro cognitivo, il dramma nel dramma: non c’è altra soluzione, pena l’abbandono dei nostri studenti. Le raccomandazioni diventano molteplici, tra “far sentire la vicinanza”, “evitare la mera trasmissione di compiti”, “riprogettare e riprogrammare” gli interventi.
Sbalzati dall’aula nella propria dimensione casalinga, la sensazione di smarrimento è profonda da parte di tutti gli attori del complesso processo educativo didattico formativo. Insegnanti alla deriva, famiglie allo sbaraglio, studenti in sgomento. In dieci giorni bisogna portare a compimento una rivoluzione che in più di due decenni ha camminato a singhiozzi. Ma non c’è tempo per le riflessioni, per le chiacchere, per le lamentale o le rivendicazioni, è il momento del fare, subito e bene. Entra in moto la macchina di una ricca vetrina di opportunità multimediali interattive: le piattaforme. Già, in qualunque direzione programmatica e metodologica ci si voglia dirigere, il punto di partenza è comunque obbligatorio.
Giunge il momento della scelta – obbligata- e scopri delle considerevoli possibilità, finora ignorate, che effettivamente potrebbero risultare un valido (e sottolineo momentaneo) rimpiazzo alla tua presenza. Ed in questo calcolo ragionato delle probabilità, comincia a prendere forma e senso un progetto, alla cui base vi è una traslazione del canale del messaggio, una declinazione metodologica del contesto, un clinamen tra mittente e destinatario.
Dalla comunità educante, forse neanche senza troppa consapevolezza, si giunge alla community di apprendimento. Con uno sforzo di coniugazione degli obiettivi, anche la co-costruzione dell’apprendimento stesso è salva. Si tratta di reinterpretarlo su un piano astratto, meta-fisico e ricongiungerlo alla sua idea sociale. Difatti, guardando all’iter di approccio costruttivista, anche a distanza, questo è possibile concretizzarlo. E’ una rivisitazione in chiave socio-costruttivista, in cui l’interazione, anche se priva della prossemica, può avvenire.
Non è la forma elettiva dal docente finemente imbastita nella relazione diretta con i suoi studenti, ma è pur sempre – ed ancora ricorre- un’occasione, eticamente imprescindibile.
Caterina Tripodi