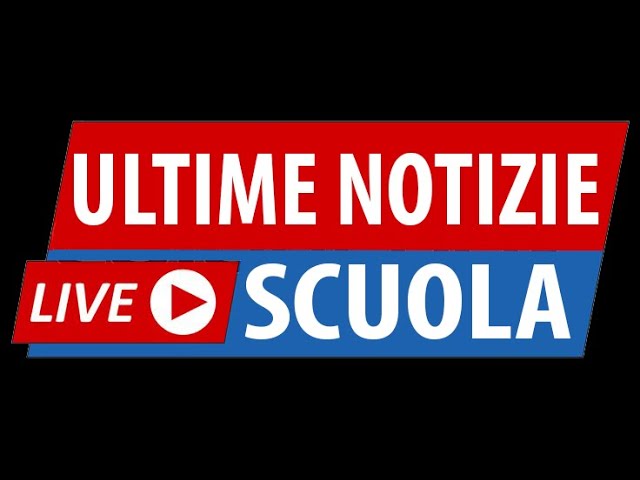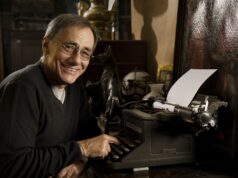“I bambini e i ragazzi di oggi sono estremamente fragili sul piano emotivo e poi non li capisco. Noi eravamo molto diversi!”. VAI AL CORSO
Docenti disorientati
Giudizi come questi sulle nuove generazioni sono abbastanza comuni e riflettono una effettiva difficoltà di lettura e un reale disorientamento di tanti insegnanti (e genitori), esasperati di fronte alle molteplici espressioni di insicurezza e fragilità emotiva manifestate dai minori di oggi, spesso ipersensibili di fronte anche ai più piccoli fallimenti o in preda a stati ansiosi molto forti e prolungati. Beninteso, le crisi legate alla crescita ci sono sempre state, adesso però sembra esserci obiettivamente qualcosa di più.
Alcuni autori hanno perfino individuato una sorta di elemento temporale discriminante di questo cambiamento nelle nuove generazioni, una di quelle date che segnano il passaggio storico e irreversibile fra un prima e un dopo: i primi anni a partire dal 2010, gli anni cioè in cui si diffondono dappertutto gli smartphone e le piattaforme digitali dei social media e, con essi, un aumento esponenziale del livello di connessione in internet e di impegno nei social da parte degli utenti, in particolare di bambini e ragazzi.
Insomma, secondo questa teoria, il problema riguarderebbe specificamente la cosiddetta generazione Z (e quelle che la seguiranno), cioè la generazione formata dalle persone che sono nate poco prima del Duemila. La Gen Z infatti è quella maggiormente investita dall’impatto di quella sorta di asteroide invisibile rappresentato dall’entrata in scena dei nuovi e potentissimi strumenti tecnologici digitali, che ha determinato due conseguenze nelle nuove generazioni: una progressiva drastica riduzione del gioco tradizionale e una iperconnessione nel mondo virtuale, con conseguente progressivo ritiro da quello reale. Da qui, il dato epidemiologico di una impennata dei casi di ansia e depressione come non si era mai registrata nelle analisi statistiche a livello mondiale. Un autore in particolare, Jonathan Haidt, con il suo libro “La generazione ansiosa”, ha puntato il dito su questo fattore socioculturale.
Diversi autori hanno considerato più che credibile questa lineare connessione causale. Per altri, invece, il fattore digitale e social è solo una delle componenti che ha contribuito a lasciare il segno sulle nuove generazioni di oggi, insieme con altri fattori comunque legati ad un aumento della complessità della realtà nella quale tutti ci troviamo a vivere. E che, per chi si trova in età evolutiva, può risultare particolarmente disorientante o perfino destabilizzante.
C’è infatti chi ritiene che ciò che determina un effettivo stato di destabilizzazione nello stato psicologico dei minori sia in realtà proprio questo: un oggettivo, smisurato aumento delle possibilità di scelta, che conduce ad una sorta di più densa angoscia esistenziale. Ciò comporterebbe insomma la necessità di prendere più (e più importanti) decisioni rispetto a quanto non avvenisse nei decenni precedenti e questa condizione determinerebbe a sua volta sempre più frequentemente stati emotivi e patologie come i disturbi d’ansia, il ritiro sociale, la fuga nel virtuale, il senso di solitudine, per citare solo alcune fra le manifestazioni più frequenti di disagio psicologico oggi. Troppa possibilità di scelta, insomma, e da lì il tentativo di fuga disperata dall’assunzione di responsabilità e dalla decisione tout court.
C’è poi chi rovescia totalmente il quadro e punta l’indice invece sulla fragilità proprio degli adulti, incapaci di essere un punto di riferimento educativo efficace per nuove generazioni alle prese con questo enorme aumento di complessità nelle relazioni e nelle condizioni di vita di oggi. Adulti troppo narcisisticamente centrati sulla realizzazione di sé e sull’anestetizzazione delle proprie paure educative, con il conseguente tentativo di controllo costante e maniacale dei minori; controllo velleitario da una parte e a sua volta foriero di ulteriori future insicurezze e paure in bambini e ragazzi. Per lo stesso motivo, sempre secondo questa ipotesi, si assisterebbe al fenomeno della tensione ossessiva al successo (rigorosamente senza traumi) dei propri figli, all’obiettivo reiterato di fargli bruciare le tappe, magari preparandoli con eccessivo anticipo, rispetto al loro fisiologico processo di crescita, al mondo concorrenziale e spietato, a loro dire, che verrà.
Una cosa appare certa: se le nuove generazioni rischiano di apparire oggi sempre più una sorta di mistero a chi svolge una funzione educativa, rischia anche di aumentare la probabilità dell’errore educativo, attraverso una sottovalutazione o misinterpretazione dei segnali e dei problemi che essi annunciano, della mancata lettura dei reali disagi che (dati epidemiologici alla mano) comunque si manifestano, oggi, effettivamente, più di prima.
Il corso
Su questi argomenti il corso Leggere il disagio nascosto dei nostri giovani, in programma dal 5 giugno, a cura di Giovanni Morello.
Preparati con La Tecnica della Scuola
La Tecnica della Scuola, ente di formazione accreditato dal ministero dell’Istruzione e del Merito, offre un’ampia offerta formativa tra webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole e corsi di preparazione ai concorsi.
I nostri webinar
LA CERTIFICAZIONE EIPASS STANDARD
TRANSIZIONE DIGITALE, SCEGLI IL PERCORSO PER LA TUA SCUOLA
Dop: strategie di intervento in classe
ChatGpt-4o: potenzialità, questioni etiche e impatto sulla didattica
Insegnare nella classe complessa
Dinamiche di classe, inclusione e insegnamento
Grammatica valenziale: teoria, metodologia e progettazione didattica
Fare scuola in natura. Teoria e pratica dell’outdoor education