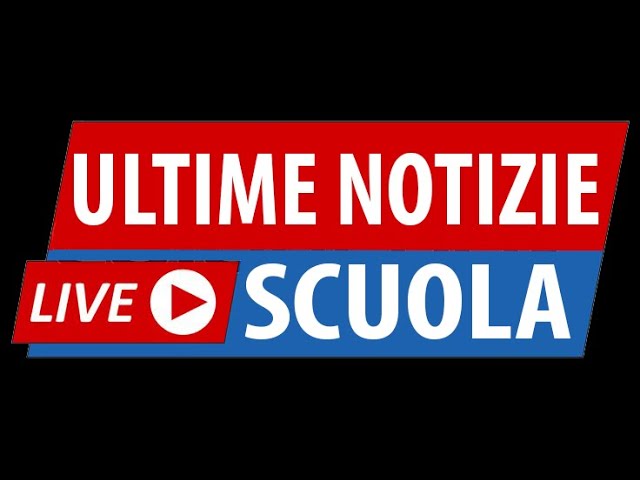Riceviamo e pubblichiamo un contributo relativo alla prima prova dell’esame di Stato 2024 da parte del prof. Salvatore Distefano, già insegnante di Storia e Filosofia nei licei classici:
“Ho letto le tracce della Prima prova scritta degli Esami di stato (non è più Esame di maturità dal 1999, ma – quasi – nessuno se ne è accorto!) e non vi nascondo una certa preoccupazione, visto il livello di ambiguità delle tracce proposte per alcune tipologie agli/alle esaminandi/e lo scorso 19 giugno.
Per carità di patria, non mi soffermerò sulle discussioni stucchevoli e insopportabili che precedono gli Esami e riempiono le trasmissioni televisive facendo crescere l’audience e rimpinguando il portafoglio dei bravi presentatori, vero e proprio vuoto chiacchiericcio che lascia il tempo che trova e che si risolve, per chi non ha perso la fede, nella beatificazione di Venditti, autore di “Notte prima degli esami”.
Le tracce hanno un chiaro riferimento all’attualità, anche se questo ingenera qualche sospetto: quello di voler orientare la riflessione in una certa direzione, non sempre disinteressata. Ad esempio, Ungaretti (rientrato in Italia nel 1914; fervente interventista, si arruola volontario e tra il 1915 e il 1918 combatte sul fronte del Carso; dopo la guerra diventa corrispondente da Parigi del “Popolo d’Italia”) e il tema di Storia hanno come filo conduttore la questione della guerra, peraltro confermato con entusiasmo (sic!) da Aldo Cazzullo sul “Corriere della Sera” di venerdì 21 giugno u. s. Scrive il Nostro: “Ungaretti invece (si riferisce a Montale, ndr) in guerra si scopre italiano e si scopre poeta. Amava l’Italia, ma non c’era mai stato: eppure parte volontario, e nei suoi versi restituisce sia l’epica della guerra, sia il dolore”. Anche se in modo più sfumato, il tema della guerra è presente nell’opera di Luigi Pirandello Quaderni di Serafino Gubbio operatore, poiché la prima edizione del romanzo è del 1915, anche se la traccia ministeriale si riferisce all’edizione del 1925, e le macchine che incombono minacciose sull’orizzonte sono quelle belliche, in un’atmosfera pervasa da fremiti dannunziani e futuristi. In verità, i venti di guerra che attraversarono la penisola al momento della stesura del romanzo non sembrano lasciar un segno significativo nel testo, nel quale soprattutto si intravvede il contrasto tra civiltà tecnologica e umanistica (potremmo dire la Kultur e Zivilisation di Thomas Mann), tra cinema e teatro, tra condizione materiale ed esistenza alienata, nonché una piccola spia di autobiografismo pirandelliano: Serafino è un intellettuale con aspirazioni umanistiche, autodidatta nel tentativo di passare dagli studi tecnici ai classici.
E veniamo al tema di Storia, per il quale è stato scelto un testo tratto da Giuseppe Galasso, Storia d’Europa, vol. III, Età contemporanea, CDE, Milano, 1998, pp. 441-442, un brano abbastanza lungo, che in gran parte ripropone l’analisi magistrale svolta da Hobsbawm ne Il secolo breve, nel quale si evidenzia, pur in una drammatica situazione di scontro tra lo schieramento capitalista – a guida statunitense – e il campo socialista – a guida sovietica -, l’aspetto “positivo” della guerra fredda e dell’equilibrio del terrore in virtù dei quali è stata evitata la distruzione dell’umanità. Ed è sulla base di queste premesse che continua il ragionamento dello storico Galasso, il quale pone la questione di cosa avrebbe potuto succedere nel quadro della guerra fredda e dell’equilibrio del terrore (sottolineatura mia), se ci fosse stata la proliferazione di un siffatto tipo di armamenti: “Che cosa sarebbe potuto accadere se essi fossero venuti nella disponibilità di un gran numero di paesi e, soprattutto, se si fossero ritrovati nelle mani di leaders che non fossero quelli di grandi potenze aduse a una valutazione globale dei problemi politici mondiali e continentali e fossero, invece, fanatici o irresponsabili o disperati o troppo potenti in quanto non soggetti al controllo e alle limitazioni di un regime non personale e alle pressioni dell’opinione pubblica interna e internazionale? La lotta contro la proliferazione delle armi atomiche e per il disarmo in questo campo divenne perciò un tema centrale della politica internazionale e vi apportò un considerevole elemento sedativo (per così dire) di eventuali propensioni a varcare la soglia del temibile rischio di una guerra atomica”.
E a questo punto sorge il problema: mentre nella prima parte della traccia si fa correttamente riferimento al bipolarismo e al concetto di “guerra fredda” coniato dal giornalista americano Walter Lippman nel 1947, il quale così volle definire lo stato delle relazioni internazionali sancito dalla Seconda guerra mondiale, e soprattutto si voleva sottolineare l’invalicabilità di una “linea rossa”, pena l’estinzione dell’umanità; al contrario, la seconda parte, quella che chiude il testo proposto, viene utilizzata come se dal 1991 ai giorni nostri non fosse successo niente e con un evidente e improvviso salto logico-temporale – non si dice che il bipolarismo è finito nel 1991 e che il mondo è passato intanto sotto il dominio egemonico di una sola superpotenza, unipolarismo, e che addirittura da qualche anno vi è uno scontro epocale per far decollare il multipolarismo, vista la crisi verticale della superpotenza americana e dell’Occidente nel suo complesso (declino?, tramonto?…) – e facendo finta di parlare del mondo di ieri, si parla dell’oggi (de te fabula narratur) e in particolare di Paesi invisi all’Occidente (“asse del male”, “stati canaglia”, ecc.) che si pensa di colpire mettendo in preventivo anche il conflitto atomico con annessa carneficina ai danni dell’intera umanità. Tutto ciò, non c’è bisogno di dirlo, per salvare la civiltà, la libertà, la democrazia, e via elencando. Viene operata in tal modo una vera distorsione perché si chiede (sarebbe meglio dire si suggerisce) agli/alle esaminande/i una risposta che dovrebbe riferirsi al passato, peraltro immodificabile sul piano fattuale, mentre in realtà le argomentazioni, coerenti per il periodo storico preso in esame dal grande storico napoletano, diventano tendenziose se vengono utilizzate per l’attualità in quanto portano chi affronta la prova a pensare come possibili azioni estreme (leggi interventi con armi atomiche) verso come dicevamo “ […], fanatici o irresponsabili o disperati o troppo potenti in quanto non soggetti al controllo e alle limitazioni di un regime non personale e alle pressioni dell’opinione pubblica interna e internazionale? […]”.
Ecco perché, a mio avviso, in questo modo si rende un pessimo servizio alla Storia perché non è così che si attualizza (“usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici locali, regionali, continentali, planetari”; “individuare e descrivere persistenze e mutamenti: continuità, cesure, decadenza, crisi, transizione, […]”); non è così che si alimenta e favorisce il pensiero critico delle nuove generazioni, che vengono, anzi, spinte verso un’insopportabile irreggimentazione conformista, e non è così che si lotta per la pace perché si tende a far diventare “normale” e ineluttabile l’orrore della guerra, soprattutto quella atomica”.
Salvatore Distefano