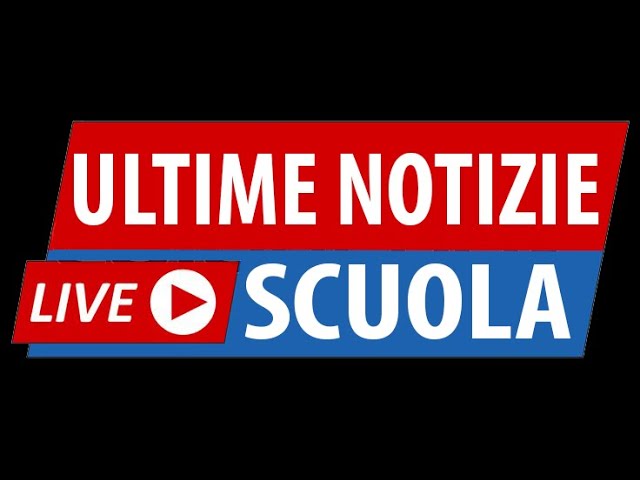Riceviamo e pubblichiamo un contributo relativo alla seconda prova dell’esame di Stato 2024 da parte del prof. Salvatore Distefano, già insegnante di Storia e Filosofia nei licei classici:
“Minosse o Sulla legge fu inserito dal grammatico Trasillo nella 9a e ultima delle tetralogie, che comprendono le 36 opere di Platone (34 dialoghi, l’Apologia e le Lettere) ordinate in gruppi di quattro. Della 9a tetralogia fanno parte, oltre Minosse, le Leggi, Epinomide, Lettere.
È noto che alcuni dialoghi e una raccolta di Definizioni rimasero fuori dalle tetralogie di Trasillo perché già ritenuti spuri dall’antichità. Ma anche tra quelle inserite nelle tetralogie ci sono opere considerate spurie, come ad esempio il Minosse. Ci fu un periodo nell’Ottocento, soprattutto in Germania, nel quale in virtù dell’atetesi (come viene chiamata la negazione dell’autenticità di un’opera) solo pochi dialoghi platonici furono giudicati autentici. Dunque, si pose il problema di definire i criteri per stabilire l’autenticità degli scritti platonici. Ecco quali sono a giudizio degli studiosi: la tradizione, le testimonianze antiche, il contenuto dottrinale, il valore artistico, la forma linguistica; tutti questi criteri offrono una certa sicurezza solo se controllati l’uno con l’altro e se si confermano a vicenda. Comunque, sulla base di questi criteri, si possono con certezza chiamare spuri i seguenti dialoghi: Alcibiade II, Ipparco, Amanti, Teagete, Minosse.
Prima conclusione: Minosse è un dialogo di scuola platonica, ma non è di Platone; non per caso, da molti autori è ritenuto spurio, soprattutto a motivo di alcune contraddizioni interne e di una certa qual sproporzione fra la semplicità della forma e la rilevanza dei temi filosofici dibattuti. In ogni caso, è un dialogo, lo ribadiamo, di ispirazione platonica – per i frequenti punti di contatto col Simposio, col Politico e soprattutto con le Leggi e per la tendenza presente nella scuola platonica di rivalutare la legislazione cretese (In epoca recente molti studiosi hanno avanzato l’ipotesi che una sola dinastia composta da re-sacerdoti abbia regnato sull’isola. Il re cretese era il sommo rappresentante della divinità, figlio adottivo sulla terra della Grande Madre, ed esercitava uno stretto controllo su tutte le attività).
Un’ultima informazione: la data di composizione è quasi certamente anteriore al 350 e dunque alcuni anni prima della morte di Platone (nel 347 a 81 anni).
Guardiamo ora con maggiore acribia il dialogo e il brano scelto dal Ministero
Tranne qualche insidia – il participio eiremenon lontano dal sostantivo enkomion; e paideuthesomenon participio futuro passivo con valore finale (“per essere educato”) -, il testo non era difficile (Canfora, La Stampa di venerdì 21 giugno: “E’ molto scorrevole. […] E’ alla portata dello studente medio”) e quindi vorrei entrare nel merito, ma in questo caso esprimere un’opinione diversa da chi che non ha visto nella scelta riferimenti all’oggi “Non ci sono particolari agganci con l’attualità”, mentre a mio avviso gli agganci ci sono perché il dialogo tratta, guarda caso, della giustizia.
Il testo da tradurre è preceduto da un pre-testo, ma gli esperti che hanno scelto la traccia avrebbero dovuto, a mio parere, porre come pre-testo ciò che viene affermato nelle righe precedenti rispetto alla parte scelta, perché lì si afferma esplicitamente la centralità dell’uomo (tema fondamentale del dialogo di scuola platonica): 319 A “E l’uomo simile a dio è l’uomo buono. Per altro verso, non devi pensare (è Socrate che parla, ndr) di poter attribuire carattere sacro a pietre, legni, a uccelli e serpenti, piuttosto che all’uomo, in quanto fra tutto ciò che esiste è l’uomo virtuoso l’essere più santo, come l’uomo malvagio è quello più impuro.” Il pre-testo della traccia ministeriale [319 B] è la continuazione del brano da me citato, brano che avrebbe chiarito meglio il ragionamento di Socrate e avrebbe favorito una interpretazione più aderente al pensiero platonico (non dimentichiamo che nella Politeia, in particolare nel I libro quello dove gioca un ruolo di rilievo Trasimaco di Calcedonia, Platone confuta l’istanza sofistica che vorrebbe ridurre la giustizia al diritto del più forte e oppone la tesi che la giustizia è condizione fondamentale della nascita nonché della vita dello Stato).
Ma allarghiamo il quadro per poter vedere meglio il contesto (hegelianamente “Il vero è l’intero”) nel quale inserire la riflessione platonica, anche se il dialogo (lo ripetiamo) non è considerato autentico. Diciamo subito che è quello tipicamente platonico per ciò che riguarda il problema del rapporto tra il nome e la cosa, cioè la questione del linguaggio (pensiamo in particolare al Cratilo): le parole corrispondono alla realtà, ci dicono veramente qual è “la realtà effettuale?” Perché se è vero che la legge, sostiene Socrate, tende sempre alla scoperta di ciò che è la realtà, gli uomini dovrebbero servirsi sempre delle stesse leggi; ma ciò non è vero e questo vuol dire che non sempre le leggi sono in grado di scoprire quello che la stessa legge esige, cioè “dire” la realtà. Viene posto qui, seppure in modo sintetico e senza particolare approfondimento il dilemma sulla verità (e il correlato oggettivo della verità non può più venir costituito da un essere a sua volta unitario e indifferenziato; deve invece articolarsi nella pluralità ordinata della realtà oggettiva), nella dialettica tra doxa ed episteme, tra mondo sensibile e mondo intellegibile, richiamando l’intreccio tra ontologia e gnoseologia. La risposta è illuminante: il miglior legislatore è il re [317 D] perché è sapiente e la sua sapienza deriva da Zeus (sophistés), che è un dio sapiente che ha educato Minosse, “l’unico figlio di Zeus che Zeus abbia personalmente educato”, il quale ogni nove anni si fermava a conversare con Zeus “per essere educato”. Alle corte: Minosse ricopre quel ruolo non per una investitura “dall’alto”, per una trasmissione ereditaria, bensì perché è stato “educato” da Zeus “di persona personalmente” e dunque sapiente, dato che la sapienza del maestro diventa la sapienza del discente. È il sapere l’elemento dirimente, grazie a cui si afferma una forma di uguaglianza e di unità della polis (la famosa katabasis del I libro della Politeia).
Questa lettura consente, a mio avviso, di raffreddare i facili entusiasmi di coloro che, ancora oggi, non vedono l’ora di ripristinare gerarchie dinastiche, preconizzare con impazienza l’accentramento per dominare e brigano per autoincoronarsi con l’intendimento di sottomettere gli altri per perpetuare le in-giustizie: per i platonici , al contrario, i re dovranno essere i filosofi, i filosofi-re, e giusta (ecco di nuovo il problema della giustizia) è l’anima in cui governa la parte razionale “con il consenso di quella emotiva e di quella desiderante”, e giusto risulterà il loro governo. Giustizia allora vuol dire governo sulla base dell’interesse comune con il consenso delle varie parti. La giustizia produrrà, quindi, quell’armonia, quella concordia, quella “sinfonia” in cui consiste la felicità personale collettiva.
Un’ultima considerazione: il riferimento a Omero, e in parte a Esiodo, dimostra la raffinatezza intellettuale dei platonici che si appoggiano, nelle loro argomentazioni, all’autorità dei padri della letteratura greca. [319 B] “Non per altro, dunque, sulla scia di Omero e Esiodo, io parlerò bene di Minosse, ma per impedire che un uomo generato da uomini commetta errori parlando di un eroe figlio di Zeus”. [319 C] “Queste brevi parole di lode rivolte a Minosse, Omero non le riservò mai a nessun altro eroe. Ora, il nostro poeta afferma spesso e in più occasioni – e anche qui lo ribadisce – che Zeus è un dio sapiente, e che la sapienza è un’arte in sommo grado bella.”
Ciò significa che è il mito a diventare la base della spiegazione storica. E mi vien fatto di pensare a Oswald Spengler che ne Il tramonto dell’Occidente scriveva: “Ma la civiltà antica non ebbe una memoria, un organo storico in questo speciale senso. […] Per cui, in essenza, la storia antica fino alle guerre persiane è, non meno delle costruzioni tradizionali di periodi assai più tardi, un prodotto del pensiero mitico. […] e ancor al tempo dei Cesari non si era finito di inventare la storia romana prima di Annibale.”
Tutto ciò dimostra, come dicevamo all’inizio della nostra riflessione, la rilevanza filosofica del dialogo e l’importanza del pensiero di Platone e della sua scuola sia per gli antichi che per i moderni.
Salvatore Distefano