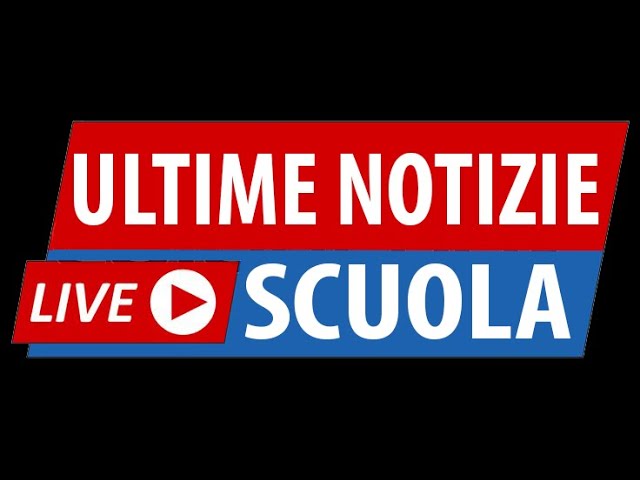Sono amate, odiate, a volte vissute con l’indifferenza che scaturisce dall’ineluttabilità di essere nati lì e non altrove. C’è chi vuole scappare verso orizzonti più tranquilli e chi – da questi orizzonti tranquilli – aspira a trasferirsi proprio nel centro vertiginoso del mondo. Sono le grandi città, le metropoli da milioni di abitanti – Milano, Roma, Napoli, Palermo – spesso al centro dell’attenzione dei media e dei popolari contenitori televisivi pomeridiani soltanto per i loro lati oscuri: grande e piccola criminalità, caos e immondizia, trasporti e servizi da terzo mondo e chi più ne ha.
Ma le grandi città possono anche essere fucine di ingegni, laboratori di ricerca per l’innovazione, la coesione sociale, la lotta all’esclusione. In altre parole potremmo dire, per sintetizzare, cantieri per una rigenerazione urbana.

Proprio di questo parleremo oggi con Sara Ebreo, architetto e rigeneratrice urbana, per l’appunto, che opera in una delle grandi città italiane tra le più complesse, una città in cui le ombre sembrano sovrastare le luci: Palermo.
Giovanissima, a 28 anni l’architetto Ebreo è una delle figure di punta, per il suo lavoro sul terreno con i più giovani, nel quadro del progetto “Traiettorie urbane”.
Come si può leggere sul suo sito, Traiettorie urbane è un progetto integrato che mira alla promozione della crescita sociale e al benessere educativo di ragazzi e ragazze tra 11 e 17 anni coinvolgendo le comunità educanti di diversi quartieri disposti su due assi della città di Palermo. Il progetto propone un modello di offerta educativa, culturale e sportiva costruita con e da giovani per i/le giovani che ne fruiscono, principalmente in ambito extrascolastico, ma costruendo alleanze generative con scuole del territorio.
I promotori del progetto sono molteplici, in prima fila l’Associazione Mare Memoria Viva e Fondazione EOS Edison Orizzonte Sociale in partenariato con l’Istituto Valdese, alcuni Istituti comprensivi, il Comune di Palermo e altri enti e associazioni. Il progetto si sviluppa su due assi urbani che insistono su alcuni quartieri che – come dice Sara Ebreo – hanno una cosa che li accomuna: essere dei satelliti dentro lo stesso pianeta urbano.
Architetto Ebreo, come nasce il progetto Traiettorie urbane?
È iniziato l’anno scorso, nel 2022, ha durata triennale ed è stato selezionato da Fondazione Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione EOS Edison Orizzonte Sociale.
Lei che ne è parte integrante, come definirebbe questo progetto?
Traiettorie urbane si può definire come un progetto integrato e di integrazione. Integrato perché mira alla crescita sociale e al benessere educativo di ragazzi e ragazze tra 11 e 17 anni coinvolgendo le comunità educanti e proponendo un modello innovativo di offerta educativa, culturale e sportiva costruita per i giovani e soprattutto con i giovani. Di integrazione perché al centro del progetto si instaura quella che dovrebbe essere una sana sinergia tra gli Enti del terzo settore e gli enti pubblici e istituzionali quali Uffici Territoriali comunali e regionali, le scuole di ogni ordine e grado e la pubblica amministrazione.

Qual è il suo ruolo all’interno del progetto?
Mi occupo principalmente della cosiddetta “mappatura territoriale”, a partire dalla quale ho condotto una ricerca – con la collega architetto Valentina Mandalari – sulla “città degli adolescenti”. La mappatura è partita da una domanda di base: chi sono, dove stanno e soprattutto come vivono i ragazzi e le ragazze tra gli 11 e i 17 anni in questa parte di città complessa e sensibile?
Cosa si intende, esattamente, per mappatura territoriale?
In estrema sintesi, è una sorta di analisi e ricostruzione del territorio, attraverso la percezione dei giovani, degli adulti, delle istituzioni socio-culturali che lo abitano. Metodologicamente parlando, è stata eseguita una mappatura top down, nella quale abbiamo intervistato stakeholders, scuole e soggetti attivi per comprendere quali fossero i servizi e le opportunità offerte all’adolescenza in questa parte di città e una mappatura bottom up svolta direttamente con i beneficiari attraverso passeggiate urbane, mappature partecipative percettive e interviste peer to peer.

Quanti ragazzi partecipano al progetto? Quali sono i risultati del vostro lavoro?
Sono circa 200 ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 17 anni. Con loro, come dicevo, abbiamo lavorato molto sulle percezioni emotive che hanno del proprio quartiere. Su questa scia abbiamo continuato a elaborare quello che nella nostra pratica di educatrici al patrimonio e alla consapevolezza urbana già facciamo da anni. Ci siamo, cioè, domandati: “come si proiettano i ragazzi nei confronti dello spazio che attraversano e che vivono? Come si connettono con lo spazio che li circonda? Come si muove il corpo nello spazio? Abbiamo cercato, attraverso delle passeggiate svolte nei mesi di aprile e maggio di quest’anno, di mettere nero su bianco le nostre emozioni: paura, rabbia, felicità, indifferenza, stupore, disgusto. Cercando di conoscerci e di conoscere anche un po’ quello spazio di congiunzione tra il centro e la periferia. Cercando di stare nelle cose, considerando che la memoria degli spazi che si vedono o si attraversano dà un senso delle cose ben preciso nella scatola neuronale che porta a trasformare quello spazio in luogo, che porta l’adolescente a concepire un luogo più sicuro rispetto a un altro, più accogliente o più escludente.
In buona sostanza, si può affermare che questa ricerca non finirà mai?
Sì, si può dire così. Lo studio condotto è, infatti, una ricerca in divenire, abbiamo lasciato un capitolo aperto alle nuove sollecitazioni, i ragazzi continueranno a dare nuovi stimoli e nuove visioni di cambiamento per una città adolescente che si comporta troppo spesso da adulta.