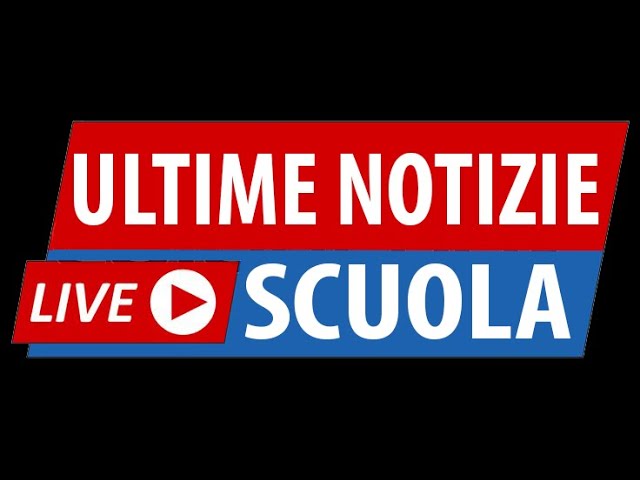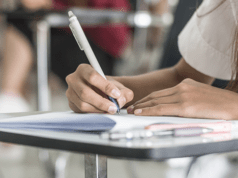La correlazione fra status, e corrispondente retribuzione economica, degli insegnanti e livello economico politico e culturale di uno Stato è un dato acquisito e incontrovertibile. L’Italia per ragioni storiche, in buona sostanza il frazionamento politico e l’invadenza clericale, è stata l’ultimo dei grandi Paesi europei a preoccuparsi dell’istruzione popolare e a darsi una politica scolastica.
Il peso di questo ritardo si è fatto sentire fino ai primi decenni del Novecento assicurando al Paese il poco invidiabile primato dell’analfabetismo insieme a quello degli insegnanti elementari peggio formati e peggio pagati dell’Europa occidentale. Solo dopo gli anni Venti del secolo scorso si verificò una rapida inversione di tendenza che finì per portare la scuola italiana, a tutti i livelli, al vertice delle graduatorie mondiali mentre la ricerca scientifica conseguiva eccezionali risultati e si rinvigorivano il tessuto economico e il potenziale industriale del Paese.
Il passo decisivo per la realizzazione di quel traguardo non furono tanto le riforme degli ordinamenti quanto gli interventi sulla formazione, la selezione, lo stato giuridico e soprattutto gli stipendi degli insegnanti. Dopo il primo decennio postbellico è cominciato un lento smottamento della scuola italiana con il progressivo affermarsi di ideologie confuse e contraddittorie che in nome della scuola di massa, dell’egualitarismo sociale, della centralità dell’alunno, della partecipazione e così via oscurarono completamente la figura e il ruolo del docente e mortificarono l’originalità del rapporto educativo sminuendo l’importanza delle competenze disciplinari, lasciando incancrenire il sistema di reclutamento e di fatto abolendo qualsiasi tipo di selezione.
A partire dalla fine degli anni Sessanta, col crescere del potere del sindacato e l’ingresso della sinistra nella stanza dei bottoni, le retribuzioni del docente, con l’eccezione significativa dei professori universitari, iniziarono a scendere paurosamente in termini relativi e col levitare di quelli di magistrati, dipendenti di Enel, Eni, enti locali e parastatali e, ultimi, militari, si ponevano le premesse di quella giungla retributiva denunciata da Ermanno Gorrieri nel 1972.
È così che l’insegnante ha finito per occupare l’ultima posizione nel pubblico impiego, appaiato ai dipendenti pubblici e privati meno qualificati, perdendo, in un sistema che misura lo status col denaro, quel prestigio sociale che è anche segno della maturità di un Paese. Questo processo parte quindi da lontano, ma negli ultimi anni, chiusa la breve parentesi dei governi di centro destra che avevano fatto registrare una lieve inversione di tendenza, è diventato drammaticamente evidente e altrettanto drammaticamente correlato con il generale arretramento economico, sociale, politico e culturale del Paese.
Una correlazione che nessuno nega ma che i politici risolvono nella retorica di proclami astratti e generici mentre i sindacati la confondono nel polverone del diritto allo studio, dell’edilizia scolastica e della condizione di non meglio identificati lavoratori della scuola. Deve essere invece chiaro che dignità e decoro della scuola comportano la restituzione al docente, al docente e non a un generico personale della scuola, la centralità che gli spetta.
Deve essere chiaro che la scuola non la fanno né i dirigenti né il personale amministrativo né i bidelli, fermo restando che nessuno mette in dubbio la dignità del loro come di ogni altro lavoro né l’importanza delle loro mansioni per il suo buon funzionamento . Ma, con tutto il rispetto che si deve loro come a tutti i lavoratori, ai quali tutti deve essere garantito il diritto ad una retribuzione che consenta un’esistenza dignitosa, è stupida demagogia e faziosità partigiana non riconoscere il dato ovvio che la scuola la fa l’insegnante, che l’insegnante in una società avanzata non è un impiegato d’ordine ma un professionista altamente specializzato, che la scuola funziona se vi sono buoni insegnanti e, infine che la scuola è tout court l’insegnamento e il resto, dirigenti compresi, è solo supporto all’insegnamento.
Deve essere anche chiaro che la giusta rivendicazione del docente alla retribuzione che gli spetta, la stessa di quella degli altri Paesi avanzati, non mira soltanto a sanare una situazione aberrante, una palese ingiustizia e un vero e proprio furto, ma è la condizione per restituire alla scuola italiana la posizione che ha perduto e per rimettere in moto la società italiana.
A parole tutte le forze politiche e il governo nazionale riconoscono, e non potrebbe essere altrimenti, la verità di questa relazione ma nei fatti accade che le prime hanno completamente accantonato il problema della scuola e si limitano a uno sterile piagnisteo sulle condizioni generali del Paese, il secondo prende provvedimenti che ne segnano il de profundis. Il governo si è impantanato sulla questione del precariato, ha pasticciato senza concludere niente sulla formazione e sulla selezione e ora finisce la sua opera distruttiva con un provvedimento che mira a svilire ulteriormente i docenti e a dividerli gettando loro un osso perché si accapiglino per impadronirsene e si distolgano dall’unico obiettivo serio, che è quello di costringere l’esecutivo ad un approccio responsabile al problema dello status dell’insegnante italiano, che non ha bisogno di chiacchiere ma di un contratto che gli restituisca il maltolto e ne allinei la retribuzione non solo e non tanto a quella dei suoi colleghi europei ma al personale laureato e con funzioni dirigenziali all’interno della pubblica amministrazione.
L’idea di identificare gli insegnanti migliori e di premiarli è una colossale bufala, un trucco per sviare l’attenzione dal fatto che l’Italia paga bene o benissimo i suoi politici, i magistrati, gli universitari, i dirigenti, i vertici militari nonostante la corruzione nella politica, l’inefficienza della magistratura, l’incapacità e l’irresponsabilità dei dirigenti e il collasso della macchina amministrativa, l’inutilità dichiarata delle forze armate, e non paga quelli che ne debbono garantire il futuro e la sopravvivenza.
Nessuno si oppone all’idea di identificare gli insegnanti incapaci e destinarli ad altre mansioni. Bisogna, infatti, che i politici, l’opinione pubblica, il governo prendano atto che in linea di principio non ci possono essere cattivi insegnanti così come non ci possono essere medici incompetenti, perché tollerarne la presenza significa mettere a repentaglio la vita delle persone o di negare ai giovani il diritto ad una formazione seria. L’insegnante, in quanto tale, deve essere competente ed è responsabilità precisa delle istituzioni far sì che non ci siano eccezioni rispetto a questo principio: lo debbono fare attraverso il sistema formativo, il sistema di reclutamento e un sistema di monitoraggio.
In questa prospettiva l’idea di identificare e premiare gli insegnanti più bravi è una clamorosa sciocchezza Una sciocchezza che nasce dalla confusione fra due piani, quello della soggettività e quello della misurazione. Ogni insegnante si distingue da qualsiasi altro e sicuramente vi sono insegnanti più bravi, più preparati o con maggiori competenze relazionali di altri. Ma quello che l’insegnante è in sé è inaccessibile e a ben vedere privo di interesse. Perché l’insegnante è tale in una relazione, che non è una cosa ma un farsi fluido e cangiante che si scompone tante volte quanti sono i soggetti che la definiscono; l’insegnante non è mai bravo in assoluto: lo è per alcuni ma non per tutti e anche se lo fosse stato fino ad oggi non c’è alcuna garanzia che lo sia anche in futuro. Insomma: né una generica bravura, né le più definite competenze professionali sono dato oggettivo, qualcosa che uno si porta dietro come un bagaglio.
Al massimo si potrebbero premiare quelli che hanno più titoli andando però incontro a facili obiezioni: se si pensa che più titoli siano meglio del solo titolo di accesso allora si dovrebbe consentire l’accesso solo con quei titoli in più. Altri criteri, come dimostrano i fallimenti del passato semplicemente non ce ne sono: pensare che sia più bravo un insegnante disponibile per le supplenze o che ha ricoperto una carica elettiva o ha partecipato ai PEI (partecipazione peraltro obbligatoria) è semplicemente umoristico. Resuscitare i concorsi per merito distinto, comunque sempre meglio di quei criteri, rappresenterebbe un onere non giustificato dal risultato: un tema o un colloquio non danno alcuna risposta riguardo alla professionalità.
Quando si sostiene che non è possibile stabilire seriamente quali sono gli insegnanti più meritevoli perché non esistono criteri di misurazione del merito non si intende sfuggire al controllo e alla valutazione. Al contrario: il monitoraggio, che comporta ovviamente controllo e valutazione, è una condizione per evitare derive localistiche o personalistiche nelle strategie formative e mantenere, nel rispetto della libertà dell’insegnamento, standard educativi di carattere nazionale. Ma è anche lo strumento per evitare che gli studenti rimangano affidati a persone che per motivi diversi non sono o non sono più all’altezza del compito loro assegnato. Non è un mistero che la professione docente comporta uno stress psicologico che non tutti sono in grado di sostenere per tutto l’arco della loro attività professionale e neppure è un mistero che anche i più efficaci sistemi di selezione non sono filtri perfetti: vi sono nella scuola oggi come nel passato insegnanti privi di competenze disciplinari, insegnanti competenti ma incapaci di comunicare, insegnanti caratterialmente o per disturbi della personalità inadatti al ruolo.
Per il bene della scuola questi soggetti devono essere identificati, se possibile sostenuti con provvedimenti adeguati o altrimenti destinati ad altre mansioni. Per concludere: se è vero che è pura utopia la pretesa di stabilire chi è migliore fra gli insegnanti è anche vero che è possibile e anzi necessario verificare che tutti gli insegnanti siano in grado di adempiere la loro funzione: la valutazione serve ed è praticabile negativamente, non positivamente. Va quindi ribadito il principio che tutti gli insegnanti ritenuti idonei debbono essere retribuiti come insegnanti meritevoli e che, sulla base del presupposto che l’esperienza arricchisca la professionalità, la progressione economica non solo va salvaguardata ma va rafforzata fino a raggiungere a fine carriera almeno il raddoppio effettivo della retribuzione iniziale.
Ma l’ultima delle preoccupazioni per il governo nazionale è la scuola, che sembra essere un’imbarazzante seccatura. E si capisce che per togliersi dall’imbarazzo questa classe politica non solo tolleri ma addirittura provochi, col controllo totale che esercita sui media, il formarsi di un’opinione avversa e di stereotipi negativi sulla scuola e sugli insegnanti, ottimo alibi per sottopagarli. Si è demagogicamente creato il mito della malasanità, ci si ingegna a costruire quello della cattiva scuola e del cattivo insegnante. Non per intervenire con provvedimenti migliorativi ma per conseguire due scopi: giustificare i bassi stipendi e le proprie inadempienze e far passare la 107 come la legge della “buona scuola”, alternativa salvifica alla “cattiva scuola”.
Ė veramente vergognoso il modo in cui sono state amplificate prima di qualsiasi vaglio le notizie sui maltrattamenti negli asili nido o il dileggio al quale sono stati esposti malcapitati insegnanti vittime di situazioni di degrado sociale e culturale al quale lo Stato non tenta neppure di far fronte. Ormai, incoraggiata anche da un certo dissennato pedagogismo, l’opinione pubblica considera la scuola come un servizio sociale, un parcheggio, gli insegnanti come badanti e l’insegnamento come un’opportunità occupazionale modesta ma appetibile perché difficile da raggiungere solo per l’enorme numero degli aspiranti; basta aspettare, poi tocca a tutti. Anche in questo caso all’origine del male sta la questione economica. Il genitore che viene a sapere che l’insegnante di suo figlio guadagna meno di lui operaio è portato a credere che effettivamente vale di meno, lo guarda dall’alto in basso e lo considera un parassita perché non passa a scuola almeno otto ore al giorno, mesi estivi compresi. In una società degradata come quella italiana sfugge completamente il valore di una professionalità che non sia legato al denaro e la proletarizzazione del docente è stata accompagnata dalla perdita di credibilità: al danno, per l’insegnante italiano, si è aggiunta la beffa.
In nessun altro paese europeo l’insegnamento è screditato come in Italia. Si è coccolato il movimento studentesco, è stata esaltata l’importanza sociale degli organi collegiali, si è gabellata per una grande conquista l’autonomia e si è lasciato che il paradigma della professione docente fosse un informe precariato anelante a un posto quale che sia, si è trasformato l’insegnamento in un gigantesco ammortizzatore sociale. C’è da chiedersi a chi giovi tutto ciò. Sicuramente intere categorie di dipendenti pubblici hanno beneficiato del depauperamento della classe docente, che ha liberato risorse per loro. Questa è la conseguenza di una politica sindacale irresponsabile e grettamente corporativa. Ma c’è anche qualcosa di più grave: una democrazia malata e vacillante come la nostra non è compatibile con una scuola rigorosa che prepari persone competenti e spiriti liberi. Vi sono e vi sono stati regimi che si sono serviti della scuola come orpello ma un regime cialtrone non ne ha bisogno, gli basta il dirigente che assicuri consenso e normalità, non gli serve l’insegnante, che nella scala sociale scivola al livello di modesto impiegato, operatore scolastico, operaio della cultura addetto ad una superficiale alfabetizzazione di massa.
In questa prospettiva il problema della formazione come quello della selezione non esistono, sono falsi problemi. In questa prospettiva è normale che si acceda all’insegnamento per caso, perché non si può aspirare a qualcosa di meglio, perché non si hanno vere competenze. Accade così che un giovane che volesse per scelta intraprendere quella che, al di là della miseria presente, resta comunque una professione affascinante, non sappia quale sia la strada, perché di fatto non esiste più alcuna strada. Dopo tante chiacchiere, progetti fumosi alla cui realizzazione non si è messo mai mano, macerie di provvedimenti iniziati e subito abbandonati, riluttanza delle università a raccordarsi con la scuola secondaria, l’unica certezza è che il governo non ha alcuna intenzione di affrontare la questione preferendo continuare ad alimentare il numero di aspiranti messi in coda come pezzenti alla Caritas in attesa di una legge che li metta in ruolo a prescindere, salvo poi lamentarsi che così diventano supplenti di ruolo, perché se cattedre non ce ne sono non possono essere inventate.
Questi sono i criteri di reclutamento nell’era di Renzi. Se non ci vogliamo ridurre ad invocare un intervento delle istituzioni comunitarie quando il collasso della scuola italiana sarà diventato un problema europeo bisogna da subito mettere mano alla formazione vincendo le resistenze e l’ottusità del mondo accademico e ad un efficace sistema di professionalizzazione post lauream che funga anche da filtro e canale per l’inserimento in cattedra, bisogna definire lo stato giuridico del docente svincolandolo dal pubblico impiego e riconoscendogli la qualifica dirigenziale che compete ad un professionista, come accade per i medici, e fissare le retribuzioni indipendentemente dalle pressioni e dalle proposte dei sindacati, non ultimi responsabili del disastro che si è creato, ma sulla base di criteri razionali e dell’importanza sociale della professione. Detto questo, è improbabile se non impossibile che questo governo, questa maggioranza, questa cultura politica siano disponibili per questa inversione di rotta. Sta ai docenti, alle associazioni di categoria, ai sindacati adoperarsi per elaborare una proposta globale di politica scolastica e cercare nel Paese di coinvolgere le forze che si impegnino per realizzarla in un quadro politico profondamente rinnovato. La scuola così com’è fa comodo all’attuale regime e non ci si può aspettare che i rimedi vengano da chi ha fatto il danno.