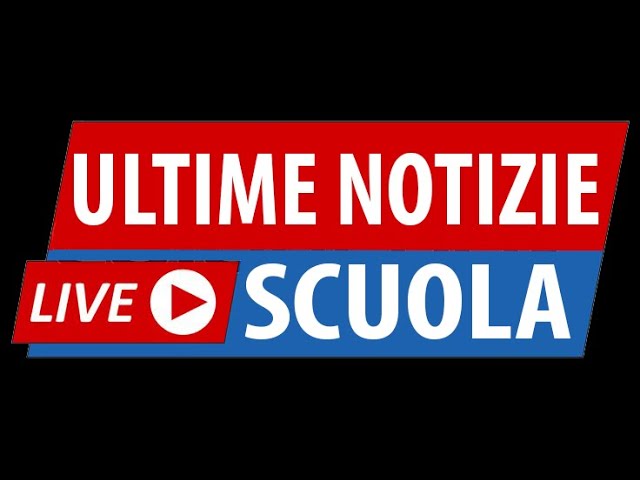Riceviamo e pubblichiamo questo articolo del nostro lettore Francesco Provinciali.
Se qualcuno si cimentasse nel compito di raccogliere il glossario degli acronimi, delle sigle, e dei neologismi della scuola 4.0 ne uscirebbe un tomo ponderoso, forse un manuale d’uso (da aggiornare in continuazione) costruito su un linguaggio sincopato per gli addetti ai lavori che servirebbe solo ad evidenziare i tentativi di cambiamento introdotti nel sistema scolastico nazionale con le più recenti riforme (o pseudo tali) : in realtà una babele semantica e simbolica che sopravvive e anzi prolifera nella propria inconcludente autoreferenzialità.
Eppure chi non sa o non parla di BES, DaD, DDI, RAV, GLO, PEI, POF, FO, DOS, DSA, ADHD, FAD, FIS, GLH, GLIP, GOP, IOP; LEA, MOF, LIM, LIS, NAV, GAV, OSA, OF, PAF, PDF, PDP, PECUP, PMOF, PIA, PEP, PNF, POR, PON, PTOF, PSP, ROL, RAV, RE, RSPP, SASI-S, TIC, UdA, USR, UST…. è considerato un aborigeno, un analfabeta di ritorno, un arcaico espunto dalla pedagogia post-moderna e dai suoi addentellati professionali.
Da quando la scuola – che è luogo di relazioni umane, di socializzazione e di apprendimenti, di conoscenza e trasmissione del sapere – è stata snaturata dalle teorie nuoviste di matrice aziendalista (ben descritta nelle metafore del ‘preside-sceriffo’ e poi ‘capitano della nave’, degli insegnanti funzioni-obiettivo e poi funzioni-strumentali) vi si respira un’aria di irreggimentazione, con una minuziosa parcellizzazione dei ruoli, una logica preordinata e sequenziale di azioni e procedure studiate a tavolino, con un effetto moltiplicatore della burocrazia decentrata secondo i dettami di una malintesa autonomia, una fucina di progetti effimeri e spesso senza esito dove l’enfasi è posta più sul preparare che sul fare.
C’è gran fervore nel progettare una complessità virtuale che con fatica si trasferisce poi sul piano fattuale. Con un dispendio di tempi e di energie nel generare corollari sempre più lontani dalla realtà – la scuola degli anelli di Saturno – dove la pletora degli adempimenti non produce risultati migliorativi mentre la libertà di insegnamento è fagocitata dalla compilazione di schede, modulistica innumerevole, registri elettronici complicati e inutili che riducono la programmazione didattica ad una sequela di caselle da riempire, crocette da annotare, domande predeterminate per rispondere alle quali non serve far uso del pensiero critico: ma tutto deve essere annotato, descritto, documentato anche oltre la mera aderenza alla realtà.
Chi ha introdotto queste logiche computazionali nella scuola forse non si accorge che la sta snaturando, che la spinge in una spirale perversa di evanescenza, dove tutto deve essere certificato e validato, fosse anche il nulla che con slancio enfatico è stato raffazzonato nel calderone di una gestione acefala e inconcludente.
La classe, gli alunni, l’esempio degli adulti, la buona educazione sentimentale, il piacere di andare a scuola, il gusto di insegnare e di imparare, l’impegno di studiare non sono più al centro dei diritti e dei doveri. Subentrano adempimenti formali che spesso restano chiusi nel limbo dell’autoreferenzialità.
Le riunioni dei collegi dei docenti diventano sempre più monologhi del dirigente che detta regole, ritmi, tempi, procedure, metodi: non per vocazione ma per dare una sembianza gestibile alla complessità di cui è stato sovraccaricato. Anche la dimensione collegiale assume più le parvenze di una adunata da caserma che di un cenacolo che produca idee, che liberi la creatività, che favorisca e premi le eccellenze e il merito.
Per non parlare delle circolari interne che finiscono per competere in numero e complessità con quelle ministeriali. La scuola delle sigle e delle formule non piace a molti anche se ha i suoi estimatori, specialmente attinti tra i fanatici delle nuove tecnologie, dove gli acronimi, i codici alfanumerici, le password e le username prendono il posto di un testo scritto lineare, intellegibile, interlocutorio. La corsa alla digitalizzazione e all’abuso dei linguaggi informatici impoverisce il lessico della scuola in tutti i suoi contesti comunicativi, interni ed esterni, vanifica la ricchezza della dimensione relazionale.
Alla stregua di quanto accadrebbe nei concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli professionali della scuola, se malauguratamente e definitivamente i quiz sostituissero la trama di un tema sintatticamente corretto e semanticamente descrittivo, in grado di far interagire tra loro significati e significanti, di dare un senso compiuto alla sua stesura, di esplicitare una narrazione. La scuola sta perdendo le sue radici storiche e culturali, la tradizione e l’esperienza sono irrazionalmente sostituite hic et nunc dalla folle e spesso improduttiva logica dell’innovazione tout court.
Lungo questa strada stiamo abbandonando discipline come la geografia, espunta dai programmi di studio delle superiori (la sua presenza è ridotta al lumicino: 1 ora la settimana in alcuni istituti tecnici, 3 ore nel biennio del liceo ma trasformata in geo-storia, un mostro culturale riduttivo e tutto da inventare), mentre la storia è quasi estromessa dalle tracce dei temi di maturità (peraltro statisticamente la meno scelta dai maturandi, circa il 3% tra gli ambiti proposti negli ultimi anni) e raramente viene fatta oggetto di approfondimenti che vadano oltre le allegorie delle guerre e delle battaglie. Sta venendo meno il fondamento formativo e l’inquadramento spazio-temporale della cultura tramandata: geografia e storia si stanno spegnendo come gli zolfanelli della piccola fiammiferaia.
Per non parlare dell’educazione civica: 33 ore annuali di una materia da comprimere in una sintesi inesprimibile, introdotte con un anno di ritardo per un errore del Ministero (Parere CSPI – Cons. Sup. Pubbl. Istruz. n.° 31 dell’11/09/2019) e poi praticamente scomparse dai radar della didattica in presenza e nel contenitore indefinibile della DaD. Stiamo parlando della Costituzione Repubblicana, delle regole del vivere sociale, di quelle norme che tutelano la stessa civiltà. Nel Paese che vanta il più importante patrimonio artistico lo studio della storia dell’arte è un ectoplasma: può dirsi ‘formativa’ una scuola che concede la maturità liceale ad uno studente che non sa distinguere una tela di Raffaello da una di Caravaggio?
A questa deriva di decadenza e di impoverimento culturale del nostro sistema scolastico hanno concorso molti fattori: l’invadenza delle tecnologie intese come fine anziché come mezzo, la confusione tra apprendimento dell’inglese e uso degli anglicismi, le teorie della facilitazione e della semplificazione, l’abbandono del linguaggio orale e scritto nella sua valenza argomentativa ed esplicativa-per comunicare e comprendere- sostituito da neologismi e acronimi cui viene attribuito un valore superiore all’espressione compiuta e forbita, di cui sono solo una pallida ed aleatoria sintesi. Condizionali e congiuntivi si sono persi per strada, la stessa politica ne fa scarso uso.
Se poi gli influencer e gli imbonitori di ogni schermo (dalla TV agli smartphone) raccolgono milioni di followers su tematiche surreali e spesso demenziali, ci si chiede come la scuola potrebbe mai competere rispetto ad apprendimenti fugaci e a nuovi linguaggi. Essa subisce le contraddizioni di una dimensione virtuale basata su impressioni, opinioni, approssimazioni emendabili, cancellazione della memoria, oblio.
Nel nome della semplificazione del presente e della rimozione del passato rischieremo dunque di formare menti acritiche e prive di ogni motivazione alla conoscenza? Su questa domanda la scuola dovrebbe interrogarsi e compiere un percorso di riflessione e autovalutazione, non solo docimologica ma di merito.
Eppure l’Italia, la sua storia, la sua bellezza naturalistica e il suo patrimonio artistico e culturale sono invidiati da tutto il mondo. Dovremmo aprire le porte delle scuole a questo universo di conoscenze e tradizioni che hanno forgiato la nostra storia e ci hanno consegnato un bagaglio di inestimabile valore. Teatro, arti figurative, musica, poesia, letteratura meritano che le porte delle aule scolastiche vengano spalancate: eppure spesso ci trasciniamo nei meandri angusti e noiosi di una progettazione didattica di basso cabotaggio, ripetitiva, persino lesiva – lo ripeto- della stessa libertà di insegnamento intesa come libertà di scegliere il metodo migliore.
Tutto tende a enfatizzare i progetti per minimizzare o disistimare i risultati. Per liberare il sistema scolastico da tutti i lacci, i lacciuoli e gli orpelli che ne distorcono la vera matrice pedagogica e istituzionale occorre rimettere alunni e docenti al centro di un’idea di scuola.
L’insegnante deve essere sollevato dal sovraccarico di burocrazia autogeneratasi in questi decenni, deve tornare ad essere l’artefice della didattica intesa come sintesi di insegnamento e apprendimento.
Il Rinascimento italiano che da più parti si postula come via d’uscita dalla crisi pandemica passa necessariamente da una scuola che sappia recuperare i fondamentali del rapporto educativo. Per fare questo bisogna riconsegnare – metaforicamente – ai docenti le chiavi di accesso alle aule, ai libri, al sapere, alla conoscenza da stimolare e trasmettere e insieme a questo il “gusto” di farlo.
Restituendo loro l’immedesimazione in un compito professionale (che è anche funzione sociale) che è andato spegnendosi in una deriva di omologazione culturale. La grande bellezza della scuola italiana è il sapere ereditato, la cultura che entra passando attraverso la storia e le tradizioni. Ma è anche – per insegnanti e alunni, nel rispetto dei ruoli – la gratificazione di elaborare e compiere un percorso insieme, come direbbe Marguerite Yourcenar, per ammassare riserve contro l’inverno dello spirito, per scoprire sotto le pietre (dell’impegno e dello studio) il segreto delle sorgenti.