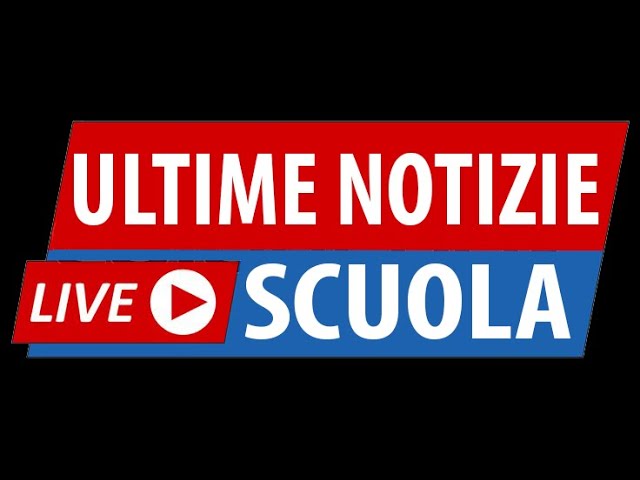Anche quest’anno ho lavorato perché, nelle mie classi, non mettesse radici il cancro di una concorrenza spietata, non serpeggiassero odio e rivalità tra gli studenti, non s’insinuasse nel loro animo l’atroce e falsa convinzione che il successo si costruisca a danno e a spese dell’altro.
Cala il sipario su un altro anno scolastico.
Si è trattato di un anno inusitato, inedito, surreale, oserei dire. Una comunità educante, un microcosmo resistente alla barbarie che incalza, una creatura che scalcia e si dimena, recalcitrante com’è, e come deve essere, a tradursi in mero ingranaggio di un sistema che, lì fuori, mercifica, omologa, umilia, sferza chiunque non si pieghi alle sue logiche intrise di miope, sterile produttivismo, cieco e fratricida competitivismo e furia nichilistica. Questa è stata, e mi auguro continui a essere, la scuola. Quella scuola che affonda le proprie radici etimologiche nel greco σχολή e che, in origine, indicava il tempo libero, quello che i latini chiamavano otium, ossia il tempo sottratto alle attività lavorative e da dedicare allo svago, destinato a nutrire la propria mente e a prendersi cura del proprio spirito. Si trattava di una prerogativa esclusiva dei ricchi, ossia di chi poteva, non dovendo spendere energie e tempo in altra attività, permettersi questa forma d’intrattenimento impegnato. La modernità ha esteso questo diritto a tutti, considerandolo sacro e inviolabile. Eppure una tendenza abbastanza diffusa nella nostra società vorrebbe che la scuola legasse il proprio ruolo al criterio dell’utile, inteso come necessità che le nozioni acquisite durante il percorso scolastico rechino vantaggi immediati e prontamente spendibili (cioè utilizzabili) nel mondo del lavoro. Aristotele a proposito della filosofia scriveva: “La filosofia non serve a nulla, dirai; ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile”. Giocando con quest’affermazione, modificandola e sostituendo alle parole “filosofia” e “sapere” i termini “scuola” e luogo, emerge, di converso, la tesi di chi crede che la scuola debba essere libera da condizionamenti esterni e concentrare il proprio impegno nella formazione dello studente come uomo e cittadino. La scuola non deve, certo, divenire un anacronismo, un polveroso scriptorium di monastica memoria, ma essere una membrana: flessibile, inclusiva, aperta e mai sorda alla temperie storico-culturale in cui è calata; eppure, deve alzare il ponte levatoio e scavare un fossato dinanzi al saccheggio dei Lanzichenecchi, alzare un muro al cospetto dei mercanti del tempio, il cui intento è picconare i sogni “improduttivi” e le ambizioni, a loro dire, “non profittevoli”.
Ho provato a decostruire, smontare in maniera ragionata, la mitologia utilitaristico-opportunistica inoculata nelle loro menti da un mondo che “ha annegato l’esistenza tutta nell’acqua gelida del nudo calcolo egoistico” e che a tutto accorda la patente di legittimità e il certificato di conformità alle proprie esigenze contingenti. Ho cercato, nelle vesti di un demiurgo, di plasmare una classe, da individui quali erano; di farne una molecola armonica, da atomi divisi e conflittuali; di fonderne i destini individuali in un’esperienza collettiva; di vederne i cuori palpitare all’unisono; d’insegnare loro, in definitiva, che “sortirne tutti insieme è la soluzione, sortirne da soli è l’avarizia”.
Sulla scuola nella pandemia si è scritto e detto abbastanza, ma una verità che mi sembra inconfutabile è che la didattica a distanza ci lascia in eredità un dato autoevidente: la scuola o è in presenza o non è. L’assenza del pubblico, la diaspora di quella comunità di cura e il ripiegamento nel privato delle proprie stanze hanno determinato la recrudescenza di quegli squilibri e di quelle diseguaglianze socio-economiche che le aule scolastiche, in qualche modo, depotenziano, armonizzando l’eterogenea platea studentesca.
Quello che abbiamo imparato è che quando i nostri ragazzi e le nostre ragazze, da studenti titolari di diritti inalienabili, si tramutano in consumatori di sapere, dai privilegi legati alla capacità di spesa dei singoli, a soccombere sono sempre gli ultimi.
Enrico Bonelli