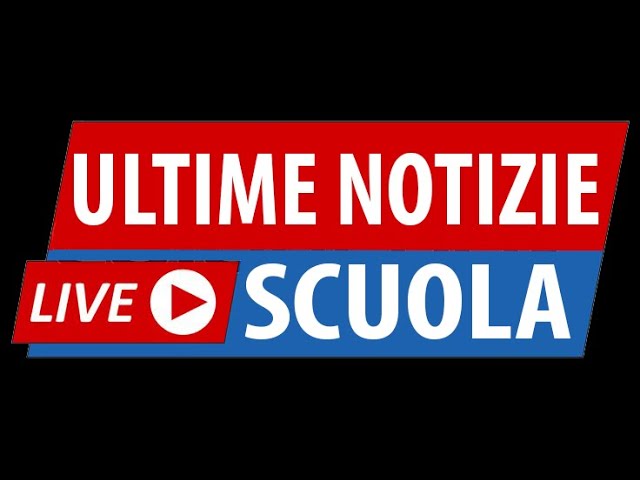Gent.mo L.M.,
scrivo per comunicare che non sono più disponibile a seguire l’iniziativa relativa a […] e che, d’ora in poi, non svolgerò attività diverse da quelle legate alla didattica in classe.
Questo gesto, che non ha niente di personale, dipende dall’approvazione della legge 107 sulla cosiddetta riforma della scuola, indicata di solito – comicamente, mi verrebbe da dire, se la definizione non discendesse da una propaganda politica spregiudicatamente populista – come ‘Buona scuola’. Di certo non pochi avranno al riguardo una visione differente, ma non è questo il punto: voglio qui manifestare il mio pensiero, la mia personalissima opinione non perché pretenda di avere la verità assoluta dalla mia parte, ma solo per chiarire le ragioni che impediscono a me di continuare a lavorare come prima, ragioni che si riassumono in questo: il nuovo corso imposto alla scuola italiana contrasta in modo insopportabile con la mia coscienza, con la mia idea dell’insegnamento e della scuola pubblica.
Dico ‘mia idea’, ma, al di là delle legittime differenze di opinione, dovrebbe restare un punto imprescindibile per qualunque discussione il profilo che della scuola pubblica traccia la Costituzione repubblicana, quella che afferma che «L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento» e che prevede per i privati «il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato» (art. 33), quella che sostiene che «la scuola è aperta a tutti» (art. 34) e che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» (art. 3), quella che «promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica» (art. 9), quella che garantisce che «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione» (art. 21), quella che «tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» e «cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori» (art. 35), quella che richiede che «Il lavoratore» abbia «diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa» (art. 36), quella che impone che «i pubblici impiegati» siano «al servizio esclusivo della Nazione» (art. 98).
Non sono giurista e del resto voci numerose e ben più autorevoli della mia hanno già messo in rilievo le contraddizioni della legge rispetto al dettato costituzionale; mi limito a leggere il testo della nostra Costituzione da semplice cittadino: se già la scuola di ieri pregiudicava parte di questi diritti fondamentali, quella disegnata dalla legge appena approvata, almeno secondo me (e questo è appunto ciò che conta qui), mostra una capacità mirabile di comprometterli tutti.
Solo per esemplificare sommariamente la mia inquietudine: non riesco a immaginare come possa conservare inalterato o come non senta almeno minacciato il proprio diritto alla libertà di manifestare il proprio pensiero e a quella di insegnamento chi sa che le sue condizioni di vita dipendono in modo notevolissimo da un dirigente scolastico e perfino da chi, come un alunno, è chiamato, da giudicato, a giudicare i propri insegnanti senza poter avere alcuna competenza per farlo, secondo un principio assurdamente ispirato al modello aziendalistico della customer satisfaction o al limite a quello, ancora più insensato, del like diffuso sui social network.
Nella scuola di domani i docenti, trovandosi a dipendere dal giudizio di soggetti esterni alla didattica e talora addirittura del tutto privi delle loro competenze professionali (si pensi, per esempio, al caso di un dirigente o di un docente che, da laureati in Lettere, debbano giudicare un professore di matematica, o a quello persino più incredibile di un genitore macellaio o medico che debba giudicare il lavoro dei docenti), finiranno loro malgrado per lavorare e fare le loro scelte in funzione dei desideri – anche solo impliciti – del dirigente, dei volubili umori delle famiglie e persino dei capricci degli alunni (non è difficile prevedere che il meccanismo produrrà, nei prossimi anni, uno straordinario “miglioramento” dei voti degli studenti italiani).
Se non invidio chi avrà in classe il figlio dei docenti, del genitore o l’alunno stesso che faranno parte del comitato di valutazione chiamato a decidere dei suoi aumenti di stipendio, guardo preoccupato anche alla situazione di tutti quei colleghi che, con una sorta di caporalato in versione scolastica, attenderanno di essere scelti dall’arbitrio di un dirigente e che, inoltre, lavoreranno per i successivi tre anni sapendo di essere privi di una titolarità certa (caso unico, a mia conoscenza, fra tutti i dipendenti pubblici), dovendosi ricordare ogni giorno che la permanenza in quella sede non dipenderà dal corretto esercizio costituzionale, contrattuale, culturale e didattico del loro ruolo, bensì da principi che i nostri legislatori hanno evidentemente ritenuto superiori, ovvero il POF e forse anche i desideri dello stesso dirigente (quanto questo secondo elemento inciderà non mi sembra ancora chiarissimo dalla norma, ma, dato lo “spirito della riforma”, sarebbe sorprendente che non contasse).
Come, costretti a subire questi condizionamenti impropri, potremo continuare a sentirci non solo pienamente liberi di esercitare il nostro ruolo con equilibrio e obiettività, ma anche al servizio esclusivo della Nazione? Come potremo ritenerci tutelati in quanto lavoratori e garantiti nella nostra elevazione professionale? Come potremo essere sicuri del nostro diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del nostro lavoro? Come potremo noi per primi garantire lo sviluppo della cultura in una scuola in cui la cultura ha, di fatto, un ruolo così marginale e subordinato?
Come non pensare, leggendo la disposizione che consente sconti fiscali sulle donazioni di privati alle singole scuole, che si creeranno differenze inaccettabili di risorse fra istituto e istituto? A parte le possibili discussioni sull’entità del fondo perequativo per le scuole meno o per nulla finanziate, è il principio stesso ad essere inaccettabile: fosse anche per un solo euro di differenza, lo Stato rinuncia al suo dovere di garantire una scuola pubblica uguale per tutti ovunque.
Come non vedere calpestato – ancora una volta – il divieto costituzionale di destinare finanziamenti pubblici alle scuole private in una disposizione che prevede la possibilità di detrazioni fiscali per la loro frequenza? L’obiezione di solito opposta a questa osservazione è nota: la scuola privata solleverebbe lo Stato da un impegno molto oneroso. L’argomento è pretestuoso e ridicolo in un Paese che investe in istruzione la percentuale del PIL più bassa dell’Unione Europea dopo la Grecia, nonché una delle più basse fra i paesi OCSE.
Come si può non comprendere (o fingere di non comprendere), cioè, che la scuola non è né può diventare un’azienda se non a patto di snaturare in modo irrimediabile la sua missione e di smarrire i suoi scopi costituzionalmente definiti?
Personalmente considero del tutto legittimo reagire di fronte a quello che è solo l’ultimo atto di un progetto avviato da tempo (come lasciano del resto intuire anche indizi solo all’apparenza non connessi con quanto accade oggi: si pensi alla grottesca definizione del dirigente scolastico come ‘datore di lavoro’ e ai termini insensatamente economicistici che da anni inquinano il lessico scolastico: Piano dell’Offerta Formativa; debito; credito; rendimento): dopo averli a lungo screditati e tenuti di fatto sull’orlo della povertà, si vuole ora trasformare gli insegnanti in semplici yes men proni a ogni ordine, sottomessi all’arbitrio di chiunque, vittime designate di un potere che, per ovvie ragioni, non sopporta il pensiero critico e dunque una scuola pubblica qualificata, libera, laica e solidale.
Tutto ciò è reso ancora più insopportabile dal fatto che su temi di questa rilevanza (si pensi anche al fatto che, in modo del tutto unilaterale, sia stata prevista la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con la cosiddetta riforma: è solo l’ennesima conferma che il contratto – scaduto addirittura nel 2009 e tornato nel dibattito pubblico solo grazie alla recente sentenza della Corte Costituzionale – sia ormai proditoriamente emarginato, ignorato con indifferenza raccapricciante dai provvedimenti che riguardano la regolamentazione dei rapporti di lavoro) è stato addirittura impedito al Senato di discutere e che il governo si è riservato delle deleghe in bianco incredibilmente ampie e destinate con ogni probabilità ad aggiungere ulteriori aberrazioni a quello che vediamo adesso. Né si può dimenticare la demagogia ricattatoria di chi ha sostenuto, sapendo di mentire, che la nuova legge e le sue ripugnanti novità fossero indispensabili all’assunzione di un cospicuo contingente di personale precario e a una non più rinviabile valutazione degli insegnanti: chi conosce la scuola sa perfettamente che il tema delle assunzioni e quello della valutazione potevano essere affrontati in modi ben diversi e di certo più logici (ad esempio, per il primo punto, abolendo lʼobbligo di riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore e con la riduzione sistematica – e quindi non secondo la finzione pubblicitaria della attuale legge 107 – del numero degli alunni per classe, due problemi di gelminiana memoria che hanno prodotto la perdita di decine di migliaia di posti e un notevole indebolimento della qualità dell’insegnamento) e che la via scelta non era affatto necessaria, ma solo funzionale a interessi e progetti dalla natura inquietante (prodotto di un potere che sembra ormai avere in Italia solo i suoi esecutori materiali, ma che forse impartisce i suoi ordini altrove).
È successo più di una volta nel recente passato che venissero approvate, su materie di centrale importanza per la vita democratica della società, leggi poi dichiarate incostituzionali (si pensi al caso della legge elettorale o quello della legge sulla fecondazione assistita).
Si può dunque comprendere che, non potendo più considerare ciò che è legale necessariamente coincidente con ciò che è costituzionale (né tanto meno con ciò che è giusto, secondo una lezione che, come è noto, la Storia ci ha già offerto purtroppo molte volte), ci si senta portati, in casi come questo, a regolare il proprio agire innanzitutto sulla propria coscienza, supplendo con il senso del dovere morale al vuoto di riferimenti esterni condivisibili, nella speranza che, prima o poi, anche per questa legge arrivi l’abrogazione.
Cerco solo di spiegare che mi sentirei del tutto indegno del mio ruolo e della gigantesca responsabilità di presentarmi ogni giorno davanti a decine di ragazze e ragazzi, se continuassi a parlare di Dante e Leopardi, Pasolini e Calvino senza poi avere, fuori dalla classe, un comportamento coerente con gli esempi intellettuali di cui ci si occupa dentro. Tutti ricordiamo le parole, ormai da considerarsi profetiche, di Piero Calamandrei sulla scuola, tutti conosciamo l’importanza e la delicatezza della funzione – probabilmente addirittura rivoluzionaria – che la scuola pubblica svolge in una società che pretende di definirsi democratica, tutti siamo chiamati a essere all’altezza del compito difficilissimo e dell’impareggiabile onore di servire la società attraverso l’insegnamento: ecco, essere all’altezza, ieri come oggi, secondo me significa anche rifiutare sistematicamente di collaborare, a qualunque titolo, con le manifestazioni istituzionali di un potere arrogante e intimidatorio, e concentrare le proprie energie in modo esclusivo sulla didattica, sul tentativo di santificare l’ora di lezione quotidiana come rituale laico di libertà ed elevazione culturale e civile.
Conta solo questo, contano adesso per me solo i giovani che ogni giorno entrano nelle nostre aule, almeno finché ce li lasceranno, finché non si accorgeranno che l’unica scuola davvero ‘buona’, ovvero l’unica del tutto rispondente alle esigenze di chi governa, è quella senza insegnanti o magari quella in cui gli insegnanti siano stati sostituiti da altoparlanti o piuttosto, per sicurezza estrema, quella che sia stata abolita.