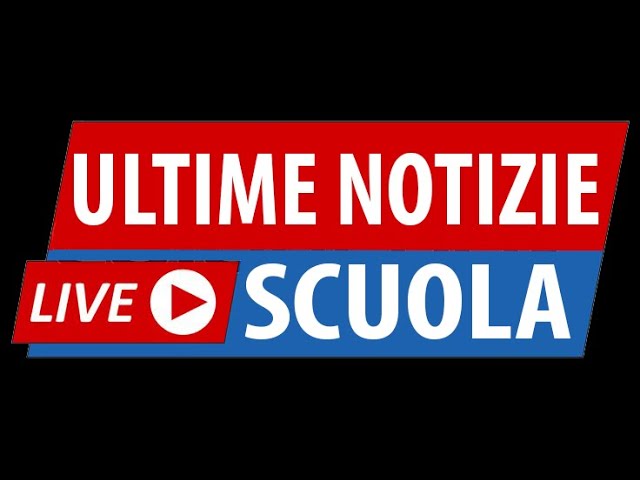Ecco un piccolo saggio su Shakespeare, scritto da uno studioso particolarmente innamorato del grande Bardo, Paolo Sessa, e dove si cerca di capire, in occasione dei 400 anni dalla morte, la sua origine: era effettivamente inglese, pur essendo il meno inglese degli artisti, o siciliano, come alcuni studiosi amano sussurrare da mezzo secolo a questa parte? Chissà, forse, non è chiaro, ma…
Quattrocento anni fa moriva uno dei più grandi poeti, e sicuramente il più grande autore di teatro, che il mondo abbia conosciuto. Eppure, ironia della sorte, della vita del più famoso e studiato scrittore di tutti i tempi, sappiamo così poco che ancora, da tante parti, si nutrono dubbi sulla sua identità. Di lui si è scritto praticamente tutto; la sua bibliografia è ampia quasi quanto quella di Dante Alighieri, riconosciuto universalmente come il più grande poeta di tutti i tempi.
Fiumi d’inchiostro sono stati versati anche sulla sua vita, della quale, però, al di là di poche notizie certe (e neanche troppo) riusciamo a fare solo congetture più o meno stravaganti. A parte qualche firma su atti pubblici, qualche menzione contemporanea sulle sue produzioni teatrali, qualche registrazione di opere pronte per la scena, una sorta di strano testamento autografo che menziona persino un letto particolarmente comodo (il suo “secondo miglior letto”) che lascia alla moglie Anne, ma non fa menzione, ad esempio, di alcun libro in un’epoca in cui i libri costavano quanto un buon mobile; a parte questo, e la registrazione di un battesimo il 23 aprile di un tale William Shakespeare (“Guiliamus filius Johannes Shakspere”), nulla sembra certo. A cominciare dalla sua data di nascita. Il 23 di aprile o, come è più probabile, qualche giorno prima. Il 23 di aprile è in realtà la data del suo battesimo ed è probabile che suo padre, considerata la mole di lavoro di un guantaio, lasciasse passare qualche tempo, prima di decidersi a denunciare la sua nascita. E comunque, il 23 di aprile può anche starci bene, visto che fa coppia con il giorno della sua dipartita: c’è del magico in questo regno di Albione.
{loadposition bonus}
A proposito di suo padre, non siamo neanche sicuri che facesse il guantaio; qualche biografo dice che fosse un conciatore di pelli; e qualcun altro, un macellaio. Certo, fra i tre, guantaio fa più cool! Far nascere da un macellaio il più grande poeta di tutti i tempi sarebbe decisamente deprecabile. E tuttavia, anche col più nobile guantaio, i conti non tornano lo stesso: nasce da una famiglia così così, in un villaggio così così (Stratford sull’Avon), fa una scuola di paese così così (la grammar school del paese, una sorta di ginnasio), non lascia neanche un libro nel suo testamento; e però diventa il più bel pezzo da novanta della letteratura mondiale: quando parliamo di Shakespeare, proviamo ancora, dopo 400 anni, una riverenza che dalle nostre parti reclamano solo Dante, Leonardo, Galilei e Einstein.
Per rabberciare i conti, i suoi biografi vantano la grammar school frequentata dal poeta, dove si studiava un poco di latino e un po’ meno di greco e citano (ma non tutti sono d’accordo) l’esperienza che avrebbe fatto come maestro elementare nei dintorni di Stratford per un paio di anni, tanto per coprire un periodo della vita dell’autore del quale, in realtà, non sappiamo nulla.
Non sappiamo neanche perché, a un certo punto della sua vita, si trovasse a Londra; tanto che i suoi biografi si sono inventati di sana pianta una serie di storielle senza alcun fondamento documentale: ad esempio, un furto (o caccia di frodo) di un cervo nel parco privato di un certo Sir Thomas Lucy, che lo avrebbe costretto a scappare a Londra per evitare l’arresto. E però, nel giro di un paio d’anni, ce lo ritroviamo a Londra amico della regina Elisabetta e della buona nobiltà, con gli University Wits, giovani studenti di Cambridge che studiavano greco, latino, francese, storia, retorica, grammatica, etc., dei quali alcuni già famosi e affermati autori teatrali, nelle vesti di suoi comprimari; tanto che uno di loro, certo Robert Greene, non mancò di definirlo con disprezzo “un galletto abbellito con le nostre penne”.
Cosa leggeva Shakespeare? Dove si procurava i libri? Quale biblioteca frequentava? Queste stesse domande, riferite alla maggior parte degli autori medievali europei, hanno risposte plausibili, a volte, certe; riferite a Shakespeare, creano imbarazzo persino tra i suoi più quotati studiosi.
Ma allora, ci domandiamo, se ci sono così tanti punti oscuri sulla vita del più importante scrittore europeo del XVI secolo, vissuto nella civilissima Inghilterra, perché ogni congettura sulla sua identità, che di tanto in tanto salta fuori da parte di non specialisti in senso stretto, viene subito liquidata come ridicola fantasticheria? Perché quasi nessuno degli specialisti riconosciuti di Shakespeare, o dei suoi biografi, ha mai provato a discutere queste congetture per smentirne la serietà?
L’argomento è stato materia di numerose opere di narrativa e di qualche film, ma mai (o quasi) di uno studio serio e accurato da parte di specialisti di Shakespeare. Eppure, se apriamo Google e cerchiamo la voce “Shakespeare”, ci imbattiamo in una quantità strabiliante di materiale sulle presunte identità del grande poeta: chi si nascondeva dietro il suo nome, Francesco Bacone, il conte di Penbroke, o la stessa Elisabetta? o forse Shakespeare altro non era che Marlowe costretto a cambiare identità dai sevizi segreti britannici per cui lavorava? o questo Shakespeare era in realtà un italiano arrivato in quegli anni a Londra, un rifugiato politico (forse), un certo siciliano della famiglia dei Florio, che cambiò cognome, adottando la traduzione inglese del cognome della madre: Crollalanza che diventa Shakespeare.
Tralasciando le ipotesi meno intriganti e meno probabili, Bacone, Elisabetta e gli altri nobili coi quali si racconta l’Autore avesse rapporti, l’ipotesi Marlowe e quella del giovane Florio sembrano le più interessanti: quanto meno spiegherebbero la mole di informazioni e lo spessore culturale necessario a produrre quei grandi e immortali capolavori che conosciamo: Marlowe era un ottimo studente di Cambridge e autore drammatico affermato, e il giovane Florio apparteneva a una delle famiglie siciliane più nobili e di buona cultura, che aveva condotto studi seri e aveva a disposizione una sterminata biblioteca domestica.
Da dove avrebbe preso Shakespeare tutte le informazioni, le trame, le storie delle sue opere? I suoi biografi ci informano che ha avuto modo di leggere qualche adattamento inglese delle Vite parallele di Plutarco (per il Giulio Cesare, Antonio e Cleopatra, etc.), che gli sarà capitata fra le mani la Chronicle di Holinshed (per Lear, Macbeth, etc.), che forse ha avuto occasione di spulciare la traduzione di qualche novelliere italiano del Trecento (per le storie ambientate in Italia), ma di tutte quelle informazioni precise e piene di particolari, che saltano fuori dalle sue opere, i suoi biografi non riescono a dar conto.
E quella lingua, che ha incantato decine di generazioni di lettori e studiosi in tutto il mondo per secoli, e che presuppone ben altre letture che qualche traduzione raffazzonata dall’italiano o dal francese e il repertorio scabro di Holinshed, dove l’ha appresa? Senza una fede incrollabile, pare una sfida al buon senso affermare che la grammar school di Stratford e le letture che vi si facevano fossero capaci di suggerire quell’arsenale di immagini, metafore, conoscenza della retorica, uso sapiente del blank verse, etc.
Quando ero giovane studente di letteratura inglese, mi intrigava l’idea che Shakespeare e Christopher Marlowe potessero essere la stessa persona; all’esame del secondo anno di inglese portavo due corsi particolari sui due grandi drammaturghi, e la lettura delle loro opere mi aveva affascinato allo stesso modo; inoltre trovavo che la bramosia di potere di Macbeth si specchiava nell’ansia di conquista di Tamerlano, la sete di conoscenza di Prospero luccicava negli occhi di Faust, e quella morbida inclinazione per il proprio sesso, che scoppiettava nei Sonetti di William, pareva la stessa che agitava le fantasie di Edoardo II.
Poi, mi impressionavano alcune coincidenze anagrafiche: Shakespeare nasce nell’aprile del 1564, e forse un po’ prima; anche Marlowe, con qualche ritoccatina, nasce negli stessi giorni. Il padre di Shakespeare fa il guantaio (insomma lavora la pelle); il padre di Christopher, lo stesso, fa il calzolaio. Il padre di Shakespeare si chiama John come quello di Marlowe. Dalle opere di Shakespeare emerge sicura padronanza di una bella cultura classica (anche se ha frequentato solo una grammar school); lo stesso dalle opere di Marlowe che, però, ha fatto l’università.
Ma sono gli anni londinesi, quelli che infittiscono il mistero e rafforzano l’ipotesi Marlowe. Che fa Shakespeare tra il 1585 e il 1592? Mistero: sono i cosiddetti lost years (gli anni perduti). Sposato, con tre figli, parte improvvisamente per Londra, lasciando la moglie e i tre figli a Stratford; arriva a Londra nel 1590; e che fa? Scrive il Tito Andronico? Quale? Quello che molti studiosi indicano come lavoro a quattro mani che Shakespeare scrisse assieme a Marlowe? Nel ’93, tre anni dopo il suo arrivo, mentre a Londra infuriava la peste e nessuno ancora parlava di Shakespeare, che fa Marlowe? Si fa accoltellare a morte in una rissa da taverna: bel modo di sparire per una spia della regina. Scompare Marlowe, compare Shakespeare. Su questa ipotesi, John Underwood ci ha costruito un bel romanzo di successo, The Shakespeare’s Chronicles (2011), tradotto in italiano per la Newton Compton (Il libro segreto di Shakespeare).
L’autore del romanzo, credo tragga ispirazione da un articolo di Archie Webster sulla National Review del 1923: partendo dall’ipotesi che i Sonetti sono una sorta di autobiografia poetica del loro autore, e non trovando alcuna corrispondenza tra gli elementi di questa autobiografia e i dati biografici di Shakespeare, di Bacone, o del Duca di Oxford, Webster ne deduce che bisogna cercare altrove.
Il candidato perfetto gli sembra Marlowe, non solo per le numerose corrispondenze con la sua vita, ma perché così si spiegano una serie di allusioni che sono sempre state un rompicapo per i critici più acuti di Shakespeare. Nel 1593 Marlowe aveva già pubblicato Tamburlaine, Faustus, The Jew of Malta, ed Edward II, prima che il nome di Shakespeare apparisse sulla scena; ed era considerato un genio del teatro e della poesia; nel marzo di quell’anno fu accusato di eresia e pochi giorni dopo ucciso, si dice, in una rissa da taverna. Appena un mese dopo sulla scena londinese appare il nome di William Shakespeare stampato sul poemetto Venus and Adonis, dedicato al Conte di Southampton (che era stato compagno di studi di Marlowe a Cambridge).
Su queste, e su molte altre “corrispondenze”, Webster costruisce la sua teoria e Underwood il suo romanzo. Sono sufficienti a spodestare Shakespeare dal suo trono? Non lo so; so, però, che gli inglesi storcono il naso quando si mette in discussione l’identità del loro Bardo.
In questo senso, un vero cataclisma appare l’ipotesi italiana, che va per la maggiore, e cioè che Shakespeare altro non fosse che Michelangelo Florio, messinese (immaginate la faccia che fanno gli inglesi!). Quando facevo l’Università, il mio insegnante di Letteratura Italiana Gino Raya era tra i sostenitori dell’idea che Shakespeare non fosse Shakespeare, e provocatoriamente sfidava gli inglesi ad aprire la tomba del grande poeta, convinto di trovarci la soluzione dell’enigma. In effetti, neanche questo sarebbe stato possibile: il corpo del poeta, sepolto nel cimitero di Stratford, a ridosso dell’alveo dell’Avon, a ben cinque metri di profondità (chissà perché!), se lo sarà mangiato il fiume, assieme a tutto il resto, nel corso delle sue frequenti inondazioni. Mistero.
A sostenere la sua causa, Raja citava l’iscrizione voluta dal poeta sulla sua tomba, una sorta di maledizione di Tutankhamon.
Caro amico per amor di Dio rinuncia
a scavare la polvere che è qui rinchiusa.
Benedetto sia colui che risparmia queste pietre
e maledetto colui che rimuoverà le mie ossa.
Gli studiosi sostengono che questo invito a non rovistare nella propria tomba fosse assai comune nel Cinque-Seicento inglese, ma non danno conto del tono severo della maledizione, che, invece, non pare fosse così frequente.
Ma questo Shakespeare, in realtà chi è?
“Sappiamo chi siamo, ma non sappiamo chi potremmo essere”(Amleto). Sembra quasi che il poeta volesse lasciarci una traccia. Se è per questo, c’è chi sostiene che di tracce ne abbia lasciate a palate! A proposito! E’ mai stato in Italia, Shakespeare? Pare di no: troppo occupato fra moglie e figli lontani, teatro e vita mondana (come si presume dalle sue alte frequentazioni); e, comunque, manca qualsiasi evidenza di suoi possibili spostamenti. Se Shakespeare si fosse mai mosso dall’Inghilterra lo avremmo certamente saputo; pensate che, ad esempio, di Geoffrey Chaucer, vissuto due secoli prima, si sa praticamente tutto, a cominciare dei suoi viaggi in Francia, in Italia, in Spagna, nelle Fiandre, etc.
E allora, appare veramente curioso che Shakespeare abbia deciso di ambientare quasi una ventina delle sue opere teatrali, oltre il cinquanta per cento, in diverse città italiane. Se da un lato sappiamo che l’Italia del Rinascimento esercitava un fascino irresistibile su tanti scrittori inglesi, specie autori di teatro, dall’altro appare decisamente strano che un giovanotto di Stratford, che si presume non si sia mai mosso dal suo villaggio e da Londra, si scelga come location delle sue opere Verona, Venezia, Padova, Milano e persino Messina.
Per spiegare la faccenda i biografi e i critici si affannano a spiegare che Shakespeare ha avuto modo di leggere un sacco di libri sull’Italia; sulle fonti presunte di Shakespeare esistono centinaia di studi, alcuni dei quali (ad esempio, il Manualetto Shakespeariano di Gabriele Baldini) estremamente precisi e documentati. Tuttavia, nessuno ci dice mai quando il nostro Bardo avesse letto quei libri (tra l’altro di non facile reperimento). Certo, non alla grammar school di Stratford, né in quella Londra, dove ad un tratto si ritrova senza il becco di un quattrino, costretto (dicono) a lavorare come guardiano di cavalli all’ingresso dei teatri (sic!); né avrebbe potuto farlo dopo i primi successi, perché non ne avrebbe avuto assolutamente il tempo se si pensa che scriveva in media quasi due drammi l’anno, partecipava alle prove a teatro, lui stesso recitava in alcuni ruoli (personaggi femminili?), frequentava l’aristocrazia londinese, reggeva economicamente con i suoi soci le sorti del Globe, di cui era azionista; e, ogni tanto, pensiamo dovesse andare a trovare moglie e figli a quasi duecento chilometri da Londra (più di un giorno di viaggio in carrozza).
Niente libri, dunque, che, tra l’altro, nessuno sa che fine abbiano fatto. A noi pare, a lume di naso, che queste conoscenze si maturino in lunghi anni di studio universitari o, comunque, a contatto con un ambiente letterario mediamente alto: cosa che andrebbe bene per l’ipotesi Marlowe o per l’ipotesi Florio, ma che non corrispondono alla storia debole e piena di lacune del giovanotto di Stratford.
Quali elementi fanno propendere per l’ipotesi italiana? Innanzitutto, la precisione e la dovizia di particolari con cui descrive luoghi, che non si ritrovava in nessun libro pubblicato all’epoca (e Google Maps non c’era ancora!). Tranne a pensare che Marlowe, una volta scomparso, sia venuto a vivere in Italia (cosa per la quale non esiste evidenza alcuna), resta plausibile l’idea che “Shakespeare” potesse essere italiano, o meglio siciliano di Messina. Appunto, quel Michelangelo Florio, figlio del medico Giovanni e della nobildonna Guglielma Crolla-Lanza (shake-spear)? Questo è il ragionamento che da oltre un cinquantennio fanno i sostenitori dell’ipotesi Florio.
A supportare l’ipotesi, qualche anno fa, un avvocato californiano, tale Richard Paul Roe, si è messo alle calcagna di Shakespeare come un segugio e, pur senza incrinare la mia fede nel canone (nessuno tocchi Shakespeare!), dopo aver letto il suo libro, confesso di essere stato assalito da un discreto numero di dubbi e di perplessità. Cominciamo con Giulietta e Romeo: ma come ha fatto Shakespeare a inventarsi il boschetto di sicomoro sul fianco ovest di Verona, ancora vivo e vegeto all’esterno di Porta Palio, che la maggior parte dei veronesi neanche conosce? E la chiesa di San Pietro Incarnario, dove Giulietta avrebbe dovuto convolare a nozze con Paride, che nessuna guida (né vecchia né nuova) riporta, come l’ha conosciuta? Solo chi fosse vissuto per qualche tempo a Verona avrebbe potuto averne notizia.
A proposito dei Due Gentiluomini di Verona: nessuno di noi sapeva che da Verona si potesse andare in barca, risalendo dall’Adige al Po all’Adda, fino ai Navigli di Milano; ma veronesi e milanesi nel Cinquecento lo sapevano; e lo sapeva pure “Shakespeare”, tanto che ripropone la cosa, facendo fuggire Prospero da Milano in barca (La Tempesta). E a proposito di Milano, il Pozzo di San Gregorio, dietro l’omonima chiesa, scavato per seppellirci i cadaveri della peste del 1575? Neanche i milanesi lo conoscono e però è là. Per non parlare della Bisbetica domata, ovvero una Guida turistica della Padova del XVI secolo o del Mercante di Venezia con il Ghetto nuovo, il portico, la casa di Shylock; o della Messina di Molto rumore per nulla.
Ed ecco rafforzata l’ipotesi del prof. Martino Iuvara, ex docente in pensione, giornalista e scrittore, secondo il quale nello stesso aprile 23 del 1564 nasce a Messina, da nobile famiglia, Michelangelo Florio, ragazzo geniale, costretto a fuggire con la famiglia, in Veneto, a Milano e successivamente a Londra, a causa delle idee calviniste del padre, già condannato al rogo dal Sant’Uffizio. A Messina aveva studiatolatino, greco e storia presso i francescani e pare avesse scritto una commedia in siciliano “Tantu traficu ppi nenti” che non può non ricordare il Much Ado about nothing. Pare, almeno secondo le ricerche di Iuvara, che Michelangelo ebbe modo di soggiornare ad Atene e in Danimarca (il che spiegherebbe il Timone d’Atene e l’Amleto). Una volta a Londra, per stare più tranquillo con l’inquisizione, avrebbe cambiato il suo nome con quello della madre tradotto in inglese (Guglielma Crollalanza – William Shakespeare).
Gli amici, che sanno della mia sfegatata passione per Shakespeare e della mia curiosità per tutto ciò che va controcorrente, mi chiedono spesso se io non sia convinto del fatto che un “caso Shakespeare”, comunque, non si possa negare. Ora, io confesso la mia ortodossia e poi, da innamorato di cose inglesi, non mi verrebbe mai di fare uno sgarbo a un popolo amico: come la prenderemmo noi se qualcuno avanzasse l’ipotesi che Dante non era italiano?
E poi, non vorrei turbare il Bardo, con questi dubbi in fatto di identità, proprio nel quattrocentesimo anniversario della sua dipartita. Il fatto è che questo Shakespeare è un vero portento, forse troppo grande per essere una sola persona; e allora dagli con Marlowe, Bacone, il conte di Oxford, la stessa Elisabetta, il giovane Florio, etc. Dai tempi dei tempi, nessuno ha mai solcato con tanta sicurezza e profondità i mari infìdi della nostra psiche, neanche i moderni con tutte le loro diavolerie (risonanza magnetica, PET, elettroencefalografia, TAC, ecografia, psicanalisi, etc.). I suoi non sono personaggi, sono uomini e donne fatti di carne e sangue e nervi e muscoli, che urlano, soffrono, gioiscono come uomini veri, e che si stagliano su un orizzonte di verità che neanche mille libri ci daranno mai.
Il re Lear e il buffone in quella landa inglese (ma potrebbe essere siciliana) sono l’umanità intera che soffre per l’ingratitudine delle figlie e che solo un poco di autoironia riesce a salvare dalla totale distruzione. Le mani insanguinate di Macbeth sono le nostre, quelle lorde delle mille guerre di conquista che ancora pratichiamo come riti ossessivi di morte, mani che nessuna acqua può lavare. I dubbi di Amleto sono i nostri dubbi, sono l’infelicità cui ci condanna sempre l’incertezza proprio quando siamo chiamati ad agire. L’amore innocente dei due ragazzini veronesi, le bravate di Romeo e i suoi amici, l’indolenza e la stupidità dei padri, sono ancora e sempre i nostri. Shakespeare è riuscito a farci provare compassione e affetto persino per Iago, il più turpe dei suoi personaggi a dire di molti, ma io ho capito: ho registrato l’indicibile sofferenza di Iago quando sospetta che il Moro lascivo “tra le mie lenzuola abbia preso la mia vece”. Moglie per moglie. Chi di gelosia colpisce, di gelosia perisce.
Quando, nella Tempesta, i suoi personaggi, come aerei fantasmi, si sono sciolti nel nulla, il sipario non s’è chiuso, e ci siamo ritrovati tutti catapultati sul suo palcoscenico a mandare avanti la rappresentazione, scoprendoci ora Amleto, ora Lear; Calibano piuttosto che Prospero; Macbeth o Romeo; Giulietta, Cordelia, Miranda. Quando “le torri ammantate di nubi, gli splendidi palazzi,/i templi solenni, lo stesso immenso globo,/ sì, e tutto quel che racchiude, si dissolveranno” gli uomini saranno sempre là. Non lo lasceremo solo “in questa nuda isola” e continueremo a dar voce ai suoi e ai nostri sogni, perché Shakespeare è stato tutti noi. Chiunque egli sia stato, “ il nostro pianto e il nostro riso sono nostri solo in parte; li troviamo dove lui li ha lasciati, e recano il suo stampo” (George Steiner).
Paolo Sessa