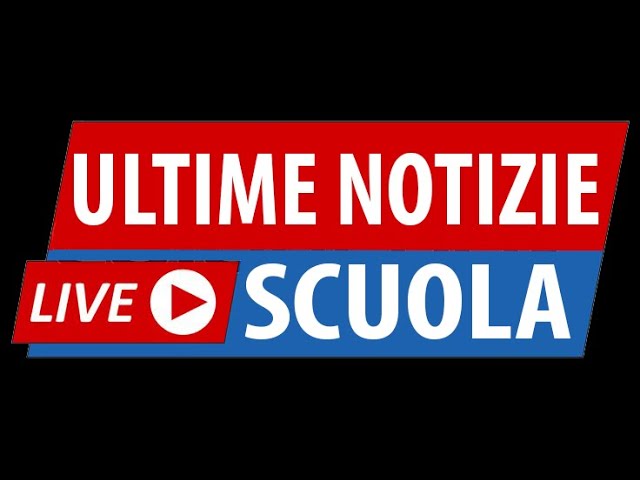È impossibile identificare una strategia nella politica scolastica della sinistra. Essa risulta dalla sommatoria di obiettivi settoriali, spinte contingenti e richiami del passato, interessi corporativi e pressioni della società civile, istanze diverse e contraddittorie. Ma soprattutto eredita una contrapposizione originaria interna al vecchio Pci: quella fra chi propugnava l’accesso del proletariato alla scuola della borghesia e, di conseguenza, ai suoi valori e quella di chi, al contrario, voleva distruggere la scuola e i valori borghesi in nome di una cultura rivoluzionaria e di una scuola di classe.
La traduzione operativa di questa contrapposizione, di cui hanno fatto le spese la scuola media e l’istruzione professionale, sta nell’alternativa fra la conoscenza e la competenza: una scuola che insegna a pensare e una scuola che insegna a fare. Il malanno è che nessuna delle due prospettive è mai stata definita coerentemente e, quel che è peggio, convivendo all’interno del medesimo partito e spesso delle medesime persone, esse, quando la sinistra ha preso nelle sue mani le leve del potere, si sono mescolate fra di loro provocando un indecoroso guazzabuglio. Il disastro della “buona scuola” renziana è solo l’epilogo di una stagione di interventi improvvidi e improvvisati che hanno progressivamente distrutto il sistema formativo italiano. La posizione della sinistra, o meglio del Pci, sulla scuola non era solo viziata da pregiudizi ideologici contraddittori ma risentiva anche della sostanziale incapacità di entrare nel merito dei problemi per disinformazione e incompetenza. Per decenni si è alimentato il mito della riforma della scuola – che era anche il nome di una rivista– una riforma salvifica che avrebbe smantellato la scuola “gentiliana” e che nella sua nebulosità ottenne l’unico risultato di creare una situazione di precarietà, di sfiducia, di disaffezione, facendo passare per retrivi gli insegnanti convinti del loro lavoro e per progressisti quanti si adoperavano per svalutarlo. Poi venne il latino cattivo, il latino inutile, il latino classista, sulla scia delle Lettere ad una professoressa che hanno fatto più danni delle bibliche cavallette, il latino che impediva ai figli degli operai e dei contadini il riscatto sociale. Era vero esattamente il contrario: la scuola “difficile”, della quale a torto o ragione il latino era diventato il simbolo, era semmai un ostacolo per le dinastie familiari, per i rampolli di professionisti, possidenti, industriali, che rischiavano di soccombere nel confronto con i giovani proletari di talento e soprattutto determinati. La scuola facile non facilita il ricambio sociale: lo impedisce. Tutti lo sapevano ma tornava comodo non dirlo.
La tentazione di magnificare il passato crea indubbiamente distorsioni difficili da correggere come gli idòla baconiani. Per ciò che mi riguarda vedo di tenerla a bada e non ho difficoltà a riconoscere che la scuola italiana, e, in particolare proprio il liceo classico che ne era la punta di diamante, poteva essere un ottimo strumento per distogliere i giovani dalla lettura, per indurre l’odio verso i classici, per confondere la cultura con l’erudizione. Era proverbiale il sadismo con cui il professore, col testo fra le gambe, pretendeva dal tapino sottoposto a interrogatorio la descrizione dell’acconciatura di Lucia. So bene che imparare liste di verbi greci con l’aoristo irregolare non contribuiva ad apprezzare il padre Omero e so anche che docenti sprovveduti o caratterialmente inadatti non sono una prerogativa del nostro tempo. Ma il “clima” che si respirava nella scuola, come nel resto delle istituzioni, quello sì era diverso e contribuiva a dare dignità anche ai somari.
In uno dei suoi sonetti giovanili Alessandro Manzoni esprime tutto il suo fastidio per gli anni passati a scuola, per la forzata immobilità, il desiderio frustrato di libertà e di evasione, per la voce monotona dell’insegnante di latino. Eppure da quella scuola si usciva con un abito mentale del quale lo stesso autore dei Promessi Sposi è un esempio: una cultura personale, che è il sedimento dell’istruzione scolastica, rigore intellettuale e chiara consapevolezza di quel che si sa e di quello che non si sa, amore e rispetto per la conoscenza. E lo stesso Carducci delle Risorse di San Miniato non doveva essere proprio un amicone come insegnante, quando si rivolgeva alle malcapitate ragazze di campagna con un “élleno”. Lui stesso, prodotto e continuatore di quella scuola, si ispirava ad uno stile didattico ben poco informato al pedagogismo, ben poco centrato sull’alunno e i suoi presunti interessi ma sicuramente informato al rispetto per la tradizione, alla sacralità del sapere, al valore dell’autodisciplina e della fatica. La scuola, insomma, ieri come oggi, si giudica dai frutti che produce e può essere ottima anche quando viene vissuta con disagio.
Poi è venuto il primato della comunicazione e con esso facilitazione a tutti i costi, bando alla competizione, ossessione della relazione, clima amichevole e collaborativo e insieme utilità pratica, spendibilità immediata, vicinanza alla propria realtà – il territorio – di ciò che si studia: con questi ingredienti, col mito dello “star bene a scuola”, è penetrato nel sistema il virus che avrebbe finito per distruggerlo. Si è voluto dimenticare che i turbamenti dell’adolescente come l’energia emotiva e motoria del bambino stridono con i tempi e i luoghi dell’insegnamento formale. Stridono almeno quanto il rapporto fra natura e cultura, fra istinti e ragione, fra il linguaggio delle passioni e quello della logica. E non si è capito che la vera pedagogia degli interessi non è la pedagogia di ciò che interessa al bambino o all’adolescente ma di quello che è oggettivamente il suo interesse.
La scuola, in buona sostanza, è anche costrizione, interna ma anche esterna; sicuramente comporta frustrazioni ma le frustrazioni sono il sale della crescita e vanno affrontate se non si vuol favorire lo sviluppo di un ego sproporzionato rispetto alle capacità, e comporta anche il rischio della marginalità, che va affrontata senza fingere di poterla sempre prevenire ed evitare. Ma poi si creano situazioni in cui l’emarginazione è nelle cose. Inserire un ragazzo con sindrome di Down in un liceo classico, tanto segue il percorso B, corre per un attestato, non aspira al diploma di maturità, è un’idiozia di cui sono responsabili famiglia e istituzione scolastica, entrambe vittime di quel modo ludico, ricreativo, dolciastro di intendere la formazione imposto dalla sinistra, che nei fatti poi non si realizza, non si può realizzare, e che condanna una persona a fare il soprammobile, a entrare e uscire dall’aula dove sono i suoi compagni in una condizione che non attenua ma esaspera la sua diversità. E la chiamano integrazione. È lo stesso modo di intendere la formazione che per abbattere gli steccati fra istruzione superiore e formazione professionale ha distrutto la seconda, salvo poi farla rientrare dalla finestra della regione come un carrozzone clientelare. Si è dato luogo a un sistema pasticciato nel quale non solo gli studenti transitano senza difficoltà da un ordine di scuola all’altro ma gli stessi insegnanti, che hanno perso ogni specificità professionale perché si è preteso che la didattica prevalga sul sapere disciplinare e che tutti possono insegnare tutto – forse perché si è convinti che non insegnino nulla –, insegnanti arrivati alla cattedra per anzianità di attesa, che un anno insegnano scienze e geografia in prima media l’anno dopo matematica e fisica al liceo scientifico.
Il processo di smantellamento dei concorsi, in atto da almeno un trentennio e rovinosamente accelerato con la sciagurata politica renziana, è andato di pari passo con lo smottamento della formazione universitaria, naufragata nella formula tre più due. Il sistema è a suo modo coerente: se i ragazzi escono dai licei – ora sono tutti licei – ignoranti come capre gli aspiranti docenti escono dalle università senza che si sappia cosa sanno, e il sospetto è che sappiano ben poco. In questa melassa la ministra senza diploma piovuta dal sindacato dei chimici farfuglia di educazione gender, di lezioni in inglese e di altre bischerate, plaude al merito e vuole eliminare le bocciature, vuole più rigore e niente compiti a casa, vuole prolungare l’obbligo scolastico e riprende il vecchio progetto comunista di ridurre a dodici gli anni di scolarizzazione pensando ora di togliere un anno ai licei, ora alla scuola media, ora alle elementari. Una confusione mentale imbarazzante, di cui l’ultimo segno sono gli smartphone in classe.
Un vecchio modo di dire francese recita: “La critique est aisée e l’art est difficile”. La scuola com’è ridotta è un bersaglio troppo facile e se ne può dire fondatamente tutto il male possibile. Ma per non scadere in un qualunquismo da ballatoio bisogna guardare al futuro e immaginare scenari in cui si possa restituire al Paese un sistema formativo decente. Il primo e decisivo passo dovrà essere quello di toglierlo dalle mani dei partiti, liquidare le ideologie e i pregiudizi ai quali sono aggrappati, impedire che se ne occupino politicanti e affidarsi al meglio del mondo accademico col coinvolgimento dei docenti che nella scuola lavorano. Bisogna rimettere al centro la formazione, che è poi la trasmissione del sapere, il testimone della tradizione, il fil rouge che unisce passato e futuro, sulla cui base costruire le competenze di cui la società necessita, e farlo senza pregiudizi, saldando istruzione secondaria, università e mondo del lavoro. E farlo convintamente, vincendo le resistenze delle lobby accademiche, i pregiudizi verso la manualità, le pretese degli amministratori locali, il cui ruolo deve essere di supporto e non di indirizzo. E bisogna soprattutto che i docenti rivendichino il loro ruolo, che si convincano che sono loro la scuola, che la scuola non è un edificio né un’organizzazione ma è tutta risolta nel sapere di cui l’insegnamento è tramite e catalizzatore; che è loro, esclusivamente loro, la responsabilità, il merito o la colpa, del successo o del fallimento formativo, in una parola di ciò che i nostri giovani possono diventare e di quello che sarà il futuro di tutti noi.
di Alessandra Lupetti