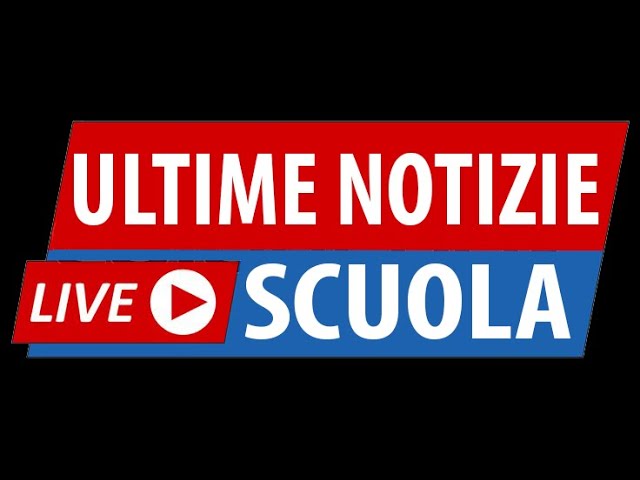Oggi tutti i docenti sono in difficoltà, dalla primaria all’università, perché i discenti impreparati sono troppi. Peggiori grattacapi assillano però forse i professori delle prime classi della scuola media di secondo grado (un tempo definite “primo superiore”). Fino a 40 anni fa, infatti, chi arrivava al liceo aveva almeno acquisito — o possedeva le conoscenze basilari per acquisire — le quattro abilità linguistiche di base: ascoltare, parlare, leggere, scrivere. Tutti, a 14 anni, nel “primo superiore”, sapevano inoltre far di conto, ossia svolgere operazioni semplici e calcoli, conoscendo l’aritmetica di base.
Quando la Scuola era “nozionistica”
Basati sugli studi di Lev Vygotskij, Maria Montessori e Jean Piaget, gli insegnamenti seguivano lo sviluppo cognitivo del bimbo nei suoi stadi. Nei primi otto anni di scuola il discente sviluppava, in modo organico e interdipendente, intelligenza, linguaggio, memoria e ragionamento. Le conoscenze fornivano al discente materiale su cui esercitare le funzioni cognitive principali: percezione, attenzione, memoria, linguaggio, funzioni esecutive (che permettono di ragionare, ottenere comportamenti orientati a uno scopo, gestire le idee, adattarsi a situazioni nuove), nonché apprendimento, pensiero, processo decisionale.
La ciclicità dei programmi di storia (aboliti dal dicastero Moratti)
Imparare a memoria le poesie, per esempio, rendeva consce le capacità mnemoniche, faceva memorizzare nuove parole, comprendendone il significato per usarle in nuovi contesti comunicativi, e arricchendo il linguaggio. Studiare tutta la Storia dalla terza alla quinta elementare, poi ristudiarla tutta in modo più approfondito nei tre anni di scuola media, e poi ancora una volta alle superiori, sviluppava ragionamento, capacità di mettere i fatti in relazione tra loro (secondo rapporti sincronici, diacronici e causali), comprensione della complessità del reale. Tutte le altre discipline contribuivano allo sviluppo di fasi e funzioni cognitive, permettendo al discente di conoscere le proprie inclinazioni e i propri gusti.
Nuove generazioni: piccolo repertorio dei danni a loro sfavore
Tutto ciò non esiste più. Persino nel primo anno di liceo classico, in tutta la Penisola, financo nel centro di Roma, Milano e Palermo, si lavora in una situazione distopica. Almeno un terzo degli alunni (alcuni dei quali tredicenni), hanno superato l’esame di terza media senza aver conseguito in modo pieno e sicuro nessuna delle abilità linguistiche di base. Non sanno esprimere a parole un concetto ascoltato: perché non sanno ascoltare con concentrazione, non conoscono molte delle parole ascoltate, non si accorgono di non aver compreso; perché non conoscono e non padroneggiano la varietà lessicale della propria lingua (per cui non sanno trovare sinonimi); perché non usano a dovere la sintassi, e ciò li rende incapaci di esprimersi in modo logico, coerente, intelligibile.
Alcuni motivi per cui non capiscono un testo scritto
Molti studenti a 15 anni ancora non sanno trovare soggetto né complemento oggetto, non distinguono attivo, riflessivo e passivo, non sanno che in italiano esistono tre persone singolari e tre plurali, non conoscono le nove parti del discorso, non sanno cosa siano tempo, modo, diatesi e persona di una forma verbale. Però i loro genitori li hanno iscritti al liceo classico, magari perché vanno male in matematica (materia comunque fondamentale al liceo classico), o perché misteriosamente “bravi” in inglese (pur non conoscendo l’italiano).
Se libertà è misconoscere l’ortografia e usare i congiuntivi come ci pare
Del resto, la lingua italiana è ormai bistrattata e violentata persino da noti giornalisti e politici popolarissimi. Pochi usano i congiuntivi al posto giusto e nel tempo giusto. Quasi fosse di moda usare il contrario del tempo e del modo corretti, infatti, è “normale” sentire il politicante di turno uscirsene con frasi tipo «Preferirei che Trump levi i dazi», anziché una più logica «Preferirei che Trump levasse i dazi (o meglio ancora togliesse, ritirasse, eliminasse). Moltissimi dicono e scrivono «Temo che non hai capito» anziché, più logicamente e cortesemente, «Temo tu non abbia capito»; «Sono sicuro che ieri avesse la giacca» anziché il corretto «Sono sicuro che ieri aveva la giacca», secondo la norma che riserva il congiuntivo alla soggettività e all’incertezza.
L’ortografia poi è un’opinione. L’italiano medio sembra ormai convinto che libertà non sia star sopra un albero o avere un’opinione, né tantomeno partecipare, ma scrivere senza convenzioni ortografiche.
È solo colpa degli smartphone?
I più incolpano di tutto ciò gli smartphone: giudizio non erroneo, certamente; molti italiani hanno ormai delegato al telefono larghe fette del proprio cervello. Tuttavia nel degrado culturale del Paese hanno giocato il ruolo maggiore lo smantellamento della Scuola e il suo definanziamento, secondo criteri di privatizzazione, aziendalizzazione, burocratizzazione, impiegatizzazione.
Oggi gli ottimi ed efficaci programmi del 1985 (ministra Falcucci) non esistono più, sostituiti e smentiti da vaghe “indicazioni” (2010, ministra Gelmini, quella degli 8,5 miliardi di tagli alla Scuola e del tunnel tra il CERN e il Gran Sasso): indicazioni che cambiano secondo il ghiribizzo della maggioranza di governo e le sue ideologie e convenienze. La storia antica si studia solo alla primaria, il medioevo solo alla media di primo grado, l’età contemporanea solo alla media di secondo grado, la geografia mai sul serio. Il far di conto è delegato alla calcolatrice, e nessuno sa la differenza tra teorema e postulato. Sin dalla primaria si fa di tutto un po’, e nulla approfonditamente. Muore una ragazza trucidata dal fidanzato? Tutti a reclamare l’“educazione sessuoaffettiva”. Incidente mortale il sabato notte? La Scuola insegni l’educazione stradale. Crollano le borse? Educazione economica a scuola!
Piccolo problema: come insegnare tutto ciò a chi non sa ascoltare, parlare, leggere, scrivere e far di conto? Qualcuno sa rispondere?