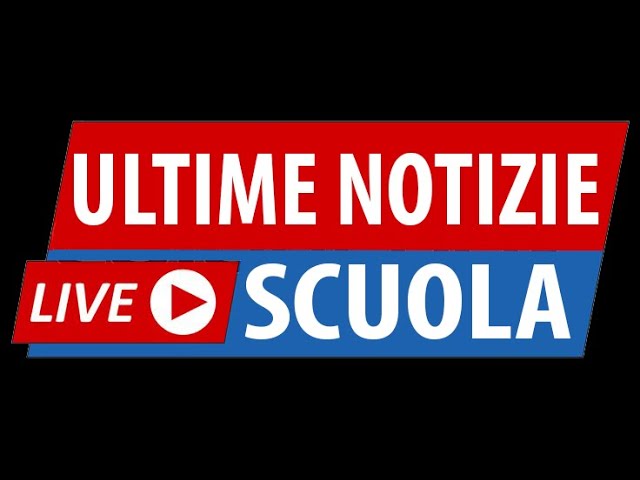Domani, 13 aprile, si va nell’ “inferno del nord”, più di 250 chilometri in bicicletta, a poco meno di 50 km orari di media, su un tracciato che definire disumano è poco.
E’ la Parigi-Roubaix, la “regina delle classiche”, che ha incoronato campioni leggendari, da Coppi a Van Steenbergen negli anni ’50, da Van Looy a Merckx negli anni ’60, Roger De Vlaeminck negli ’70, Francesco Moser con una storic tripletta (1978,79,80), senza dimenticare le imprese epiche di Johan Museeuw che nel 1998 nel passaggio nella foresta di Arenberg cadde facendo a pezzi un ginocchio (ma vinse poi la corsa nel 2000 e nel 2002).
Fino a 50-60 anni fa per alzare le braccia al cielo in segno di vittoria nel velodromo di Roubaix dove si conclude la corsa “bastavano” (si fa per dire) forza, coraggio e un po’ di buona fortuna.
Ma da un quarto di secolo nel ciclismo sono cambiate molte cose e nell’”inferno del nord” si può primeggiare solo con una preparazione scientifica: tutto va tenuto sotto controllo, dalla alimentazione (non sono più i tempi in cui si mangiava un panino al prosciutto bevendo magari un sorso di vino), al mezzo meccanico (per la Parigi-Roubaix ci vogliono biciclette leggere ma incredibilmente robuste che possano reggere le sollecitazioni della velocità e del pavè).
Per usare un gergo “scolastico” diciamo che per “fare la Roubaix” ci vogliono grandi competenze: bisogna correre come diavoli ma anche, e soprattutto, sapersi preparare fisicamente e mentalmente e saper correre; nulla può essere lasciato al caso, un minimo errore può essere fatale.
E bisogna avere alle spalle uno staff tecnico di grandi professionisti che studiano ogni particolare.
La Parigi-Roubaix, se si osserva l’altimetria, può sembrare una corsa facile: il tracciato è pressoché pianeggiante ma quello che ne fa una gara ai limiti della resistenza umana è il fondo stradale.
Alla fine degli anni ‘60, il patron della corsa Jacques Goddet era demoralizzato perché spesso la gara era poco spettacolare e si concludeva con una volata fra 10-15 corridori: i tratti in pavé, infatti, si riducevano di anno in anno scomparendo sotto 10 centimetri di asfalto.
Nel 1968 il patron chiama Jan Stablinski, ex corridore francese che conosceva molto bene il territorio e gli chiede di cercare tratti nuovi di pavé.
Stablinski sapeva della esistenza della Foresta di Arenberg perché da ragazzino aveva lavorato “sotto” lo foresta, nelle miniere di carbone che abbondano in quell’area.
Propone a Goddet di inserire questo tratto di 2.400 metri nel percorso; Goddet fa un sopralluogo e si rende conto che far passare di lì 200 corridori è una follia.
Alla fine Stablinski la spunta, convince il patron e, a partire dalla edizione del 1968, la Foresta di Arenberg diventa il simbolo della corsa.
Nel 1968 vince il giovane Eddy Merckx e inizia la leggenda dell’inferno del nord.
Ancora giorni dopo racconta di dolori quasi insopportabili alle braccia, a causa delle sollecitazioni del pavè. Ed è la stessa cosa che raccontano ogni anno tutti coloro che riescono ad arrivare fino alla fine. Si entra nel tratto in pavé mentre si corre a 50-60 km di media, il fondo è spaventoso, per lo più umido e scivoloso o addirittura fangoso se si incappa nella pioggia.
I passaggi nel pavé fangoso (ce ne sono anche altri dopo la Foresta) rendono la corsa una vera e propria gara di resistenza ad eliminazione; spesso all’arrivo a Roubaix i corridori (quelli che riescono ad arrivare senza ritirarsi durante il percorso) sono maschere di fango, quasi irriconoscibili.
La foto dell’italiano Colbrelli ricoperto di fango, vincitore nel 2021, e le immagini della edizione del 1985 che si corse quasi interamente sotto una pioggia torrenziale (non a caso dei 172 partecipanti arrivarono a Roubaix solamente in 35) sono entrate nella storia.
Vincere a Roubaix significa entrare nella leggenda e per un posto nell’albo d’ora della corsa in tanti sono pronti a sacrifici incredibili; sacrifici che, oggi, hanno a che fare anche con la scienza e con la scuola: nell’inferno del nord può trionfare solo chi si allena e chi “studia”.