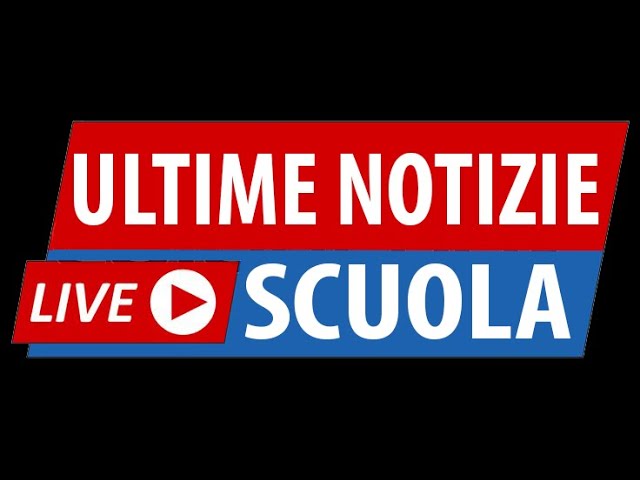La prova scritta di Italiano, che si è svolta il 12 gennaio scorso, è stata una prova comune per gli ambiti disciplinari 4 e 9.
Ai candidati è stato consentito usare solo il vocabolario d’italiano e la durata della prova è stata di otto ore.
Testi dei temi
Il candidato analizzi e commenti, a scelta, uno dei due testi qui di seguito proposti, prendendo specificamente in considerazione, secondo un ordine espositivo liberamente assunto, gli aspetti relativi a:
– forma linguistica e struttura testuale (caratteristiche lessicali, sintattiche, retoriche, fonicoritmiche e, all’occorrenza, metriche);
– genere letterario (rapporti con la tradizione, eventuali elementi di innovazione);
– contenuto informativo, rapportabile sia all’esperienza personale dell’autore sia al contesto storico e culturale, con i possibili richiami intertestuali.
Sulla base dell’analisi compiuta, il candidato esponga un’interpretazione complessiva del testo. Ipotizzi, inoltre, l’utilizzazione didattica del testo, indicando:
– la classe a cui intenderebbe proporlo;
– il percorso o il modulo in cui inserirlo;
– gli obiettivi didattici da perseguire, in relazione alle conoscenze e competenze da sviluppare negli allievi;
– le metodologie utilizzabili (tipo di attività, strumenti, metodi critici).
TESTO 1
Di pensier in pensier, di monte in monte
mi guida Amor, ch’ogni segnato calle
provo contrario a la tranquilla vita.
Se ‘n solitaria piaggia, rivo o fonte,
5 se ‘nfra duo poggi siede ombrosa valle,
ivi s’acqueta l’alma sbigottita;
e come Amor l’envita,
or ride or piange, or teme or s’assecura;
e ‘l volto che lei segue ov’ella il mena
10 si turba e rasserena
et in un esser pìcciol tempo dura;
onde a la vista uom di tal vita esperto
diria: “Questo arde, e di suo stato è incerto”.
Per alti monti e per selve aspre trovo
15 qualche riposo: ogni abitato loco
è nemico mortal de gli occhi miei.
A ciascun passo nasce un penser novo
de la mia donna, che sovente in gioco
gira ‘l tormento ch’i’ porto per lei;
20 et a pena vorrei
cangiar questo mio viver dolce amaro
ch’i’ dico: “Forse ancor ti serva Amore
ad un tempo migliore:
forse a te stesso vile, altrui se’ caro”;
25 et in questa trapasso sospirando:
“Or porebbe esser vero? or come? or quando?”
Ove porge ombra un pino alto od un colle,
talor m’arresto, e pur nel primo sasso
disegno co la mente il suo bel viso.
30 Poi ch’a me torno, trovo il petto molle
de la pietate, et allor dico: “Ahi lasso,
dove se’ giunto, et onde se’ diviso!”.
Ma mentre tener fiso
posso al primo pensier la mente vaga,
35 e mirar lei, et obliar me stesso,
sento Amor sì da presso
che del suo proprio error l’alma s’appaga:
in tante parti e sì bella la veggio,
che se l’error durasse altro non cheggio.
40 I’ l’ho più volte, or chi fia che m’il creda?
ne l’acqua chiara e sopra l’erba verde
veduto viva, e nel troncon d’un faggio,
e ‘n bianca nube sì fatta che ceda
avria ben detto che sua figlia perde
45 come stella che ‘l sol copre col raggio;
e quanto in più selvaggio
loco mi trovo e ‘n più deserto lido,
tanto più bella il mio pensier l’adombra.
Poi quando il vero sgombra
50 quel dolce error, pur lì medesmo assido
me freddo, pietra morta in pietra viva,
in guisa d’uom che pensi e pianga e scriva.
Ove d’altra montagna ombra non tocchi
verso ‘l maggiore e ‘l più espedito giogo,
55 tirar mi suol un desiderio intenso.
Indi i miei danni a misurar con gli occhi
comincio e ‘n tanto lagrimando sfogo
di dolorosa nebbia il cor condenso,
allor ch’i’ miro e penso
60 quanta aria dal bel viso mi diparte,
che sempre m’è sì presso e sì lontano;
poscia fra me pian piano:
“Che sai tu, lasso? forse in quella parte
or di tua lontananza si sospira”;
65 et in questo penser l’alma respira.
Canzone, oltra quell’alpe,
là dove il ciel è più sereno e lieto,
mi rivedrai sovr’un ruscel corrente
ove l’aura si sente
70 d’un fresco et odorifero laureto:
ivi è ‘l mio cor, e quella che ‘l m’invola;
qui veder poi l’imagine mia sola.
F. PETRARCA, Canzoniere, CXXIX
TESTO 2
Da molti anni io mi consideravo malato, ma di una malattia che faceva soffrire piuttosto gli altri che me stesso. Fu allora che conobbi la malattia “dolente”, una quantità di sensazioni fisiche sgradevoli che mi resero tanto infelice.
S’iniziarono così. Alla una di notte circa, incapace di prendere sonno, mi levai e camminai nella mite notte finché non giunsi ad un caffè di sobborgo nel quale non ero mai stato e dove perciò non avrei trovato alcun conoscente, ciò che mi era molto gradito perché volevo continuarvi una discussione con la signora Malfenti, cominciata a letto e nella quale non volevo che nessuno si frammettesse. La signora Malfenti, m’aveva fatti dei rimproveri nuovi. Diceva ch’io avevo tentato di “giocar di pedina” con le sue figliuole. Intanto se avevo tentato una cosa simile l’avevo certamente fatto con la sola Ada. Mi venivano i sudori freddi al pensare che forse in casa Malfenti oramai mi si movessero dei rimproveri simili. L’assente ha sempre torto e potevano aver approfittato della mia lontananza per associarsi ai miei danni. Nella viva luce del caffè mi difendevo meglio. Certo talvolta io avrei voluto toccare col mio piede quello di Ada ed una volta anzi m’era parso di averlo raggiunto, lei consenziente. Poi però risultò che avevo premuto il piede di legno del tavolo e quello non poteva aver parlato.
Fingevo di pigliar interesse al gioco del biliardo. Un signore, appoggiato ad una gruccia, s’avvicinò e venne a sedere proprio accanto a me. Ordinò una spremuta e poiché il cameriere aspettava anche i miei ordini, per distrazione ordinai una spremuta anche per me ad onta ch’io non possa soffrire il sapore del limone. Intanto la gruccia appoggiata al sofà su cui sedevamo, scivolò a terra ed io mi chinai a raccoglierla con un movimento quasi istintivo.
– Oh, Zeno! – fece il povero zoppo riconoscendomi nel momento in cui voleva ringraziarmi.
– Tullio! – esclamai io sorpreso e tendendogli la mano.
Eravamo stati compagni di scuola e non ci eravamo visti da molti anni. Sapevo di lui che, finite le scuole medie, era entrato in una banca, dove occupava un buon posto.
Ero tuttavia tanto distratto che bruscamente gli domandai come fosse avvenuto ch’egli aveva la gamba destra troppo corta così da aver bisogno della gruccia.
Di buonissimo umore, egli mi raccontò che sei mesi prima s’era ammalato di reumatismi che avevano finito col danneggiargli la gamba.
M’affrettai di suggerirgli molte cure. E’ il vero modo per poter simulare senza grande sforzo una viva partecipazione. Egli le aveva fatte tutte. Allora suggerii ancora:
– E perché a quest’ora non sei ancora a letto? A me non pare che ti possa far bene di esporti all’aria notturna.
Egli scherzò bonariamente: riteneva che neppure a me l’aria notturna potesse giovare e riteneva che chi non soffriva di reumatismi, finché aveva vita, poteva ancora procurarseli. Il diritto di andare a letto alle ore piccole era ammesso persino dalla costituzione austriaca. Del resto, contrariamente all’opinione generale, il caldo e il freddo non avevano a che fare coi reumatismi. Egli aveva studiata la sua malattia ed anzi non faceva altro a questo mondo che studiarne le cause e i rimedi. Più che per la cura aveva avuto bisogno di un lungo permesso dalla banca per poter approfondirsi in quello studio. Poi mi raccontò che stava facendo una cura strana. Mangiava ogni giorno una quantità enorme di limoni. Quel giorno ne aveva ingoiati una trentina, ma sperava con l’esercizio di arrivare a sopportarne anche di più. Mi confidò che i limoni secondo lui erano buoni anche per molte altre malattie. Dacché li prendeva sentiva meno fastidio per il fumare esagerato, al quale anche lui era condannato.
Io ebbi un brivido alla visione di tanto acido, ma, subito dopo, una visione un po’ più lieta della vita: i limoni non mi piacevano, ma se mi avessero data la libertà di fare quello che dovevo o volevo senz’averne danno e liberandomi da ogni altra costrizione, ne avrei ingoiati altrettanti anch’io. E’ libertà completa quella di poter fare ciò che si vuole a patto di fare anche qualche cosa che piaccia meno. La vera schiavitù è la condanna all’astensione: Tantalo e non Ercole.
Poi Tullio finse anche lui di essere ansioso di mie notizie. Io ero ben deciso di non raccontargli del mio amore infelice, ma abbisognavo di uno sfogo. Parlai con tale esagerazione dei miei mali (così li registrai e sono sicuro ch’erano lievi) che finii con l’avere le lagrime agli occhi, mentre Tullio andava sentendosi sempre meglio credendomi più malato di lui.
Mi domandò se lavoravo. Tutti in città dicevano ch’io non facevo niente ed io temevo egli avesse da invidiarmi mentre in quell’istante avevo l’assoluto bisogno di essere commiserato. Mentii! Gli raccontai che lavoravo nel mio ufficio, non molto, ma giornalmente almeno per sei ore e che poi gli affari molto imbrogliati ereditati da mio padre e da mia madre, mi davano da fare per altre sei ore.
– Dodici ore! – commentò Tullio, e con un sorriso soddisfatto, mi concedette quello che ambivo, la sua commiserazione: – Non sei mica da invidiare, tu!
La conclusione era esatta ed io ne fui tanto commosso che dovetti lottare per non lasciar trapelare le lagrime. Mi sentii più infelice che mai e, in quel morbido stato di compassione di me stesso, si capisce io sia stato esposto a delle lesioni.
Tullio s’era rimesso a parlare della sua malattia ch’era anche la sua principale distrazione. Aveva studiato l’anatomia della gamba e del piede. Mi raccontò ridendo che quando si cammina con passo rapido, il tempo in cui si svolge un passo non supera il mezzo secondo e che in quel mezzo secondo si muovevano nientemeno che cinquantaquattro muscoli. Trasecolai e subito corsi col pensiero alle mie gambe a cercarvi la macchina mostruosa. Io credo di avercela trovata. Naturalmente non riscontrai cinquantaquattro ordigni, ma una complicazione enorme che perdette il suo ordine dacché io vi ficcai la mia attenzione.
Uscii da quel caffè zoppicando e per alcuni giorni zoppicai sempre. Il camminare era per me divenuto un lavoro pesante, e anche lievemente doloroso. A quel groviglio di congegni pareva mancasse oramai l’olio e che, muovendosi, si ledessero a vicenda. Pochi giorni appresso, fui colto da un male più grave di cui dirò e che diminuì il primo. Ma ancora oggidì, che ne scrivo, se qualcuno mi guarda quando mi movo, i cinquantaquattro movimenti s’imbarazzano ed io sono in procinto di cadere.
ITALO SVEVO, La coscienza di Zeno