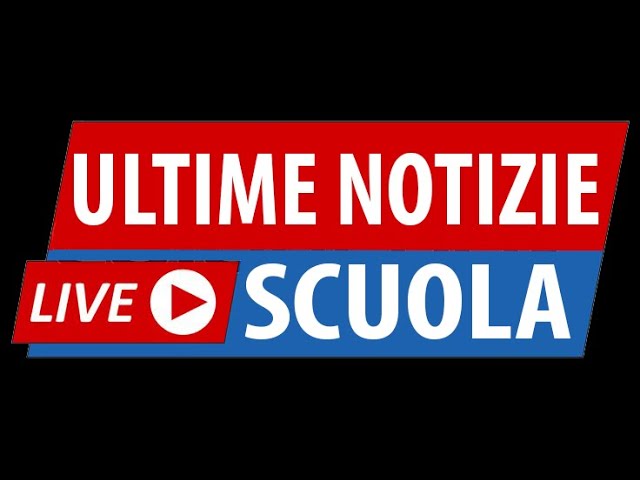L’Educazione civica è una disciplina trasversale che dal settembre 2020 è stata introdotta in tutti gli ordini e gradi scolastici, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di II grado. Nelle scuole è affidata, per effetto del decreto n. 35 del 22 giugno 2022, in contitolarità a tutti i docenti della classe: 33 le ore minime da destinare annualmente a questo insegnamento, articolate su tre tematiche, prima delle quali è Costituzione, seguita da Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale.
GUARDA TUTTE LE NOSTRE DIRETTE DI EDUCAZIONE CIVICA
Ma quale Costituzione si studierà nelle scuole italiane il prossimo anno scolastico? Difficile dirlo, visto che il testo del nostro dettato Costituzionale è attualmente in via di trasformazione, adagiato in preanestesia sul tavolo operatorio del Governo Meloni in attesa degli interventi previsti dal ddl Casellati istitutivo del premierato, approvato lo scorso 18 giugno al Senato e che passerà ora alla Camera, e dal ddl Calderoli sull’autonomia differenziata delle Regioni, approvato con il secondo e definitivo voto favorevole della Camera del 19 giugno mattina.
Ma perché a scuola si studia la Costituzione?
Perché la Costituzione è il documento normativo al vertice nella gerarchia delle fonti dell’ordinamento giuridico della nostra Repubblica, la legge al di sopra di tutte le leggi, quella che detta le regole e i principi fondamentali a cui tutte le altre devono attenersi. Se questo non accadesse, se una legge fosse in contrasto con la nostra Costituzione, uno speciale tribunale, la Corte Costituzionale, interverrebbe immediatamente ad annullarla.
”La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare” -si legge nelle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica allegate al decreto del giugno 2022- “Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.”
La conoscenza della Costituzione italiana – si afferma inoltre nelle Linee guida- è a fondamento dell’Educazione civica in quanto “criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. E questo accresciuto dalla caratteristica della trasversalità che rende il paradigma di riferimento di questo insegnamento molto più ampio di quello di qualsiasi altra disciplina, facendogli assumere la valenza di una matrice valoriale.
In quanto tale, è dunque fondamentale che la Costituzione italiana debba essere percepita come un valore condiviso da tutti i cittadini. E allora, viene da chiedersi, perché la si voglia oggi modificare in questo modo, senza prestare ascolto alle voci di chi dissente. Senza attenzione alla negoziazione, senza cercare di rendere ogni interazione positiva e fruttuosa, senza comprendere che portare avanti le proprie istanze a tutti i costi senza curare quelle degli altri non è definibile “buon governo”.
Cosa stiamo insegnando allora ai nostri studenti? Qual è il messaggio che intendiamo comunicare loro se, da un lato, professiamo e celebriamo gli alti valori e principi della Repubblica o progettiamo per loro percorsi per lo sviluppo delle competenze sociali mentre, dall’altro, esponiamo i nostri studenti a spettacoli tristi e contrastanti come il recente pestaggio alla Camera di un parlamentare solo per aver ostentato il tricolore?
Ogni docente sa, ma del resto anche tanti genitori, che la mancanza di concordanza nell’indirizzo educativo e nelle conseguenti forme di comunicazione impiegate determinano nei soggetti in formazione precisi e gravi problemi e sono in grado di scatenare reazioni disfunzionali di vario genere, reazioni che possono interessare i comportamenti, il pensiero ed anche le emozioni. Così come accade, ad esempio, tra genitori in contrasto che, ancorati alle loro posizioni, nel farsi la lotta tra di loro dimenticano i figli che coinvolgono nelle loro liti, così sta accadendo oggi nel nostro Paese. Bisogna essere consapevoli che la mancanza di coerenza dei messaggi che inviamo alle giovani generazioni con queste azioni, in particolare quando gli attori sono rappresentanti delle Istituzioni, è gravissima, e può determinare comportamenti sintomatici, che finiscono per imprigionare i nostri ragazzi in una condizione paradossale per la quale non sanno più cosa ci si aspetta da loro, né sono più in grado di distinguere i comportamenti negativi da quelli positivi. I giovani finiscono così per percepire che ciò che si dice loro non necessariamente deve corrispondere con ciò che va fatto e che qualsiasi azione, anche la più inaccettabile, può essere, tutto sommato, consentita. A scuola si insegna loro che bisogna rispettare sempre e comunque l’opinione degli altri, che è necessario saper gestire i conflitti, saper negoziare le decisioni da prendere e ad approfondire mille altre sfumature delle famose competenze sociali e delle altre life skills, mentre noi adulti, addirittura anche nei luoghi dove agiscono le alte cariche dello Stato, mostriamo loro l’immagine della peggior specie di degrado.
Le proteste contro le riforme in atto
Certo le modifiche costituzionali, seppur disciplinate per la caratteristica di rigidità della nostra Carta, sono consentite e possono essere dunque realizzate ma andrebbero fatte in modo da risultare il più possibile condivise da tutti i cittadini, cosa che in questo momento, non sta affatto accadendo.
“Ci sono (…) dei momenti nella vita di un Paese nei quali il progetto di cambiamento delle regole fondamentali assume un significato preoccupante” si legge nell’appello contro il premierato recentemente firmato da 180 costituzionalisti schierati con la senatrice a vita Liliana Segre, con la quale condividono la preoccupazione per il pericolo che si introducano contraddizioni insanabili nella nostra Carta Costituzionale. Anche lo scorso 18 giugno a piazza Santi Apostoli a Roma molte le voci politiche, sindacali e associazionistiche che si sono levate contro le riforme che il Governo Meloni sta portando avanti e in base alle quali verrà presto disegnato un nuovo volto alla nostra Costituzione e alla nostra Repubblica. Pochi articoli, capaci però di provocare conseguenze ragguardevoli sull’equilibrio tra i poteri dello Stato. Sotto attacco in particolare l’articolo 92 della Costituzione, quello che disciplina la formazione del Governo. Il progetto di riforma costituzionale prevede infatti l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio da parte dei cittadini (ma non si sa ancora con quale percentuale potrà essere eletto né se ci sarà il ballottaggio) e di un premio di maggioranza che garantirà il 55% dei seggi alle liste collegate al premier più votato.
Con queste modifiche, al Presidente della Repubblica- sottolineano le opposizioni- non competerebbe più il potere di nomina del Presidente del Consiglio su proposta del partito di maggioranza, pertanto, il suo ruolo sarebbe depotenziato, rendendolo solo un esecutore della volontà del popolo e, in caso di crisi di Governo, sarebbe privato del potere di istituire, ad esempio, un governo tecnico come è avvenuto nella storia recente con i Governi Monti e Draghi. Quanto al Parlamento, il rischio è che finisca per non rappresentare più il paese diventando una struttura di servizio del Governo: tra l’altro, legato così al capo dell’esecutivo attraverso il meccanismo del premio di maggioranza, avrebbe non poche difficoltà ad esercitare il suo potere di controllo.
La riforma dell’Autonomia differenziata
Anche la riforma dell’Autonomia differenziata, che fa paventare il rischio di una Italia spaccata in regioni di serie A e B, sta diventando un tema fortemente divisivo nel nostro Paese, con le opposizioni che hanno fortemente criticato la mancanza di serenità e serietà nel dibattimento in aula con una seduta fiume durata tutta la notte fino al voto finale a cui si è arrivati solo al mattino, come voluto dalla maggioranza.
Davanti a questa grande e discutibile volontà di correre per portare a compimento, a tutti i costi e nel più breve tempo possibile, due riforme così determinanti per il nostro Paese, non resta allora che citare le parole pronunciate in aula dalla stessa senatrice Segre: “se proprio si vuole riformare, occorre farlo con estrema attenzione. Il legislatore che si fa costituente è chiamato a cimentarsi in un’impresa ardua: elevarsi, librarsi al di sopra di tutto ciò che – per usare le parole del Leopardi – ‘dall’ultimo orizzonte il guardo esclude’. Sollevarsi dunque idealmente tanto in alto da perdere di vista l’equilibrio politico dell’oggi, le convenienze, le discipline di partito, tutto ciò che sta nella realtà contingente, per tentare di scrutare quell’ ‘Infinito’ nel quale devono collocarsi le Costituzioni. Solo da quest’altezza si potrà vedere come meglio garantire una convivenza libera e sicura ai cittadini di domani, anche in scenari ignoti e imprevedibili.” E forse è questa la lezione più adatta agli studenti delle nostre scuole.