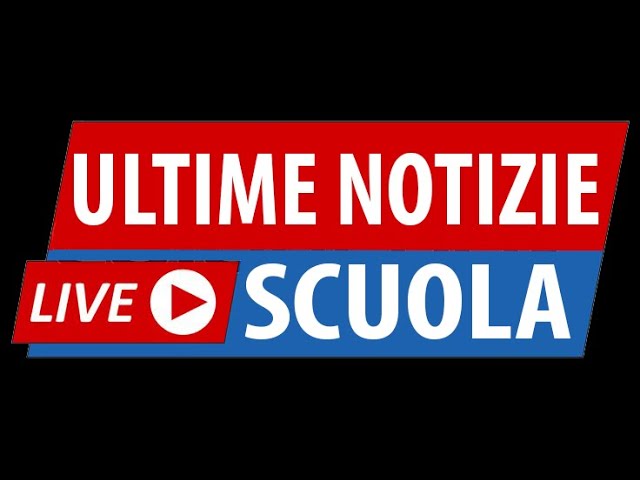Riceviamo e pubblichiamo una lettera del dirigente scolastico dell’IC Mozart di Roma Giovanni Cogliandro sull’istruzione scolastica in carcere:
“All’inizio dello scorso anno scolastico mi è stato proposto di assumere la reggenza dell’Istituto John Von Neumann di Roma. Sono tanti i docenti di questo Istituto, la cui sede principale è ubicata nel quartiere di San Basilio nella periferia est di Roma, e che ha tra le sue peculiarità quella di avere più di 500 dei suoi studenti detenuti nei quattro Istituti penitenziari di Rebibbia.
Sono Dirigente scolastico da pochi anni e avere l’opportunità di dirigere la più grande Istituzione scolastica in carcere d’Italia ha suscitato in me inquietudine e gioia. Nelle scuole che ho avuto l’opportunità di dirigere cerchiamo di perseguire un percorso di intersezione tra insegnamento, narrazione ed esperienza della filosofia, allo scopo di trovare punti di incontro tra i trascendentali pulchrum, bonum e iustum (bello, buono, giusto). In tale percorso di ricerca sulle pratiche e di formazione continua dei nostri docenti abbiamo fatto uso di argomenti tipici della tradizione filosofica classica, pensando e descrivendo la bellezza come un anelito e un bisogno primario di ciascun essere umano.
Una caratteristica peculiare di chi entra in carcere come docente è quella che non ne vuole più uscire, sembra una sorta di boutade ma non è così. Alcuni di loro, tra i quali un noto scrittore, lavorano a Rebibbia da un quarto di secolo, e hanno potuto assistere ai diversi mutamenti che hanno contraddistinto l’evoluzione dei rapporti tra amministrazione penitenziaria e Scuola, hanno potuto osservare nel tempo crescere il numero delle realtà che gravitano sul carcere.
Il carcere di Rebibbia è una realtà articolata, una cittadella a sé stante, dietro le alte mura che la cingono comprende in realtà quattro diverse istituzioni carcerarie: il Nuovo complesso è il più grande, con più di mille detenuti di tutte le tipologie, dall’alta sicurezza a coloro i quali hanno compiuti reati comuni. Quindi viene il Carcere femminile che accoglie numerose tipologie di reati, compiuti da fanciulle, madri, persone persino quasi anziane, le storie più diverse di disagio, crimine, lontananza e nostalgia. Quindi proseguendo lungo la via Bartolo Longo si incontra l’ingresso della Casa di reclusione, che accoglie i condannati in via definitiva a pene anche molto lunghe, con reati molto gravi da espiare. Alla fine della via si incontra la Terza Casa, dedicata alla custodia attenuata di chi ha scelto di partecipare a numerose iniziative formative organizzate dalla direzione.
Da preside del Von Neumann visitavo spesso le nostre aule in carcere, per incontrare docenti e detenuti e parlare con loro, perché ritengo che essere compagni di viaggio per queste persone, migliorare gli ambienti scolastici nella reclusione significa attuare al più alto livello il dettato costituzionale e il nostro compito di docenti. Sin dai primi colloqui che ho avuto con i nostri docenti di Rebibbia mi sono convinto di come anche loro credano fermamente nella necessaria anteriorità dell’ottimismo, nel bisogno di vincere l’isolamento che uccide dentro molti nostri colleghi bruciandone l’entusiasmo e trasformandoli in meri burocrati o funzionari di un apparato. Non dobbiamo lasciare che le circostanze, per quanto drammatiche, spengano la luce che ardeva negli occhi di coloro i quali si sono accostati al mondo della scuola non come a un lavoro qualsiasi, ma come una sorta di laica missione nel mondo della reclusione.
Nel quadro di questa simpatia operativa abbiamo iniziato qualche mese fa il progetto di meditazione per i detenuti. La pratica della meditazione origina dalla ricerca dell’autenticità, coniugando la consapevolezza con la scoperta della capacità illimitata di essere amorevoli nei confronti di ogni essere, che posta alla base della pratica di meditazione ha un effetto lenitivo del dolore e calmante per la mente. Sono riuscito a mettere in contatto il docente referente dell’insegnamento presso il Nuovo complesso con un valente maestro di meditazione, proveniente dalla tradizione Theravada, il nome che ha assunto la comunità dei meditanti che perseguono l’autenticità delle origini di questa pratica in estremo oriente.
“Theravada” significa letteralmente “via degli anziani”: tale nome connota un approccio alla meditazione intesa come strumento attraverso il quale esperire il reale senza filtri e incontrare uno stato di calma profonda, al di là delle dimensioni del dubbio e delle teorie razionali, muovendo dalla pratica della gentilezza amorevole verso sé stessi e verso gli altri, definita Metta in lingua Pali. Questo tipo di meditazione consiste nella ricerca della realtà così com’è, non come dovrebbe essere oppure come immaginiamo che sia. La meditazione di Metta consiste in sessioni della durata di circa un’ora di silenzio, durante le quali nutrire la presenza mentale e la sincerità nei confronti di noi stessi e delle sensazioni che proviamo. Anche le percezioni più scomode riescono a trovare così un tempo e un luogo nella nostra esistenza. Tale approccio mi è sembrato di grande aiuto per i detenuti, in particolare per quelli sottoposti a un regime precauzionale di particolare attenzione, con socialità ridotta e problematiche relazionali particolarmente acute.
Abbiamo organizzato la prima sessione del corso di meditazione la scorsa settimana in un giorno in cui non vi erano lezioni scolastiche. Sono stato molto felice della presenza di numerosi detenuti che hanno voluto da subito approfondire la pratica proposta, con tante domande al maestro, con un’interlocuzione che mi ha coinvolto insieme al docente che ci ha aiutato a organizzare l’iniziativa.
Ritengo che vi sia un profondo legame tra la Scuola e la pratica della meditazione, in quanto entrambe sono volte alla scoperta della realtà nella sua articolate complessità e all’indagine del mistero della mente, unione originaria di affettività e chiara consapevolezza. Credo che avremo modo di scoprire tanti frutti ulteriori in queste settimane, il coinvolgimento della comunità dei detenuti è stato molto al di sopra delle aspettative.
La costruzione armonica di una comunità può passare tramite la scuola, anche in carcere, ritengo che l’insegnamento delle discipline sia un esercizio di grande importanza anche semplicemente per ampliare gli orizzonti e le capacità della mente stessa, che nella meditazione diventa oggetto di osservazione e al tempo stesso soggetto attivo di pratica. Ampliare la capacità della mente con la conoscenza può andare di pari passo con il renderla capace di aprirsi a nuove modalità di percezione della bellezza e dell’armonia, capace di accettare ferite esistenziali anche profonde come quelle di chi si trova in carcere. I detenuti sono alunni esemplari in quanto riscoprono la socialità tramite la scuola, e ritengo possano essere esemplari anche come meditanti, praticando la gentilezza amorevole che da millenni si trova alla base della meditazione di antica tradizione, neutralizzando il consueto e tradizionale paternalismo dell’istituzione carceraria (ma troppo spesso anche di quella scolastica) a favore di un rapporto fondato più sull’empatia che sul timore, e quindi su un rispetto basato sulla meraviglia, e sull’attenzione per la persona”.