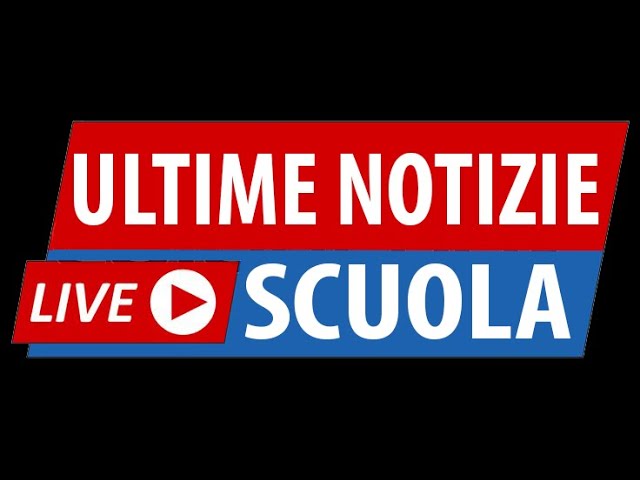Il padre di una ragazza stuprata da un branco nel 2020, all’epoca 16enne, in quello che è noto come lo “stupro di Capodanno” a Primavalle, a Roma, ha scritto una lettera indirizzata alla ragazza vittima dello stupro di Palermo, violentata da sette ragazzi lo scorso luglio.
Nel messaggio il genitore ripercorre quanto è accaduto alla propria figlia, concentrandosi sulle atroci conseguenze della violenza, senza filtri e senza indorare la pillola. Ecco il contenuto della lettera: “Cara ragazza di Palermo, sono il padre della vittima del tristemente noto “stupro di Capodanno” di Roma, e ti scrivo per appoggiarti. Hai fatto bene a reagire contro chi, sui social, ha facilmente concluso che a ‘una come te’ è ‘normale’ che capiti; e di suicidio – purtroppo – non hai parlato a sproposito. Ma ti scrivo anche per avvertirti: sei sola, perché gli altri non capiscono.
Vittima di uno stupro di gruppo, cosa vuol dire? È paradossale perché di eguaglianza fra i generi mi ero già occupato professionalmente, ricevendo persino un premio per il mio impegno a tutela delle donne: ma prima che succedesse a mia figlia, a noi – proprio a noi! – io stesso non avevo capito. La gente non capisce.
Ci sono cose che pensiamo non ci toccheranno mai, come se potessero capitare solo ad altri, ma poi irrompono e devastano la vita; e ti fanno capire cosa vuol dire veramente essere violato in tutto il tuo essere. Prendo quindi la penna, sei tu che mi hai dato il coraggio. Scrivo per spiegare anche per te a tutti – a ognuno di noi quando viene sfiorato da pensieri come ‘ma in fondo se l’è voluta’, ‘ma era provocante’, ‘ma cosa sarà mai?’ – il calvario di un essere spezzato nella sua dignità.
I nostri legali sconsigliano questa testimonianza sulla stampa perché potrebbe non essere utile al processo: non importa; noi abbiamo scelto di denunciare per mettere in guardia, non per dei vantaggi – magari economici – che sappiamo benissimo che non ci saranno mai, specie quando gli imputati dello stupro non sono attori di Hollywood; e quando comunque tutti dovrebbero capire che il prezzo da pagare a esporsi in un processo come vittima di violenza è enormemente superiore a qualsiasi vantaggio personale che ne possa derivare.
Quando si denuncia, si fa a difesa di tutti, per le figlie e i figli di tutti gli altri, in un mondo che dà anzi tutto alla vittima l’obbligo di mantenere l’anonimato. Io e mia figlia – per quanto sia il segreto di Pulcinella – dobbiamo firmarci con pseudonimi e iniziali perché è un marchio sociale indelebile essere vittime: e questa è una atroce umiliazione, il primo stupro collettivo da affrontare, e tu che ti sei esposta un po’ di più probabilmente già lo sai.
Per noi, i fatti sono questi: dall’estero eravamo tornati a Roma per le feste, e mia figlia aveva 16 anni quando la notte di Capodanno 2020, in una villetta, è stata drogata e brutalmente stuprata da almeno cinque individui. È inequivocabile, il referto ospedaliero certifica gravi lacerazioni, lividi e graffi. Ma per noi, come temo sarà anche per te, l’evidenza non basta: il gioco processuale – come sempre accade – è a dimostrare che tu, come lei, volevate esattamente quello che vi è successo.
Uno stupro è un intricato puzzle di tradimenti che si incrociano e sovrappongono, e distinguendoli vorrei raccontare a tutti cosa significano nel quotidiano della vittima e di chi le vuole bene: il tradimento di chi ti usa come un oggetto e poi il tradimento di chi vede in te, vittima che ha deciso di denunciare per proteggere tutti, una scocciatura di cui sbarazzarsi così come eri solo un contenitore usa e getta di eiaculazioni animali.
Il racconto dei tragici momenti
Vi racconto cosa provocano giorno per giorno. Racconto a te, come l’abbraccio di un altro padre, e a tutti anche per te.
Pensavi di aver lasciato tua figlia minorenne in un luogo sicuro, presso la famiglia della sua migliore amica la sera di Capodanno 2020, con la promessa che sarebbe stata una minuscola riunione protetta nel rispetto delle norme sul Covid-19: non più di quattro persone. E ti senti sicuro, ma poi arriva la prima vibrazione di inquietudine, un fatto strano, neanche una telefonata per augurare buon anno a mezzanotte.
Non immagini neanche che tua figlia non è più lì dove l’avevi lasciata. Del resto, non ha il cellulare – concludi – e poi sono solo ragazzi che pensano a divertirsi. Non lo sai che invece l’adulto a cui l’hai affidata, senza avvisarti, la porta a una ‘festa’ proibita in una zona che nemmeno conosci. E il giorno seguente non ti preoccupi troppo fino al primo pomeriggio: staranno dormendo. Ma poi inizi a telefonare e nessuno risponde, finché piomba una chiamata da una caserma dei carabinieri. E allora sai che proprio a noi è successo.
Si prende la macchina e si corre infrangendo tutti i limiti di velocità – lo ammetto, multatemi se volete – si parcheggia male – chi se ne importa – e si varca finalmente quel portone di ferro per trovare un esserino annichilito. Soggiogato, prostrato, in uno stato di stupore nel vero significato di questa parola: instupidito dall’enormità di quello che le è arrivato.
La abbracci ma senti che non c’è, non è lì, è prigioniera di una bolla tutta interna di dolore fisico e dell’anima. La lasci alle sue deposizioni, sono dolorose ma necessarie. L’unico scambio sensato che riesco ad avere con mia figlia fra una deposizione e l’altra è sulla domanda se valga la pena davvero denunciare: la incoraggio.
E colgo questa occasione per ringraziare di nuovo l’Arma dei Carabinieri – tutti quei militari, ma quanto è stato fondamentale ammettere a servire come Carabinieri anche delle donne! – per la delicatezza e l’umanità mostrata verso un essere spezzato.
Poi la porti via e cerchi di circondarla di affetto e sostegno, ma percepisci che non passano, è altrove nei suoi pensieri. E non sai che pesci pigliare, sei il primo a non capire cosa le succede dentro.
Ti chiede qualcosa di assurdo, uscire. Le dici che non è proprio il caso ma poi cedi, sapendo che tu, suo padre, non stavi riuscendo a darle qualcosa di misterioso che disperatamente cercava. Mi ci sono voluti mesi per capire – e anni a lei per razionalizzare – cosa cercava: smentire a sé stessa l’evidenza.
Dopo la droga dello stupro i ricordi sono imprecisi e cerchi in questa frammentarietà la ragione per dirti che non è possibile. Quando hai 16 anni il riflesso di te stessa che ti rinvia il tuo gruppo di amici è la cosa più importante del mondo.
E allora diventa un’urgenza incontrollabile tornare sul campo, rischiare, per cercare la conferma che avevi capito male: non è possibile, sono i miei amici! non mi hanno abbandonata da sola agli stupratori, non mi hanno filmata mentre abusavano di me, non hanno avuto come prima reazione mandarmi Whatsapp di insulto perché erano stati chiamati a deporre! Non hanno davvero riso quando qualcuno sbandierava come un trofeo la maglietta sporca del sangue delle mie lacerazioni.
Devo aver capito male, sono i miei amici! Sono ragazzi che mi vogliono bene… e cerchi di smentire l’evidenza con tutte le tue forze, rischiando di incontrarli di nuovo, ma poi la verità piomba come un martello.
Pesa la verità, soprattutto perché mia figlia è assolutamente lucida e si rende conto. E la lucidità amplifica la sofferenza. La vita va avanti: c’è la scuola, in un altro paese, ci sono gli amici diversi di un luogo diverso. Ci si fa forza e all’inizio sembra che si ritrovi la serenità, che però dura un soffio.
Arrivano le crisi di panico e l’agorafobia: mia figlia, cara ragazza, era una ragazzina normale e capisce tutto, ma non riesce a entrare in un centro commerciale; scende in strada e corre a rinchiudersi di nuovo in casa perché si sente l’oggetto di tutti gli sguardi: una sé stessa che sa benissimo come tutto questo sia irrazionale è costretta a venire a patti con una sé stessa condizionata dal trauma atroce.
Comincia l’insonnia e, da padre, si va a tentoni: innumerevoli notti passate a portarla a camminare in montagna perché tanto non dorme e sotto la luna – non c’è nessuno che ti sembra intento solo a fissarti – riesce a stare fuori. È ovvio che serve un sostegno specialistico: cominciano le terapie psicanalitiche, comportamentali, farmacologiche, e le diagnosi mai certe che si alternano. ‘Stress post traumatico’, è ovvio, ma in quali patologie si trasformi, in quali fragilità intime e sociali si evolve questo stress non è per niente scontato. Ancora meno lo sono le soluzioni: e allora si tenta un tipo di terapia e poi un’altra; e allora una ragazzina, lucida e che sa di non meritarlo, deve sperimentare se è meglio l’Efexor, il Prozac o il litio e si intossica, e oltre a tutto deve far fronte agli effetti collaterali. E ancora oggi, a tre anni di distanza, la terapia risolutiva per l’ansia di una persona consapevole non è stata trovata”.
“Dove viviamo nessuno sa della vicenda, ma rapidamente brucia un prezzo sociale da pagare: ha degli amici – diversi dai vigliacchi di Primavalle – ma nessuno capisce perché non accetta mai di andare a casa di qualcuno; si può raccontare cosa le è successo l’ultima volta che l’ha fatto? Perché – si chiedono gli amici – sulla porta del bar o della discoteca lei indietreggia sempre e poi chiama “papà” per venirla a prendere e riportarla a casa?
E poi, perché chiama il padre? Potrebbe prendere i mezzi o un taxi, e nessuno capisce perché di fronte ai luoghi ove la gente si raduna rimane imbambolata: come direbbero i suoi coetanei, ‘con l’occhio a palla’. E ‘papà’ viene, è pronto: ancora oggi, per una figlia diciannovenne che dovrebbe spiccare il volo dell’indipendenza, ha la sua costante localizzazione sul cellulare perché il rischio di paralisi da panico non è sparito.
‘Papà’ che arriva… un porto sicuro ma anche la vergogna di sembrare strana; a quell’età gli amici sono tutto.
È un disagio enorme ma deve rimanere nascosto e, come sempre succede, viene fuori per vie traverse: il profitto scolastico diventa un’altalena; come il suo peso, con oscillazioni fino a 12 chili in pochi mesi, che lasciano segni sulla pelle, contemplati con tristezza da una ragazzina che continua a chiedersi se vale qualcosa di più che un contenitore di sperma usa e getta.
E anche quanto valgono gli altri: immaginatevi il dolore quando tua figlia ti chiede se sarà mai più capace di avere fiducia in un uomo, amarlo, costruire con lui un progetto o una famiglia; se potrà vivere una vita?
Con il tempo il dolore non si attenua, anzi cresce man mano che i ricordi si fanno più precisi – era stata drogata quella maledetta sera – e man mano che raggiungi una certezza: non ci si può più illudere, ‘per tutti quelli che avevo creduto amici sono solo un problema da neutralizzare’.
Non aiutano gli articoli di stampa: più o meno a favore, ma cerchi di non farglieli vedere per risparmiarle di rivivere ogni volta quei momenti; però non è stupida, li trova e ci piange sopra, lunghe lacrime. Quello che migliora è la capacità sua e di tutti noi di nascondere il dolore agli altri.
Bisogna farsi promuovere in un liceo difficile, e ci riesce; e gli adulti devono lavorare, sorridere, stringere le mani nelle riunioni mentre gran parte dei loro pensieri sono aggrovigliati a contemplare una ferita che non si rimargina e un futuro divenuto incerto: stringi i denti, si deve portare comunque a casa uno stipendio.
Ma non si dorme, o si dorme come i cetacei con mezzo emisfero cerebrale sveglio: nei momenti più bui mia figlia aveva evocato il desiderio di farla finita, e lo sai che la notte si sente più sola; lo sai che abiti a un piano alto e che il vuoto è stato fissato da tua figlia come una tentazione. Non si dorme mai.
E non è l’unica tentazione da disinnescare. Non finiscono i medicinali, le sedute, le insonnie, e suona un nuovo campanello d’allarme: gli psicofarmaci e il loro confortante stordimento – Confortably Numb direbbero i Pink Floyd – sono un canto della sirena troppo forte davanti al logorio costante dell’anima, e si deve vigilare costantemente, giorno e notte, che un momento di buio non induca a prenderne 10 invece di 2 di pillole; non lo fa, ma il dubbio ti tortura e non basta nascondere le boccette.
E ancora si stringono i denti, si va avanti, si conquista un difficile esame di maturità – siamo a giugno 2022 – e anzi mia figlia la spunta in una competitiva ammissione a un collegio universitario di merito.
Forse la luce in fondo al tunnel? Degli studi universitari immaginati anche come la possibilità un giorno di proteggere altri da quello che è successo a lei: esita fra psichiatria e neurologia, ma poi sceglie giurisprudenza, vuole diventare Procuratore. Ma il mostro era solo assopito: la prima notte nel prestigioso Collegio, da sola in una comunità di estranei, la riassale la paura, compresa come irrazionale eppure vera, visibile, patologica; al punto che mi chiamano e alle tre del mattino parto in macchina per macinare 1000 chilometri e raccoglierla di nuovo fra le mie braccia.
Avevamo voluto esorcizzare questa ipotesi, ma ora non c’è scelta: ospedale psichiatrico. Cinque duri lunghi mesi iper-medicata, a esistere come persona fondamentalmente normale che contempla la propria nuova fragilità, fra pazienti gravi che almeno hanno il conforto di non sapere troppo di essere diversi.
Ma è forte. Sopravvive chiedendo di essere non solo una paziente ma anche una collaboratrice: qualcosa le fanno fare e impara molto.
Finalmente termina la degenza psichiatrica: dei progressi c’erano stati. Ormai l’anno universitario era perso, ma mia figlia comunque voleva andare a fondo ed esprime un desiderio: entrare in una casa protetta per donne vittime di violenza a imparare ancora, toccare con mano oltre il suo stesso vissuto. Così – ragiona lei e sono d’accordo – la mia laurea in giurisprudenza avrà un altro significato e forse un altro peso. Così sarò un buon Procuratore!
Respiriamo, c’è un po’ di motivazione, la speranza non è definitivamente spezzata. Ma poi arriva il processo: una dura deposizione che fa male. Ci vogliono settimane per ricomporre l’equilibrio, ma nulla in confronto alla crudeltà delle testimonianze degli ‘amici’.
Se la tua denuncia li espone – socialmente o legalmente – all’onta di un abbandono, alla scoperta di traffici di stupefacenti gestiti da giovani spacciatori di famiglie in vista, sei scomoda.
Meglio minimizzare il tutto, e farlo coralmente, ovvio. Così, le stesse persone che avevano calcolato come più prudente portarla – senza avvisarmi – dai Carabinieri in seguito a un’ovvia violenza, ora fanno un calcolo diverso: dichiarano che sembrava consenziente, quasi felice. Quelli accusati per gli stupefacenti da cui forse è venuta la “sigaretta bagnata” che ha privato mia figlia di consapevolezza, depongono che il suo sport abituale era avere rapporti multipli in un’unica sera. La ragazzina che aveva deciso di esporsi per proteggere tutti legge: ed è di nuovo spezzata dentro.
Mi chiede, ingenua, come possono averlo detto i suoi amici! Se non altro, come possono aver descritto i suoi presunti facili costumi, visto che non li vedeva da un anno e durante quell’anno c’era stato il lockdown, quello rigoroso del Paese in cui abitiamo? Mia figlia, purtroppo, non conosceva il verbo “calcolare” se non nel suo significato aritmetico. Questo l’ha condannata a vittima designata. La gente non capisce che gli stupratori – con la coerenza dei vigliacchi – non scelgono la ragazza più ‘provocante’, ma quella più indifesa.
“Spero tu abbia intorno meno cinismo e solitudine”
Cara ragazza, spero che tu abbia intorno meno cinismo e solitudine. Noi, ora ritentiamo; che il 2023 ci porti bene! A settembre un’altra facoltà, un’altra città, con lo strappo – e le spese – di non poter studiare lì dove ci si sentiva a casa, a Roma; che onta essere vittime!
Però ora tutto dipende da un’unica cosa: quale responso restituirà la Giustizia italiana? Quanto vale una sentenza? Quale futuro avrà la ragazzina che ora vuol fare il Procuratore per difendere le altre vittime, quale fiducia, quale significato nella vita?
Quale messaggio riceverai tu, dopo esserti esposta sui social a nome di tutte, se invece di una decisione che riconosce il vostro coraggio di denunciare e che invia un messaggio educativo per tutti, avrete una formula che, in raffinato linguaggio giurisprudenziale, significa ‘facevi meglio a ingoiare tutto e stare zitta, rompicoglioni!'”.