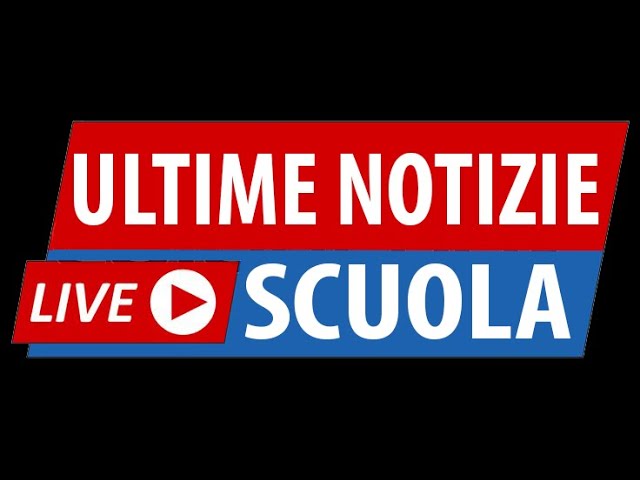Il 25 aprile è passato da poco. Anche quest’anno abbiamo dovuto sorbirci le lezioncine di chi va dicendo che la Resistenza fu poca cosa, opera di minoranze insignificanti, e che se non fosse stato per gli Alleati saremmo ancora sotto il fascismo. Il Maestro di giornalismo Vittorio Feltri, per esempio: il quale — dando ancora prova di mirabile equanimità ed obiettività storiografica — ha scritto che la Festa della Liberazione è una “sagra paesana”, un “rito stanco e pregno di bolsa retorica”, aggiungendo che chi non concorda con lui «sbaglia per ignoranza o cieca adesione al pensiero unico», e che «commemorare la Liberazione quasi fosse una nostrana pagina eroica è un’autentica mistificazione», nonché “una sceneggiata vuota di qualsiasi significato storico”. Consapevoli di non conoscere la Storia come il Maestro, non possiamo che abbeverarci alla Sua Sapienza, che bolla anche il Primo Maggio come «un’altra festa che ci ha frantumato le scatole». D’altronde, il Maestro può star tranquillo: col sempre minor spazio e importanza che la Scuola italiana riserva alla Storia, il numero dei suoi adepti non potrà che aumentare.
Ma è solo la rabbia dei nipotini degli sconfitti
Eppure — anche se all’ottimo Feltri spiace saperlo — in tutta Italia la Resistenza fu cosa davvero seria. Scuola e docenti devono farsi tutori e custodi di questa verità.
Basti pensare alle quattro giornate di Napoli. E Roma non fu da meno. La Capitale si è meritata sul campo la Medaglia d’oro al valor militare per i nove mesi nei quali fu invasa dai nazifascisti. In quei 271 giorni (tra 8 settembre 1943 e 5 giugno 1944) le azioni partigiane, gli scontri a fuoco, i sabotaggi, gli scioperi, le manifestazioni, i volantinaggi a Roma furono quasi quotidiani. I nazisti non si sentivano mai tranquilli. Lo stesso Albert Kesselring, comandante supremo delle forze naziste in Italia (quello che chiese sarcastico agli Italiani un monumento per i propri “meriti”), ammise poi che la lotta partigiana influì decisivamente sul morale delle sue truppe e sull’andamento delle operazioni.
Morirono migliaia di Romani per resistere all’oppressione. Non pochi furono gli insegnanti che parteciparono attivamente alla Resistenza.
Un Professore partigiano
Tra loro Pilo Albertelli. Romano d’adozione, ma nato a Parma nel 1907, Albertelli era sempre stato antifascista. Come suo padre, deputato socialista, la cui casa di Parma era stata distrutta dalle squadracce nere. A Roma Pilo (di idee liberali) si laureò in Lettere e filosofia, guadagnandosi la stima di Giovanni Gentile (ideologo del fascismo) in persona. Ciò non gli impedì di guidare un’organizzazione antifascista studentesca, e di essere condannato, nel 1928, a cinque anni di confino (pena poi ridotta alla vigilanza speciale per intercessione del giurista e senatore Vittorio Scialoja). Ma Pilo non si fermò. Non smise di resistere.
Dopo la laurea, diventò Docente di Storia e filosofia nel Liceo Classico Statale “Umberto I” (oggi “Pilo Albertelli”) nel centro di Roma. Grecista raffinato ed acuto filosofo, pubblicò importanti studi su Parmenide e sulla scuola eleatica, tuttora validi. Suoi modelli di pensiero erano Benedetto Croce e Piero Gobetti.
Benché fine intellettuale, non temette di sporcarsi il vestito
Cosa avrà pensato questo fine studioso di fronte al consolidarsi del regime, al crescer del suo consenso tra le masse popolari, all’ignavia di tanti suoi colleghi? Che dolore avrà provato, vedendo la civiltà italiana avvilita dalle feroci repressioni fasciste in Libia, dalla brutale aggressione all’Etiopia, dalle leggi razziali? Difficile immaginare che abbia rinunciato a trasmettere idee ai propri alunni, a far nascere in loro capacità di discernimento e desiderio di scelte etiche, in contrasto col quadro deprimente in cui vivevano.
Avrà sofferto, il Professor Pilo Albertelli, vedendo la cura con cui molti colleghi lo evitavano. Quei colleghi, ossequiosi col Potere (cui dovevano lo stipendio), evitavano lui per paura d’esser coinvolti e considerati suoi amici, e per l’imbarazzo di doversi commisurare con la sua dignità di persona retta e pulita. Tuttavia il Professore traeva alimento dall’attenzione e dall’affetto degli studenti, cui faceva scoprire, tramite la filosofia, le manipolazioni e gli inganni celati dietro la rutilante propaganda fascista. Infatti, nessuno studente lo tradì.
Coerenza tra pensiero e azione
Albertelli comunque non si fermò al pensiero. Preferì i fatti. Giunse il 1942: in piena guerra, mentre lavorava, il Professor Albertelli contribuiva alla fondazione clandestina del Partito d’Azione. Dal 10 settembre 1943 diede il proprio fondamentale apporto alla creazione delle Brigate partigiane “Giustizia e Libertà” (di ispirazione liberal-socialista), entrando poi nel comitato militare del Corpo Volontari della Libertà (CVL).
La prima azione di lotta armata partigiana a Roma lo vide protagonista: un’azione pericolosa, e dal significato simbolico dirompente. Fu il Professore stesso a collocare (con Giovanni Ricci) un ordigno esplosivo improvvisato nella caserma della MVSN ai Parioli. La MVSN (“Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale”) era un corpo di “polizia civile” militarizzata: in pratica, l’istituzionalizzazione delle squadracce di camicie nere che avevano terrorizzato l’Italia nei primi anni ‘20. “Guardia armata della rivoluzione” la definiva il regime, “al servizio di Dio e della Patria”. La miccia, breve e rapida, la accese Albertelli in persona. Era il 20 settembre 1943; data allusiva, nella Capitale d’Italia.
Qualcuno, però, trovò conveniente denunciarlo. Albertelli fu arrestato il 1° marzo 1944, e affidato alle grinfie di un branco di criminali sadici al servizio delle SS, con sede in Via Principe Amedeo, nella Pensione “Oltremare”: la “Banda Koch”. Quei maniaci depravati lo torturarono fino a ridurlo in fin di vita: ma il Professore non tradì. Non fece un nome. Accettò di pagare con la vita.
Resistere per esistere
Erano tempi molto peggiori di quelli odierni. Anche allora molti insegnanti cedevano alla depressione, si piegavano per quieto sopravvivere (o per opportunismo), cercando di non prendere posizione e di viver tranquilli nella quotidiana paura. Molti altri, però, capivano che un docente, per essere tale, deve sostanziare il proprio ruolo di educatore con l’esempio, e che non si può insegnare senza almeno sforzarsi di esser coerenti coi propri insegnamenti. Rischiavano il posto di lavoro, il carcere, la salute, la vita. Si esponevano, insomma, a danni ben maggiori della perdita di 80 euro per uno sciopero. Erano minoranza, forse: ma sono le minoranze attive che cambiano la Storia; non le maggioranze acquiescenti e tacite. Il loro esempio è ossigeno per chi crede ancora nella bellezza, nella giustizia, nella verità, ed è disposto a mettersi in gioco per esse. Checché ne dica il Maestro di giornalismo di cui sopra.