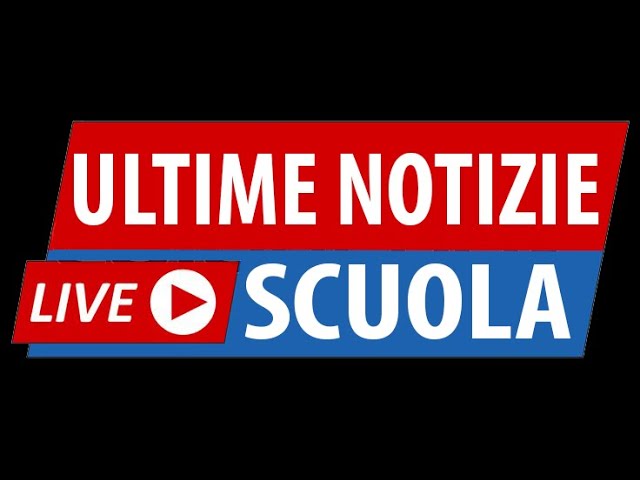Con questo articolo ritorna la rubrica Scienze per la Scuola, inaugurata ad aprile scorso, attraverso la quale si vogliono proporre, periodicamente, articoli che offrano agli insegnanti contributi scientifici a supporto del loro lavoro didattico-pedagogico di ogni giorno. L’obiettivo è quello di mettere sempre più in collegamento questi due mondi, scuola e scienze, in teoria e negli auspici così vicini, ma forse ancora troppo lontani nella realtà.
Alla radice della violenza di genere, che può essere di tipo fisico, ma anche sessuale, linguistico, psicologico o economico, c’è un nascosto virus che permea abitudini mentali e schemi di pensiero: in una parola, la cultura (o sordidi anfratti della cultura) in cui una persona si riconosce. Una idea-virus forse riassumibile in espressioni come cultura del possesso o del potere o comunque in espressioni che trasmettano l’idea di una donna naturalmente succube dell’uomo, oggetto del suo controllo. Con una istintiva e obliqua opposizione, quasi mai meditata, al trend storico dell’emancipazione femminile. Quella che è forse la più grande rivoluzione della modernità.
Quando questo virus culturale, che è trasversale a fasce geografiche, sociali o economiche della popolazione, si innesta all’interno di un sistema psicologico personale estremamente immaturo, si può arrivare alla deflagrazione tipica delle situazioni più estreme. E i femminicidi ne costituiscono una drammatica espressione. Ma, al netto dei casi di patologia psicologica, resta il problema della forza atavica di questa idea dell’uomo dominus: un’idea trasversale nello spazio e perdurante nel tempo. Questa idea fa parte della potente categoria mentale delle credenze e convincimenti impliciti, cioè al riparo dalla luce dell’autoconsapevolezza. Cose che infiltrano poi, subdolamente, anche una serie di concetti collegati a quell’idea, come quello di donna, di giustizia, di diritto, di amore.
Proprio perché implicita, questa idea viene fuori difficilmente per mezzo di un’autoriflessione personale. Più spesso, emerge invece attraverso comportamenti e concomitanze incidentali che assumono un ruolo rivelatore: ad esempio, attraverso il linguaggio usato, certe battute di spirito, i testi di una canzone, la scelta delle immagini in una pubblicità, certe convenzioni. O attraverso l’attivarsi di specifiche dinamiche emotive.
Occorre però prendere coscienza che combattere contro mappe cognitive ed emotive di questo tipo, e così profondamente strutturate nel percorso storico dell’umanità, significa combattere contro un nemico per certi versi invisibile, talmente sfuggente da annidarsi anche lì dove nemmeno ci si sognerebbe di cercarlo. L’invisibilità di questo pensiero si manifesta ad esempio nel dato di fatto, rilevato più volte dagli operatori dei centri antiviolenza o da alcuni magistrati, che molte donne non arrivano neanche ad etichettare come forme di violenza ciò che hanno subito.
Linda Laura Sabbadini, direttrice del dipartimento di statistiche sociali e ambientali dell’Istat, è stata la ricercatrice che ha approntato una metodologia di analisi statistica da cui è emerso, nel 2006, il bubbone della violenza di genere nella nostra società e che non viene quasi mai denunciata (nel 96,3% dei casi). L’indagine rivelava, già nel 2006, che c’erano più di 6 milioni di donne in Italia che avevano subito violenza fisica o sessuale (e che arrivavano a 10 milioni contando anche quella psicologica).
Sabbadini ha affermato che si è dovuto lavorare molto innanzitutto sulle domande da porre alle donne, per fare emergere il problema. Si è dovuto infatti riformulare tali domande andando dall’astratto al concreto: chiedendo loro non se avessero subito violenza, ma se avessero subito degli schiaffi, forti spintoni, o perfino calci dai loro compagni. A quel punto, le stesse donne intervistate, che prima avevano riferito di non aver subito violenza, dicevano che, sì, quelli li avevano ricevuti.
Se la stessa vittima, quasi sempre per questi retaggi culturali, può arrivare a non rendersi conto, almeno a livello di consapevolezza semantica, della violenza che sta subendo (indicizzandola come nervosismo, esasperazione, impulsività o brutto carattere o folle amore del compagno), figuriamoci quanto sia più probabile (e certamente più comodo) questo mancato riconoscimento, innanzitutto ai propri stessi occhi, da parte dell’uomo violento.
Questo modello mentale (quello della cultura del possesso della donna e del misconoscimento della sua emancipazione) è duro a morire in tanti uomini (e, c’è da temere, anche in diverse donne) perché ha permeato la nostra cultura per millenni e possiede ancora una potente forza inerziale, resa ancora più efficace da questo difetto di immediata riconoscibilità.
Quando si sente dire frasi come “Il compagno è stato violento e crudele, ma era disperato per essere stato lasciato dalla persona che amava; gli è crollato il mondo addosso”, è evidente che siamo davanti all’emersione (inconsapevole) del pernicioso modello mentale in questione. Si pensa sinceramente che quell’atto sia ignobile, ma il sistema di attenuanti che vengono rapidamente in mente (è questo il punto) è rivelatore: prefigura non raramente una qualche sottesa idea di un legittimo diritto violato ai danni di quello che, con significativa schizofrenia di giudizio, è comunque riconosciuto come carnefice. Ecco: le attenuanti riconosciute soggettivamente al carnefice in questi casi possono essere un’ottima fonte di rivelazione (e analisi) dell’idea-virus che ci abita, spesso a nostra insaputa.
E’ chiaro che qui la scuola gioca un ruolo fondamentale, proprio perché siamo alle prese con schemi di pensiero solidamente incardinati in una certa cultura e sui quali occorre quindi lavorare fin dalla più tenera età. Ogni disciplina può fare la propria parte per educare le nuove generazioni in questa direzione, per contrastare quella che in tanti definiscono ormai una vera e propria strisciante guerra dei sessi. Una direzione certamente non semplice per la scuola, ma che sembra più che mai segnata e dettata dalla storia.
V.: “La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia”. Indagine ISTAT (Anno 2006)
“La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia”. Indagine ISTAT (Anno 2014)
Il presente articolo fa parte della rubrica Scienze per la Scuola, curata da Giovanni Morello. Vedi anche gli altri articoli pubblicati:
Esami veri ed esami farsa. La questione dei riti di passaggio – Scienze per la scuola